|

I
CASTELLI LUCANI
Molte le curiosita' di
questa regione la cui storia e' raccontata anche
nei suoi numerosi castelli.
Molte le denominazioni e quindi molti i
manieri; dei piu' sono rimasti soltanto ruderi, o torri isolate. In questo
capitolo vogliamo suggerire la visita di quelli meglio conservati e piu'
interessanti.
PROVINCIA DI POTENZA
Avigliano-Lagopesole: se il castello di Melfi e' il piu'
noto, Castel Lagopesole e' il piu' bello, magico e misterioso ove aleggia
ancora lo spirito del grande Federico II. E' l'ultimo dei castelli edificati
dall'Imperatore svevo, fra il 1242 e ili 250, quando mori'. Andando da Potenza
verso il Vulture appare e scompare alla vista alto e solitario su di una
radura, splendido se illuminato dal sole.
La sua pianta rettangolare lo allontana pero' dall'esagono, figura classica
adottata nel periodo di Federico II. E' diviso in due parti, una raccolta
intorno al cortile d'onore di rappresentanza; l'altra piu' legata ai fatti
d'arme, il mastio al centro. Per la sua posizione, sulla strada per la Puglia,
costituiva una sosta e un incremento alla caccia, grande passione del re.
Probabilmente, esisteva gia' prima di Federico II, visto che qui si
riconciliarono Papa Innocenze II con l'abate Rinaldo di Montecassino, presente
l'Imperatore Lotario II di Sassonia, al tempo della guerra contro Buggero il
Normanno.
Nel 1268 e nel 1294 vi soggiorno' (e vi fece restauri) Carlo I d'Angio'. Nel
1416 passo' alla famiglia Caracciolo, insieme a Melfi. Nel 1531 Carlo V lo dono'
ai Doria. E' stato museo provvisorio dei reperti salvati dal terremoto e per
piu' di un anno la sua mole rossiccia in bugnato calcareo ha ospitato nelle
varie stanze quadri e sculture, arte popolare e aulica, che lo hanno reso una
testimonianza fondamentale dell'anima e della storia lucane.
Brienza: l'abitato e' dominato dai resti imponenti del
castello angioino rifatto nel 1571. Oltre al mastio cilindrico vi e' una
semitorre circolare a meta' della cortina muraria, con funzioni maggiormente
difensive. Appare comunque piuttosto rovinato dopo il terremoto dell'80.
Genzano di Lucania: in paese vi e' il castello settecentesco
con primo impianto angioino, oggi sede del Municipio; nei dintorni, castello
di Monteserico (542 m) ove i Bizantini furono sconfitti dai Normanni nel 1041.
Fu ampliato dagli Svevi: si nota ancora l'architettura con volta a botte. Nei
sotterranei grotte preistoriche, prime abitazioni dei monaci basiliani.
Lavello: il castello fu costruito in epoca sveva ma venne
rifatto nel 1600. Oggi vi ha sede il Municipio e un piccolo Antiquarium
civico.
Melfi: e' senz'altro il castello piu' noto della regione.
Eretto dai Normanni, venne ampliato dagli Svevi e dagli Angioini. Qui nel 1231
Federico di Svevia promulgo' le Constitutiones Augustales del Regno di
Sicilia. L'intervento angioino e' caratterizzato dalla cortina esterna con
torri quadrate e poligonali, opera di Riccardo da Foggia. Oggi si nota
l'assenza di torri cilindriche e la forma della pianta (un quadrilatero
irregolare) e' stata condizionata dalla morfologia del terreno.
Nel secolo XVI passo' ai Doria che lo trasformarono soprattutto nel corpo
centrale. La parte scuderie, stallaggio e mortorio, angioina, immette alla
Sala del Trono e al sottostante Salone degli Armigeri. Oggi vi ha sede il
Museo nazionale del Melfese.
Moliterno: oltre ai notevoli resti del castello, molto vivace
appare il centro antico che lo circonda. Il mastio all'interno delle mura e'
di epoca tardo longobarda; le due torri forse sono successive.
Muro Lucano: purtroppo dopo il terremoto dell'80, il castello
resta soltanto un ricordo di pietre e di ruderi.
Oppido Lucano: anche qui consistenti resti di un castello a
pianta irregolare inserito benissimo in un intrico di vicoli e angiporti.
Palazzo San Gervasio: il suo stesso nome ha origine dalla
domus di caccia di Federico II. Il castello, appunto, e' stato rimaneggiato ma
vi si distingue il suo stile con due torrioni a punta quadrata, quattro bifore
e una trifora-loggiato. Di fianco un palazzotto dello stesso periodo per le
scuderie.
Pietragalla: come per Marsiconuovo nominiamo qui il Palazzo
Ducale degli Acquaviva perche' notevole. E' del '400, restaurato nel 1700.
Senise: il castello e' del XIII secolo e lo si nota dalle
torri e dai merli. E' stato pero' ristrutturato nel 1400.
Venosa: molto imponente e in ottimo stato il castello
aragonese che introduce alla cittadina, a guardia di una piazza di
interessante impianto urbanistico. Fu eretto nel 1470 da Pirro del Balzo che
conservo' i caratteri difensivi del periodo angioino. Ricorda molto
Castelnuovo (o Maschio angioino) di Napoli. Nelle torri erano sistemate le
prigioni di cui ci restano iscrizioni alle pareti. Circondato da un profondo
fossato, ha anche un lungo ponte di accesso.
Molte le curiosita' di questa
regione la cui storia e' raccontata anche nei suoi numerosi castelli.
PROVINCIA DI MATERA
Bernalda: il castello del 1470 appare un po' tozzo ma tipico
di quell'epoca. A erigerlo fu Bernardino de Bernardo - fondatore del paese -
segretario della corte aragonese che con il castello fortificato dette il via
alla costruzione di Bernalda che da lui prese il nome. Alcune fonti, comunque,
dicono che il castello esisteva gia' con i Normanni, in piu' la base
tronco-conica di una delle torri cilindriche induce a pensare che la
costruzione sia invece angioina. In ogni caso esistono rimaneggiamenti e
stratificazioni.
Ferrandina: castello di Uggiano, fortificazione militare
bizantina risalente ai primi del IX secolo, preso e ricostruito dai Normanni
agli inizi dell'XI secolo, divenne residenza signorile per la trasformazione
operata da Jacopus de Astiliano nella prima meta' del XIV secolo; fu distrutto
dal terremoto nel 1456.
Irsina: il vecchio castello di Montepeloso (antico nome) era
d'impianto normanno rimaneggiato in seguito da Federico di Svevia nel 1228.
Oggi appare nell'aspetto cinquecentesco, diventato convento di S. Francesco.
La cripta e' stata ricavata dal fondo di una torre quadrangolare del castello
del 1100.
Matera: verso i primi del '500 fu costruito il castello
Tramontano dal nome del feudatario a cui la citta' era stata data da
Ferdinando II. L'edificio domina la valle del fiume Bradano e presenta due
torri cilindriche intervallate da un enorme torrione circolare. La forma e'
abbastanza rara all'epoca e cio' dipende dal fatto che il feudatario imito' il
Maschio angioino di Napoli, inizialmente, ma non fece in tempo a finirlo poiche'
fu ucciso, probabilmente perche', proprietario della salina di Manfredonia e
di un deposito cerealicolo a Barletta, dava ombra ai ricchi locali. Il curioso
e' che intorno al castello incompiuto oggi si stendono i nuovi rioni
residenziali.
Miglionico: appare definito, il paese, dalla gran mole del
castello. Detto del “Malconsiglio”, vi congiurarono i baroni contro il re
di Napoli Ferdinando I d'Aragona nel 1481. Fu anche feudo di Ettore Fieramosca.
Fu costruito dai Normanni nell'XI secolo e si scorge il loro stile nelle torri
quadrate laterali; le torri cilindriche sono piu' tarde. All'interno appare
rimaneggiato e diviso ma il fascino di questo castello possente, stabile e
minaccioso, resta immutato.
Nova Siri: allo scalo, vicino al mare, bella la Torre
Bollita, 1300.
San Mauro Forte: resta soltanto il mastio normanno
rimaneggiato nel '400 e la torre con beccatelli a triplice mensola, una delle
piu' conservate della regione.
Scanzano Ionico: piccolo ma davvero diverso dagli altri
paesi, conserva il centro antico raccolto attorno al “Palazzaccio”,
edificio padronale del 700, considerato dagli abitanti il castello.
Tricarico: sola superstite e' la torre, altissima (30 metri e
piu') e cilindrica. Essa riporta ai caratteri morfologici dell'abitato
difensivo tipico degli Angioini.
Valsinni: e concludiamo con il piu' dolce e il piu' poetico
dei castelli. Lo si vede da ogni lato e da molti chilometri di distanza. Oggi
appare di aspetto aragonese e la sua proprietaria piu' illustre e' stata la
poetessa Isabella Morra di Valsinni (1520-1545). Ma si sa che esisteva gia' in
epoca medievale.
STORIE
E LEGGENDE DEI CASTELLI IN PROVINCIA DI MATERA
Provincia di Matera:
2.1
Il Castello di Grottole
2.2 Il Castello di
Irsina
2.3
Il Castello di Matera
2.4
Il Castello di Bernalda
2.5
Il Castello di Miglionico
2.6
La Torre di S.Mauro Forte
2.7
Il Castello di Stigliano
2.8
Il Castello di Tricarico
2.9
Il Castello di Valsinni
2.10
Il Castello di Uggiano
2.11 Il Castello di
Craco
2.12
Il Castello di Torre di Mare a Metaponto
2.13 Il Castello di
Tursi
2.14 Il
Castello di Montescaglioso
2.15
Il Castello di Policoro
2.16
Il Castello di Cirigliano
2.17
Il Castello di Scanzano
2.18
Il Castello di Pomarico
2.19
Il Castello di Calciano
2.20
Il Castello di Garaguso
2.21
Il Castello di Ferrandina
2.22
Il Castello di Colobraro
2.23
Il Castello di Oliveto Lucano
2.24
Il Castello di Nova Siri
2.25
Il Castello di Aliano
2.26 Il Castello
di Rotondella
2.27
Il Castello di Girifalco
2.28
Il Castello di Picciano
2.29
Il Castello di Recoleta
2.30
Il Castello di Gannano
2.31
Il Castello di Torre Spagnola
2.32
Il Castello di S. Basilio
2.33
Il Castello di S.M. del Vetrano
2.34
Il Castello di S. Salvatore
2.35
Il Castello di Caputo
2.36
Il Castello di Santo Spirito
2.37
Il Castello di San Martino
2.38
Il Castello di Parco dei Monaci
2.39
Il Castello di Monteleone
2.40
Il Castello di Monacelle
2.41
Il Castello di Santa Candida
2.42
Il Castello di Venusio
2.43
Il Castello di S. Francesco
2.44
Il Castello di Isca del Ponte
2.45
Il Castello di Selva San Liogi
2.46
Il Castello di Monte Acuto
2.47
Il Castello di Pantano
2.48
Il Castello di Gattini
2.49
Il Castello di Gems
2.50
Il Castello di Tremiti di Sopra
2.51
Il Castello di Girogica
2.52
Il Castello di Pizzo Corvo
STORIE E LEGGENDE DEI CASTELLI IN PROVINCIA DI POTENZA

Il castello di Lagopesole (PZ)
Il castello di Lagopesole sorge su una collinetta alla quota di 820 m sul livello del mare, posta sullo spartiacque tra i fiumi Ofanto e Bradano. Il borgo di Lagopesole, che si apre a ventaglio sul fianco rivolto a sud della suddetta collina, fa parte del comune di Avigliano (PZ).
Il castello, a pianta rettangolare, presenta due cortili: il minore, di epoca alto normanna, conserva al centro un mastio (donjon) quadrato che curiosamente è fuori asse rispetto al resto della struttura, che indica che molto probabilmente è anteriore alla costruzione del castello antistante. La torre (il Donjon) è caratterizzato da una muratura bugnata nella parte superiore, fatto tipico per l’architettura sveva, in questo caso l’edificio è molto probabilmente risalente all’epoca di Enrico VI di Svevia. Anche le due teste (un uomo e una donna) scolpiti li fanno pensare ai castelli dei Svevi nell’Alsazia, costruiti nella fine del XII secolo.
È da notare anche la compattezza tipica di queste strutture: solo tre feritoie, infatti, si aprono sulle pareti sud, est ed ovest, mentre su quella nord c’è l’unico possibile accesso, a circa quattro metri dalla quota di calpestio, cui corrispondono due grandi mensole in pietra (probabili basi d’appoggio per un passaggio mobile) ed altre due mensole figurate nella parte superiore. Il cortile maggiore, risalente all’ampliamento iniziato da Federico II di Svevia nel 1242 sui resti di precedenti costruzioni normanno-sveve (a scopo militare) ed angioine (a scopo residenziale), include una vasta cisterna ed una grande cappella.
Proprio quest’ultima è una peculiarità che contraddistingue questo castello da tutti gli altri attribuiti a Federico II di Svevia; infatti la presenza, al suo interno, di una chiesa vera e propria e non di una semplice cappellina è l’unico esempio tra tutti quelli risalenti a quell’epoca imperiale. La chiesa, in un austero stile romanico che i restauri effettuati negli ultimi anni del XX secolo hanno portato alla luce e consegnato ai posteri nel suo originario splendore, ha un’abside semi circolare e l’entrata decorata con il motivo dei denti di sega, tipico dell’età angioina.
Il castello fu dimora ideale di Manfredi, figlio di Federico II, che privilegiò Lagopesole alla capitale del suo regno, Palermo. Lo stato presente del castello, restaurato negli anni novanta, riflette le modifiche apportate al progetto normanno-svevo da Carlo I d’Angiò, che utilizzò il castello soprattutto come prigione di lusso (vi rinchiuse fino alla morte Elena Angelo Comneno di Epiro, moglie di Manfredi, e i suoi figli). Nell’Ottocento il castello fu rifugio dei briganti capeggiati da Carmine Crocco, che il 7 aprile 1861 lo occupò con 400 uomini. Il castello, oggi proprietà demaniale e sede del Corpo Forestale dello Stato, ospita numerose attività culturali e dal 2000 accoglie l’Antiquarium realizzato con i materiali medievali rinvenuti durante le campagne di scavo effettuate nel cortile minore.
Il castello di Lagopesole è considerato, a buon diritto, una delle fortezze più antiche ed imponenti della Basilicata.
Esso è raggiungibile dalla superstrada che da Potenza conduce a, ed è visibile proprio da tutta la "Valle di Vitalba", la terra conosciuta già nell’antichità per essere stata sede di un lago riempitosi migliaia di anni fa a seguito dell’attività vulcanica del Vulture e che ha fatto sviluppare una serie di insediamenti già in periodo longobardo.
Una tradizione riportata da Giustino Fortunato tramanda che "un Andronico bizantino, il quale mandato da Leonida re di Sparta, nella metà dell’ottavo secolo, a capo di un'orda di musulmani", avesse fondato una città che per le ricchezze possedute era conosciuta con il nome di Fiorenzuola; ebbene, quel luogo era proprio Lagopesole.
Non tutto ciò che si è detto è falso, se si pensa che altre storie riportano che tra il 925 e il 929 vi furono, nella zona, numerose incursioni musulmane; in una valle detta degli Schiavoni, nelle vicinanze del castello fu trovata nel secolo scorso una corniola con caratteri arabi, che recitava: "La mia buona speranza è in Dio, nel profeta avventurato, nel tutore che conosce la nuova via, in Husain ed Asan".
La prima notizia risale al 1129, quando Ruggero, dopo aver sedato una rivolta in Puglia, si diresse verso un "castello, che in parlata locale si chiama Lagopesole", e l’altra del 1137, data in cui il pontefice Innocenzo II si incontra con l'imperatore Lotario III "vicino le sorgenti di Lago Pesole, per quasi trenta giorni".
Antico e ben conservato, questo castello è uno dei più maestosi degli edifici militari eretti da Federico II.
Ha una forma prevalentemente quadrangolare, con delle piccole torri ad angolo di rinforzo, e si staglia sulla rupe come una scultura perfetta dai portali a sesto acuto e graziose bifore all’interno.
Il castello ebbe massima importanza, poiché fu soprattutto sede dell’amministrazione degli imperatori svevi e fu luogo di diletto anche per gli Angioini.
Nel 1255, Manfredi, figlio naturale di Federico II, appena ventitreenne, si ammalò di malaria nel castello di Falazzo. Per guarire dagli affanni della malattia, venne a sapere che nel castello di Lagopesole l’aria era salubre e d’estate si poteva godere di un meraviglioso panorama. Proprio a Lagopesole, durante la convalescenza, Manfredi tradusse dall’ebraico in latino un libro di Aristotele, il De pomo sive de morte, premettendovi un magnifico prologo, e forse mise mano all’immenso patrimonio letterario del padre Federico II ricostruendo il De Arte venandi cum avibus. Dalle logge Manfredi controllava le non lontane Murge, spostandosi a volte a Palazzo San Gervasio, Guaragnone, Spinazzola Gravina e Irsina, ripercorrendo così la tradizione paterna del dominio sul territorio.
Il castello, dopo la parentesi non secondaria degli Angioini, fu poi donato dalla regina Giovanna II a Covella Ruffo, sua nipote, duchessa di Sessa e contessa di Squillace, Montalto ed Alife, con l'indicazione: "Nemus et territorium Sancti Gervasii cum palatio seu domo situ in provincia Basilicate".
Di questa Covella, che la tradizione vuole sia stata bellissima ed avventuriera, si raccontano diversi episodi e stravaganze; tra i tanti, quello del cosiddetto "periodo del basso e grasso" durante il quale Covella non si faceva amare che da uomini bassi e grassi, o l’altro detto "dei medici", perché Covella voleva essere costantemente sotto il controllo dei medici, essendo in ansia per la sua bellezza; o l’altro ancora "della noia", durante il quale passava le sue giornate appollaiata sugli alberi del bosco che circondava il castello.
E comunque certo che fosse un’intrigante; valga per tutti l’esempio dell’odio a morte verso l’Orsini duca di Matera.
Nel 1507 il castello venne dato a Carlo Maria Caracciolo e quindi devoluto "per diritto di fellonia" al fisco, dal quale lo acquistò Ferrante di Alarçon.
Pervenne, infine al marchese di Genzano, De Marinis, ma poi, dopo l’assunzione al Demanio, passò al Corpo Forestale, che è attuale proprietario.

il castello di Melfi (PZ)
Il castello di Melfi è un monumento della Basilicata di proprietà dello Stato Italiano, tra i più importanti castelli medievali del sud Italia. La sua fondazione, almeno dagli elementi ancora visibili, risale al periodo normanno e ha subito notevoli modifiche nel corso del tempo, soprattutto in epoca angioina e aragonese.
L’origine del castello di Melfi risale alla fine XI secolo ad opera dei normanni, sorto in posizione strategica che funge da punto di passaggio tra Campania e Puglia. Il suo collocamento era indispensabile per difendersi dagli attacchi esterni e come rifugio per gli alleati. La struttura fu luogo di avvenimenti “storici” durante l’era normanna.
A Melfi, sede della Contea di Puglia, si tennero cinque concili ecumenici, organizzati da cinque diversi Pontefici tra il 1059 e il 1137. Nell’estate del 1059, Niccolò II soggiornò nella rocca fortificata e fu al centro di importanti avvenimenti: in giugno stipulò il Trattato di Melfi, poi, dal 3 agosto al 25 agosto celebrò il Concilio di Melfi I ed infine con il Concordato di Melfi riconobbe i possedimenti conquistati dai Normanni. Il Papa nominò Roberto il Guiscardo duca di Puglia e Calabria. La città di Melfi, passava un periodo fulgido della storia: in tale circostanza fu promossa a Capitale del Ducato di Puglia e Calabria. Roberto il Guiscardo, per sposare Sichelgaita di Salerno vi mandò in esilio la prima moglie Alberada di Buonalbergo.
Nel castello di Melfi furono organizzati altri Sinodi: il papa Alessandro II dal primo agosto 1067 presiedette il Concilio di Melfi II; ricevette il Principe longobardo di Salerno, Gisulfo II, ed i fratelli Roberto il Guiscardo e Ruggero d’Altavilla. Nel corso del Concilio di Melfi III, nel 1089, il papa Urbano II indisse la Prima Crociata in Terra Santa, poi Pasquale II nel 1101 convocò il Concilio di Melfi IV ed infine Innocenzo II nel 1137 celebrò il Concilio di Melfi V, ultimo della serie. Vi fu anche nel 1130 un Concilio di Melfi non riconosciuto dalla Chiesa, perché organizzato dall’Antipapa Anacleto II, che istituì il Regno di Sicilia.
Il periodo svevo
Con la venuta degli svevi, Federico II diede grande importanza al castello di Melfi e ne apportò alcuni restauri. Nel 1231, il maniero fu il luogo di promulgazione delle Costituzioni di Melfi, codice legislativo del Regno di Sicilia, alla cui stesura parteciparono Federico II assieme a persone come il suo notaio Pier delle Vigne ed il filosofo e matematico Michele Scoto. La struttura fu anche deposito delle tasse riscosse inBasilicata e prigione, ove tra i vari detenuti ci fu anche il saraceno Othman di Lucera, uscito in seguito dietro il pagamento di 50 once d’oro. Nel 1232, Federico II ospitò al castello il marchese di Monferrato e la nipote Bianca Lancia, che divenne sua moglie e da cui ebbe il figlioManfredi. Nel 1241, il sovrano svevo rinchiuse nell’edificio due cardinali e vari vescovi francesi e tedeschi, che avrebbero dovuto far parte di un concilio papale che prevedeva la sua destituzione.
Il periodo Angioino e i periodi successivi
Con la decaduta degli svevi e l’arrivo dei nuovi dominatori angioini, il castello di Melfi subì massicci ampliamenti e restaurazioni, oltre ad essere eletto da Carlo II d’Angiò residenza ufficiale di sua moglie Maria d’Ungheria nel 1284. Fu ancora soggetto a modifiche nel cinquecento sotto il governo aragonese e divenne proprietà prima degli Acciaiuoli, poi dei Marzano, dei Caracciolo ed infine dei Doria, il quale appartenne al loro casato fino al 1950. Il castello dovette subire due violenti terremoti nel 1851 e nel 1930 ma, a differenza di altri monumenti di Melfi che furono gravemente danneggiati, il castello ne uscì quasi incolume. Al giorno d’oggi, l’edificio ospita il Museo Nazionale del Melfese, inaugurato nel 1976.
Struttura
Il castello di Melfi è formato da quattro ingressi, di cui solo uno è tuttora agibile. Il primo, situato a nord est vicino alla Torre Parvula, era collegato direttamente con la campagna ed attualmente è murato; il secondo, anch’esso murato e collocato nei pressi della Torre della Chiesa, si apre nello spalto; il terzo a sud ovest, presente vicino al Baluardo del Leone, era l’ingresso principale nell’epoca angioina e permetteva di raggiungere il fossato e la città. Il quarto, l’unico attivo, fu aperto dai Doria e funge da accesso al paese attraverso un ponte, in tempi remoti levatoio. L’interno, sebbene trasformato dai Doria, tra il XVI ed il XVIII secolo, in un palazzo baronale, conserva ancora alcuni tratti strutturali in stile normanno-svevo.
Oltrepassato il ponte si nota un portale settecentesco che contiene un’epigrafe che rende onore alle gesta di Carlo V e Andrea Doria. Procedendo si accede al cortile dove è possibile recarsi alle scuderie ed ai cortili “dello Stallaggio” e “del Mortorio”, tutte opere angioine realizzate tra il 1278 ed il 1281 per volere di Carlo II d’Angiò. Sempre in stile angioino sono la “Sala del Trono” (che ospita il Museo), innalzata sul lato settentrionale, la sottostante “Sala degli Armigeri”. Da menzionare anche la “Sala delle Scodelle”, luogo in cui furono proclamate le Costituzioni di Melfi.
L’antica città di Melfi conserva molte vestigia dell'antichità, riferibili sia al periodo classico che medievale. In particolare, a quest’ultimo periodo si riferisce la grande costruzione del castello, il cui sistema difensivo è costituito da un fossato, uno spalto e dieci torri, tre a pianta pentagonale e sette a pianta quadrata, unite da una cortina che si salda alle fortificazioni dell'abitato.
Queste ultime, datate alla metà del XV secolo, furono costruite da Giovanni II Caracciolo, e si estendono per una lunghezza di quasi tre chilometri seguendo la morfologia del terreno con una serie di bastioni, torri e feritoie. Attualmente il castello conserva un nucleo più antico, verosimilmente normanno, costituito da torri quadrate poste alle estremità dell’ingresso al Museo Archeologico Nazionale, i cui cantonali si raccordano con aggiunte posteriori, e da un'altra torre posta nell'angolo ovest –l'ultima scomparve o non fu mai realizzata– circondando infine due enormi locali voltati a pieno centro. Nel 1269 la fortezza fu dapprima restaurata in parte ad opera del carpentiere Jean de Toul. I1 4 agosto 1277 la curia, ritenendo che dovessero essere completate la stalla, la torre e i muri, nomina Riccardo da Foggia con l'incarico di magister affinché provveda di procurare dei manovali e degli asini per il trasporto del materiale necessario alla sua ricostruzione.
Dopo gli Angiò il castello passò agli Acciaioli (1346-1392), ai Marzano (fino al 1416), ai Caracciolo che realizzarono la cinta della città e, infine, ai Doria che presero in consegna anche il castello di Lagopesole.
Si racconta che in questo castello Pierre de Angicourt, al quale erano stati affidati i lavori di restauro e ricostruzione, era violento e autoritario. Un giorno, poiché un operaio proveniente da Auricarro presso Bari, aveva fatto cadere un secchio di malta cementizia, il grande architetto francese volle punirlo mettendolo in catene sotto il sole cocente dell’estate, ma comunque permettendogli di lavorare e trasportare pesi enormi. Poiché di notte gli operai dormivano tutti insieme nelle logge circostanti, il povero manovale di Auricarro restò per un giorno fuori delle logge buscandosi un bel raffreddore: ma nella notte egli meditò una vendetta sottile.
Il giorno successivo il manovale venne a sapere che l’Angicourt era pronto a mandare un lettera all’Imperatore. Si offrì egli stesso di consegnare la lettera al messo, ma riuscì a sostituire la pergamena con una lettera dal tono più o meno preoccupante: “Signore, il grande architetto del cantiere del castello di Melfi tratta gli operai come degli schiavi, ed alcuni di essi, seppur pagati, cercano di fuggire; ecco perché Sua Maestà ha bisogno di trovare altri manovali”.
L’imperatore fu sconcertato nell’ascoltare, in auditorio, quella lettera, e si racconta che Carlo I chiese a Pierre d’Angicourt di non molestare più gli operai e di non aver nulla da ridire sulla loro paga.
Si racconta che quel manovale fu promosso e, per l’indennizzo avuto dall’imperatore, divenne appaltatore dei lavori prendendo il nome di Franciscus de Melfia.
il castello aragonese di Venosa (PZ)
Il Castello Aragonese di Venosa, in provincia di Potenza, è un castello situato all’estremità sud del pianoro occupato dall’estensione urbana della città.
La sua costruzione iniziò nel 1470 per volere del duca Pirro del Balzo Orsini nell’ottica di un progetto di fortificazione più ampio. Si tratta di una costruzione imponente, a pianta quadrata con quattro torri cilindriche. Lo stemma dei Del Balzo, il sole raggiante, è visibile sulla torre ovest. La costruzione del castello e lo scavo del fossato in conformità alle nuove dottrine fortificatorie comportò la demolizione della cattedrale romanica e del quartiere che la circondava. Fu pertanto costruita una nuova cattedrale in una espansione dell’abitato sulla parte bassa del pianoro dove sorge la città.
Da fortezza fu trasformato in dimora signorile da Carlo ed Emanuele Gesualdo, con l’aggiunta della loggia interna, dell’ala nord-ovest e dei ridotti alla base dei torrioni, e ospitò dal 1612 l’Accademia dei Rinascenti.
Le quattro torri cilindriche agli angoli sono sostenute da ridotti che costituiscono la scarpa del fossato, utilizzati come prigioni, e tutto l’edificio, a cui si accede tramite un ponte levatoio, è circondato da un profondo fossato. All’interno si apre un ampio cortile circondato da un loggiato rinascimentale. Di fronte al castello c’è invece una piazza porticata e una fontana monumentale concessa a Venosa da Carlo d’Angiò.
Al suo interno, negli ambienti ricavati nei basamenti delle torri, il castello ospita il Museo Nazionale di Venosa, che conserva soprattutto le ricche testimonianze della colonia romana di Venusia.
Nell'anno 1470 Pirro del Balzo, duca illustre di Venosa, vedendo che questa città era esposta a molte vicende di guerra e che, quindi, per la difesa dei cittadini, era necessaria la costruzione di un castello, domandò ed ottenne dal Vescovo della città, il luogo dove sorgeva la Chiesa Cattedrale, impegnandosi a farne costruire un'altra a sue spese. Il motivo fu la grande espansione della città che, spostandosi oltre l’attuale area archeologica delle terme e della cosiddetta "Incompiuta", la popolazione divenne più numerosa ed anche più ricca per i traffici commerciali lungo la via Appia.
Il primo signore di Venosa fu Venceslao Sanseverino, ma alterne vicende la portarono, sotto Federico II, a divenire una città demaniale.
Ciò permise, ovviamente, una certa stabilità dell’insediamento che così prosperò senza essere angariato dalle numerose gabelle feudali.
La città, dunque, diventò più grande e necessitava di essere difesa da un forte castello. Il castello fu costruito come il Castel Nuovo di Napoli, separato da un grande e profondo fossato.
Furono innalzate quattro solidissime torri con basamento a scarpa, di cui due ridotte ad un terzo della primitiva loro grandezza. Nell'interno vi è uno spazioso cortile che ospita manifestazioni culturali, mentre gli appartamenti baronali sono oggi Biblioteca e sede degli uffici periferici della Soprintendenza Archeologica della Basilicata.
Il castello di Venosa era famoso per le sue prigioni, che furono comparate ai celebri Piombi di Venezia.
Le mura interne portano ancora le tracce della tirannide baronale; molte iscrizioni, incise nella dura pietra richiamano le pene, gli affanni, le torture dei prigionieri.
Si racconta che questo castello fu sede di vari incontri galanti fra il signore del castello e le cortigiane che, durante le rappresentazioni teatrali, si offrivano volentieri per poi favorire la carriera dei mariti all’interno del feudo.
Non sappiamo se accadde proprio in questo castello, ma una sera venne rappresentata una commedia, il "Paolino e Polla", scritta dal giudice Riccardo intorno al 1230, che raccontava le vicende del periodo federiciano. Durante lo spettacolo cadde il palcoscenico e tutti videro il castellano con una cortigiana in abiti poco decenti.
Oggi è facile trovare ancor oggi nascondigli scavati nelle pareti, trabocchetti calati nel suolo, segrete oscurissime e strumenti per la tortura.
(di P. Rescio)
il castello Caracciolo di Brienza (PZ)
Il castello Caracciolo è una corona posta sul borgo medievale di Brienza. Una corona preziosa, perché, secondo la leggenda, custodisce il tesoro di donna Bianca, castellanna conturbante e vittima dei pirati saraceni.
La storia della fortezza burgentina corre parallela a quella della Basilicata medievale. Ne tramanda l’origine longobarda, la conquista normanna, il passaggio a Federico II eppoi ai d’Angiò. I Caracciolo, che la tennero fino al 1857, la acquistarono nel XV secolo e più di altri si prodigarono per la crescita del loro feudo.
Se Domenico Bolognese ambientò in questo castello il dramma lirico “Rodolfo da Brienza” (musicato da Achille Pistilli e rappresentato, la prima volta nel 1846, nel Real teatro del fondo di Napoli), oggi il fortilizio, che conserva l’impronta angioina nel mastio cilindrico e nella semitorre circolare situata al centro della cinta muraria fa da sfondo, nei mesi estivi, allo spettacolo “Suoni e luci della storia”.
Questa rappresentazione, evento clou dell’estate burgentina, è una carrellata storico-culturale lungo la storia di Brienza e del suo castello (dichiarato ai primi del ‘900 “patrimonio di interesse storico”) dall’anno 1000 ai nostri giorni.
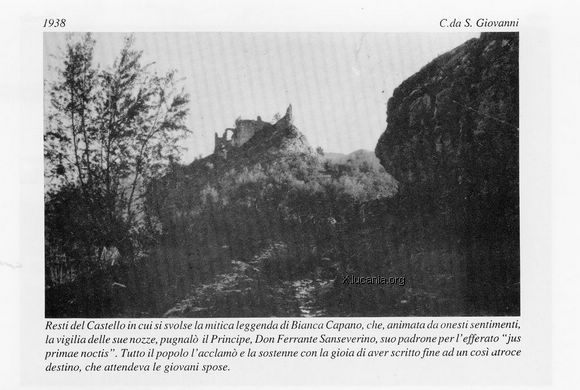
il castello di Marsiconuovo (PZ)
Su una piccola collina in Contrada San Giovanni di Marsiconuovo, sono visibili pochi ruderi di un antico castello, chiamato castello di Marsico, chiamato in dialetto locale semplicemente "u' castiedd".
In questo Castello si svolse la mitica leggenda di Bianca Capano, che, animata da onesti sentimenti, la vigilia delle sue nozze, pugnalo' il Principe Don Ferrante Sanseverino, suo padrone per l' efferrato "jus primae noctis".
Tutto il popolo l' acclamo' e la sostenne con la gioia di aver scritto fine ad un cosi' atroce destino, che attendeva le giovani spose.
La legge "jus primae noctis" imponeva che la prima notte di nozze, le giovani spose dovevano trascorrerla a letto con il principe in questo castello.
Da molti documenti non sarebbe un vero castello, ma piuttosto di una rocchetta, cioe' un posto di avanguardia.
La collina del Castello era di proprieta' fino al 1960 del marchese Francesco Navarra Viggiani, che la vendette ad un cittadino privato. Meta' della collina sono oggi erosi dall' uomo, perche' su questo fianco della collina venivano estratte pietre per costruzioni e sabbia. Questo fianco della collina veniva chiamato "La Cava". Da questo fianco vi sono alcune grotte, che secondo la leggenda erano le uscite di sicurezza del Castello. In fotografie antecedenti gli anni cinquanta le rovine del castello erano molte piu' abbondanti, come mura piu' alte e si scorge in qualche vecchia foto un arco e qualche finestra, probabilmente cadute dopo qualche ennesima scossa di terremoto oppure le pietre sono servite come materiale da costruzione per qualche edificio nei paraggi.
Il vecchio castello di Marsico si trovava invece sulla collina piu' alta del paese, sulla collina della Civita. Nel 1330 per volonta' di Enrico Sanseverino sulle rovine del castello sulla collina della Civita fu eretto il convento francescano.
Il convento francescano sulla collina della Civita esiste ancor oggi, in completo abbandono e in desolate condizioni. Sul portale si possono ammirare magnifici bassorilievi del trecento.
Il Campanile di San Francesco, una bellissima torre a base quadrata domina ancor oggi il paese di Marsiconuovo.
Fino al 1980 questo convento era abitato dalla famiglia del carcieriere di Marsico, perche' fino a pochi anni apprima per circa un centinaio di anni, il convento era stato modificato in carcere e le celle dei monaci in sicure prigioni dei carcerati.
Negli anni della seconda guerra mondiale il carcere era sovraffolato di detenuti. Il Campanile di San Francesco fungeva da Torre di Guardia, perche' da qui la vista dominava tutta la Val D' Agri.
A Marsiconuovo, sempre sulla collina della Civita, qualche centinaio di metri piu' in basso del Castello, c' e' ancora il Palazzo Santalucia, edificato nel secolo scorso sulle rovine del cinquecentesco palazzo Tafuri, appartenuto al magnifico giuriconsulto Alessandro Capano (1520 - 1594), padre della leggendaria Bianca Capano, menzionata all' inizio di questo testo. (testo di Gino Di Grazia)
il castello di Moliterno (PZ)
Il castello longobardo di Moliterno sorge su uno sperone roccioso, la cui costruzione, secondo il Racioppi, risale al XII secolo. Successivamente i normanni costruirono il resto del castello edificandolo intorno alla torre longobarda.
La massa dell’edificio in ristrutturazione, come appare oggi, è una costruzione seicentesca con un ampio cortile circondato da un muro di cinta fino ad una torre quadrata ad est ed una torre più tozza e rotonda ad ovest che si congiungono alla facciata con una serie di archi, formando un loggiato cinquecentesco. Dalla torre longobarda, che si unisce alla facciata, partendo dalla torre bassa e rotonda, si aprono due ingressi: il primo immette nel secondo cortile e il secondo nelle stalle, nelle quali sono, ancora, visibili le nicchie delle mangiatoie. La torre longobarda è alta 25 metri, ha un diametro di 8 metri ed è sormontata da merli guelfi quadri, andati per lo più distrutti.
Internamente, è costituita da tre piani, ognuno dei quali, è formato da una sola stanza , ricevente luce da una sola finestra. La stanza del pianterreno era adibita a carcere, mentre alle altre stanze, si accedeva mediante una scala a chiocciola.
Il secondo cortile, più piccolo del primo, mostra uno spettacolo di profonda desolazione: vi sono dappertutto rovine ed è quasi impossibile ricostruire la disposizione delle stanze. Oltre alle stanze del principe e dei suoi ospiti, alle stalle, alle cucine, alle carceri, ai locali adibiti a magazzini per le merci, alla cappella privata, il castello possedeva, anche, una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana.
L’ultimo proprietario del Castello fu Domenico Cassino, che l’acquistò nel 1827. Questi rimise il Castello in ottime condizioni di abitabilità, tanto da trasformarlo in collegio nel 1892 con la direzione del Prof. Antonio Frabasile. Il collegio fu frequentato da molti studenti moliternesi e da alcuni allievi provenienti da Potenza. Le beghe paesane, causarono nel 1894, la fine di questa istituzione e il sopra citato Domenico Cassino distrusse vandalicamente il Castello vendendone persino gli infissi. Esso fu poi venduto ai Padula e da questi ultimi fu ceduto ai Comune di Moliterno per la cifra simbolica di lire mille. E’ stato, in seguito, dichiarato “monumento d’interesse nazionale” e sono stati eseguiti dei parziali lavori di restauro esterno alla fine degli anni 70. Attualmente è in fase di progettazione una ulteriore fase di restauro.
La costruzione del castello di Moliterno è davvero imponente, e l’origine dai più si fa risalire al tempo dei Longobardi, anche se l’impianto attuale risale all’età angioino-aragonese.
Non si esclude che una parte del castello possa essere stata costruita dai Normanni.
Solo nel 1239 troviamo che nel castello fu custodito il barone lombardo Nicoletto de Cusano, fatto prigioniero da Federico II. Nel 1269 Carlo I d’Angiò concesse in feudo il castello ad un generale della sua cavalleria, un certo Oddone di Brajda.
I Brajda lo tennero fino al 1477, anno in cui uno dei Sanseverino lo acquistò, anche se poi lo perdette in seguito alla congiura dei baroni del 1485; tuttavia lo riconquistò in virtù dei patti di Traetto (1496); ancora, nel 1504 lo perse di nuovo, riacquistandolo definitivamente. L’ultimo dei Sanseverino lo vendette, nel 1524, al principe di Stigliano Antonio Carafa della Marra, che consentì alla sua famiglia di possedere terre e fortezza per oltre un secolo e mezzo. Infine, dopo la breve signoria degli Spinelli (1682-1685) il castello passò ai Pignatelli. che lo tennero fino al 1806.
I momenti di massimo splendore del castello di Moliterno li visse sotto la signoria di donna Anna Carafa, vice regina di Napoli, e dei Pignatelli.
Verso la fine del secolo scorso fu sede, per pochi anni, di un collegio.
IL CASTELLO DI ABRIOLA
Nel castello arabo di Abriola c’era una famiglia assai devota alla madonna di Monteforte, ma era afflitta da povertà e disgrazie infinite che si era ridotta a due soli stretti parenti: il nonno e una nipote che si arrangiava da cucitrice.
Il feudatario di quel paese, che aveva fama di essere assai capriccioso, un giorno volle che qualcuno gli indovinasse quanto valeva la sua barba. Ordinò pertanto alle guardie di far salire su al palazzo tutti coloro che fossero passati per quella via. Passò il primo cittadino, le guardie lo condussero davanti al sovrano il quale gli ordinò di sedere e gli impose: “Tu devi indovinare quanto vale la mia barba”. Il povero cristiano non seppe che rispondere e di conseguenza fu mandato in prigione. Passò il secondo, poi il terzo e poi il quarto e a ciascuno capitò la stessa sorte.
Intanto il nonno e la nipote pativano sempre più freddo e fame; essi abitavano in un sottano nelle vicinanze del palazzo reale e per rimediare qualcosa dovevano transitare dove le guardie fermavano i passanti. Allora la nipote disse al vecchio: “Vai su alla fortezza e quando sei dinanzi al duca digli che nell’ora della morte la sua barba vale quanto la tua”.
Il nonno, spinto dal bisogno, passò per quella via, le guardie lo chiamarono e gli ordinarono di salire dal duca. E il duca gli rivolse la stessa domanda. Il vecchio rispose: “Quando morirai, Maestà, la tua barba varrà quanto la mia”. “Bene! Chi ti ha suggerito la soluzione?”. “Nessuno”. “Bada, devi dirmi la verità se no ti mando in prigione”.
Il vecchio, intimorito, rispose: “Perdonami la superbia. Mia nipote è stata a suggerirmi questa soluzione sfrontata”.
“Oh, bravo! Conducimi qui tua nipote”, fece di rimando il duca.
Il vecchio, mai immaginando come se la sarebbe cavata, andò a chiamarla e il sovrano, volendo premiare l’acume della fanciulla e assicurarsi un pò di giudizio a corte, pensò bene di darla in sposa a suo figlio.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI ACERENZA
Tutti sanno che un tempo, almeno sino all’ottocento, nella città di Acerenza c’era un castello che si dice costruito dai Bizantini ed abitato dai Longobardi e, quindi, ci sono numerose leggende. Nel periodo in cui Acerenza era padrona di larga parte del territorio circostante, c’era un re che mentre andava a caccia vide un uomo intento a zappare il suo campicello. Il sovrano chiese cosa stessse facendo, ma il contadino rispose seccato: “Quello che tu non conosci, ovvero cercarsi da vivere senza servi e schiavi musulmani”.
Il re non rimase colpito, poiché conosceva il malcontento del popolo, ma chiese ancora: “Perché non vieni a corte con me così vedi come può essere difficile la vita di un sovrano?”.
E lo zappatore: “Va bene, ci sto ”.
Andarono insieme a corte e lo zappatore fu subito preso dall’entusiasmo vedendo che alcune ancelle si prendevano cura di lui. Ma la vita, come aveva detto il re, non era facile.
Alcuni cortigiani, visto il nuovo arrivato, iniziarono a congiurare contro di lui.
Dapprima scomparve dalla tavola un bellissimo vassoio bizantino e subito tutti dettero la colpa al povero, poi fu ammazzato il cuoco e, successivamente, il coppiere del re.
Il re volle sapere il senso di questi fatti dopo che i cortigiani gli rivelarono che era stato lo zappatore a fare questo. “Dunque così mi ripaghi? Dopo che ti ho accolto nella mia casa come un figlio e ti ho fatto godere la gioia dell’essere re? Ora, devi andare in prigione ed essere punito”
Nella notte, in quella buia ed umida prigione, il contadino pensava al dolore di aver incontrato quel re così ottuso e cattivo. Era intendo alla preghiera, quando all’improvviso si mosse il cancello di ferro ed apparve lo stesso re di Acerenza. Il contadino non disse niente, ma il re iniziò a parlare: “Hai visto, caro suddito, come alberga la cattiveria dentro questo castello, e a quante congiure devo sottostare per non fare la fine che farai tu. Ma non preoccuparti, ti farò fuggire, a patto che tu mi prometta di dire in giro che non si può mai invidiare un sovrano senza averlo fatto prima”.
Lo zappatore riuscì a fuggire, e dal quel giorno rimase sempre lontano dal castello, e non volle incontrare mai più alcun sovrano.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI AGROMONTE
Il castello di Agromonte, nominato per la prima volta nel 1112, è una piccola costruzione posta su una piccola collina, fra le località Dragonetti e Scalera in agro di Lagopesole(20); di esso non rimangono che i tratti di una struttura fortificata a pianta quadrata ed una chiesa. Il sito, proprio perché abbandonato in antico, fu spesso rifugio di briganti.
C’era una volta un padre che aveva tre figli di cui il minore era stato soprannominato dai fratelli, Carmine. Quando il genitore chiuse gli occhi lasciò come unica ricchezza tre vacche; i fratelli Pietro e Paolo si presero le più pregiate e più grasse e a Carmine toccò la più piccola e ossuta.
Il ragazzo, fu così costretto ad accettare quell’ingiustizia ma, non volendo più subire altre prepotenze dai fratelli, decise di uccidere la vacca, ricavare dalla pelle una grancassa e mettersi a girare per il mondo.
Con questo strumento cominciò presto a guadagnarsi di che vivere e molto spesso i padroni di masserie lo conducevano in campagna perché col tam-tam allontanasse gli stormi di uccelli che si divoravano i campi di biade.
Un giorno Carmine si inoltrò in un bosco e si diede a rullare di santa ragione proprio mentre tre ladri si stavano dividendo il tesoro che avevano rubato a un ricco proprietario. Nel sentire quei rumori da truppa in marcia i briganti immaginarono che fossero le guardie che venivano ad arrestarli per cui, senza indugio, abbandonarono la ricchissima preda e se la diedero a gambe. Carmine, come li vide scappare a quel modo, pensò che dovessero essere dei briganti, e non s’ingannava infatti; tanto che approssimatosi al valloncello da cui si erano allontanati scopri sparsi nel terriccio marenghi, anelli con pietre preziose e brillanti. “Misericordia!” esclamò quasi incredulo di quella fortuna, riempì la sacca e tornò al paese a mostrare ai fratelli ciò che aveva rinvenuto.
Quando gli egoisti dei fratelli seppero l’accaduto sbiancarono dalla sorpresa e vollero sapere come avesse fatto quella mezza cartuccia di Carmine a impadronirsene, e il ragazzo svelò onestamente il suo segreto. Allora essi, spinti dalla brama dell’oro, si affrettarono a uccidere le rispettive vacche, a ricavarne enormi grancasse e a portarsi sul luogo indicato da Carmine.
Intanto i tre ladri, pentiti di aver lasciato il bottino allo scoperto, tornarono nel bosco per recuperano; ma, cerca di qua e cerca di là, non trovarono un bel nulla, e già muti e sconsolati stavano per andarsene in malora, quando riudirono quel tam tam da cui si erano lasciati stolidamente impressionare due giorni prima. E persuasi che si trattasse delle medesime persone che avevano seminato loro terrore li presero di santa ragione e si impadronirono dell’unica loro ricchezza, cioè le grancasse. Come a dire, in lucano, Chi spàragn’ mbragn’ e mal’ e ben’ nun s’n’ ver’ (Chi risaprmia troppo va in rovina e non gode nessun bene della vita).
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI ANZI
Il principe di Anzi aveva tre figli. Un giorno il più grande volle andare a caccia e, sistemata la colazione nella bisaccia, montò a cavallo e si diresse verso le Serre.
Cammina e cammina si ritrovò in un bosco. Mentre lo attraversava fu colto da un temporale così nero che non si distingueva più la terra dal cielo. In mezzo a tuoni e lampi scorse tuttavia una luce che proveniva da una piccola casa che lì per lì gli parve più confortevole della sua reggia.
La porta era aperta e vi entrò di corsa ringraziando la Provvidenza.
E siccome nessuno dava segni di vita lì dentro si tolse i panni bagnati e li sparse accanto al fuoco che crepitava allegro nel camino. Dopo di che tirò fuori dalla bisaccia le sue provviste e cominciò a mangiare.
D’un tratto apparve una vecchia strega che incrociando le mani sotto le ascelle tutta intirizzita esclamava: “Oh figlio, che freddo! Oh figlio, che gelo!”
Il giovane s’impressionò a quella improvvisa apparizione, ma poiché era intrepido di natura subito si riprese e offrì alla vecchia metà della sua provola e metà della sua frittata.
Non si accorgeva, poverino, che le unghie della megera si allungavano a vista d’occhio, e tanto crescevano e tanto si arcuavano che in un baleno potettero afferrarlo e stritolarlo. A quel punto il cadavere venne raccolto da mani sconosciute e deposto in un sotterraneo dove giacevano decine di altri sventurati.
Il padre intanto, non vedendo tornare più il primogenito, s’impensierì e mandò il secondo figlio a cercarlo, ma anche costui, giunto alla casa maledetta, si fermò per la colazione e cadde vittima della strega.
Partì infine il terzo figliuolo che, sorpreso dal temporale nel bosco, si rifugiò nella tana che sappiamo. Questi però, a differenza dei fratelli, si accorse in tempo che le unghie della vecchia si allungavano spropositatamente e fu lesto ad agire: sfoderò la sciabola e infilzò al petto la megera la quale, prima di spirare, ebbe l’animo di rivelargli: “Figlio mio, giacché mi hai dato scacco matto meriti di sapere una cosa: là nello stipo c’è un unguento che fa risorgere i morti. Prendilo e ungi con esso i corpi che troverai nel sotterraneo. E adesso bruciami e spargi le mie ceneri nel bosco”
Il giovane eseguì fedelmente quello che gli era stato richiesto, aprì il vaso dell’unguento, unse i corpi di alcuni estranei e dei fratelli e portò questi ultimi sani salvi alla reggia.
Giunti al palazzo, una nuova sciagura li doveva affliggere: il vecchio principe, un pò per la pena de suoi figlioli e un pò per le lacrime versate, era diventato cieco e il medico andava dicendo che per guarire erano necessarie le penne del pavone da strofinare sulle palpebre dell’infermo.
I tre fratelli si rimisero dunque in cammino, ciascun per una strada diversa. Il più piccolo, quello che aveva salvato dall’incantesimo gli altri due, incontrò una donna che gli chiese: “Dove vai per queste vie?”. E lui: “Vado in cerca delle penne del pavone per mio padre cieco”.
La vecchierella, che in verità era Santa Lucia, la cui chiesa si trova ad Anzi, disse allora: “Vedi là quel palazzo bianco? Non vi sono scale ma io ti darò questa scaletta a molla con la quale potrai salire e prendere le penne che si trovano nella campana di vetro dell’ultima stanza”.
Il giovane ringraziò di tutto cuore il viandante, si arrampicò sulla scala a molla, raggiunse il luogo indicato e se ne tornava sereno alla reggia col rimedio miracoloso quando s’imbatté nei fratelli che, più infami degli infami briganti di Rionero, lo uccisero per gelosia e lo buttarono in una gravina.
Il padre, poveretto, ormai risanato grazie alle penne sottratte al terzogenito, continuava ad aspettare il ritorno di quest’ultimo e non riusciva a capacitarsi della sua prolungata assenza.
Una mattina un pastore, puntando a terra il bastone, sentì che il suolo cedeva e, sicuro di trovare un tesoro, scavò fin quando non fu a contatto con un mucchio di ossa che egli scambiò per assicelle di legno. Da una di esse ricavò uno zufolo e si mise a suonare; ed ecco chè dai buchi dello strumento prese a uscire un doloroso ritornello:
“ Mio pastore, mio .pastore
tienimi tienimi, non mi far cadere
per una penna d’uccello pavone
mi hanno ucciso senza ragione... “ :p>
L’uomo, fuori di sé dalla meraviglia, andò dal re con lo zufolo fatato e al suo cospetto si rinnovò il prodigio:
“…Pietro mi reggeva
e Nicola mi uccideva.
Nicola fu il traditore”
Il re rabbrividì a questo canto, fece chiamare i fratelli e, dando esempio di giustizia al popolo che si era raccolto sotto le finestre del palazzo, ordinò che fosse gettato in mare Nicola e punito con cinque tratti di corda Pietro. Passò ancora un pò di tempo e il sovrano che aveva ormai raggiunto la tarda età e non aveva avuto in sorte una vita felice, chiuse gli occhi, pace a lui, proprio mentre dallo zufolo del pastore si levavano dolci note:
“Padre mio, padre mio
ti terrò stretto,
non ti farò cadere
per una penna d’uccello pavone
staremo insieme fino all’Ascensione”. :p>
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI BALVANO
Nel castello di Balvano, un bel castello cinquecentesco posto in alto sul borgo antico, c’erano due cuoche, una giudiziosa e modesta, l’altra ficcanaso e pettegola, capace di creare situazioni anche spiacevoli.
La cuoca buona, sempre spiata dall'altra rivale che voleva farsi sempre buona luce nei confronti della moglie del castellano, seccata dell'atteggiamento dell’altra, prese consuetudine di chiudersi in ogni camera del castello durante le faccende.
Laltra, per farle dispetto, con un incantesimo si trasformava in una gatta. Così facendo, pensava di non farsi vedere, di continuare a lavorare e di spiare finalmente la collega.
Una mattina, appena ritornò da gatta a donna, le chiese: “Comare…quanto vi sono costati gli orecchini d'oro che avete riposto nel comò?”.
La vicina, sorpresa nel sentirsi rivolgere la domanda, le diede la risposta che desiderava.
Un altro giorno, saltando giù dal finestrino, si arrampicò sui fornelli e leccò la teglia dove era a cuocere il pranzo. E poco più tardi domandò all'amica: “Sono davvero gustosi i maccheroni col sugo di lepre?”.
La comare di carattere riservato restò ancora di stucco per come la collega sapesse tutto, e non riusciva a capire come faceva. In effetti, conoscendo l'attività di fatucchiera della cuoca, le venne il sospetta che quella gatta nera fosse la sua amica, e volle vendicarsi.
Una domenica, mentre stava scolando la pasta per il castellano, vide la falsa bestiola e le versò addosso l'acqua bollentissima. La gatta fuggì come una forsennata miagolando.
Trascorso un pò di tempo, ricomparve la comare intrigante tutta fasciata e l'altra domandò cosa le fosse accaduto. La furba rispose che mentre scolava la pasta un topo le era passato fra i piedi e le aveva fatto cadere l’acqua bollente.
Da allora, si racconta, nel castello di Balvano non girano più gatti, anche se è stato per anni abbandonato.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI BARAGIANO
A Baragiano c’era un padre assai ricco ma di poco cervello che aveva tre figli. Poiché nel castello non mancava nulla, non si prese cura di insegnare loro l’arte della guerra o un mestiere di governare, pensando che essi sarebbero eternamente vissuti nell’abbondanza.
Ma quand’egli morì i figli, non lavorando, dettero ben presto fondo ai loro averi e si ridussero in miseria. Spinti dal bisogno e non trovando alcuno che li aiutasse, decisero di rivolgersi all’imperatore per chiedere a lui i mezzi di sostentamento o almeno consiglio sul da fare.
Per non apparire troppo molesti pensarono di recarsi uno alla volta alla reggia. Un giorno vi andò il primogenito e confidò a Sua Maestà che non sapeva come tirare avanti e gli sarebbe stato grato di qualche suggerimento. Il sovrano lo ascoltò e gli ordinò di ritornare dopo un anno. Il giovane, deluso nelle sue aspettative, come fu nella strada ebbe la ventura di imbattersi in un impagliatore di sedie e lo pregò di prenderlo addirittura con sé. L’impagliatore lo accolse nella sua bottega e dapprima lo adibì a carreggiare paglia e assi di legno e in seguito lo avviò nel mestiere vero e proprio compensandolo con una discreta paga giornaliera.
Il secondo figlio, ricevuta dal sovrano la stessa risposta del fratello, non appena si ritrovò sulla strada si accompagnò a un calderaio che passava di là e gli si offrì per qualunque servizio purché gli desse da mangiare. Il calderaio lo prese a ben volere e in breve tempo gli insegnò l’arte del rame per cui poté rapidamente vivere con decoro.
Il terzogenito, invece, dopo la risposta del sovrano, si avviò per un tratturo nei boschi e qui, circondato da una compagnia di briganti, fu costretto a unirsi alle loro imprese. E poiché era audace e prestante nella persona venne presto eletto loro capo e passò da una ribalderia all’altra divenendo il terrore di quelle contrade. Allo scadere dell’anno ciascuno dei tre volle tornare dal sovrano. I primi due fratelli s’incontrarono in una locanda vicino al palazzo e ognuno raccontò ciò che aveva compiuto durante quel periodo. Ordinarono all’oste una buona pietanza, ma quegli rispose sgarbato che non disponeva né di pesce né di carne e dovettero accontentarsi di un pezzo di pane e cacio.
Mentre stavano consumando il frugalissimo pasto giunse un cavaliere armato fino ai denti che montava un magnifico cavallo. Il padrone della locanda gli si fece incontro per domandargli in che cosa potesse servirlo e il cavaliere ordinò con arroganza quanto di meglio ci fosse di fresca cacciagione e carni salate. L’oste apparecchiò come si conveniva a un gran signore e si mise d’impegno a soddisfare i suoi desideri. Il capo brigante, che era poi il terzogenito e aveva già identificato i fratelli, li invitò alla sua tavola e siccome entrambi erano lontani dal riconoscerlo non intese prolungare oltre il gioco e si rivelò. I due, meravigliati di vederlo così ricco, potente e sicuro di sé, gli consigliarono di non recarsi dal re; ma egli rispose che intendeva invece andarci puntualmente, mostrargli la sua bravura e dichiarargli che non temeva le vendette di chicchessia.
Il giorno successivo il primogenito si presentò al sovrano il quale gli domandò che cosa avesse fatto durante quell’anno e come seppe che aveva imparato l’arte di impagliare le sedie: “Bravo, figliolo” gli disse. “Hai visto che la necessità aguzza l’ingegno? Continua a lavorare sodo e vivrai onestamente”. Ciò detto lo licenziò.
Uguale risposta dette al secondogenito che si era impratichito a saldare arnesi domestici; quindi fu la volta del terzo fratello. Come lo vide avanzare nella sua tenuta di capobrigante, si irrigidì sul trono e gli intimò di cambiare abitudini e prendere esempio dai suoi fratelli se non voleva finire impiccato. Il giovane rispose con ardire: “Maestà, non posso accogliere il vostro consiglio, però vi prometto che se i vostri uomini saranno capaci di acciuffarmi abbandonerò per sempre la malavita e mi metterò al vostro servizio”.
Il re accettò suo malgrado la sfida e lo lasciò andare, ma nello stesso istante impartì ai gendarmi l’ordine d’inseguire la masnada e di arrestare a qualunque costo il capo.
Questi, intanto, che era riuscito a sfuggire alle ricerche degli sbirri volle dare al sovrano un saggio della sua straordinaria abilità e perciò decise di trafugare il tesoro regale che si trovava poco distante dalla reggia.
Una notte, infatti, pur essendo l’edificio circondato da alta muraglia e custodito da numerose sentinelle, fece calare attraverso un comignolo uno dei più agili compagni e questi, penetrato nella stanza strapiena di sacchetti di oro e d’argento, ne prese quanti più ne poteva e tornò alla luce senza essere scoperto dalle guardie.
Il mattino seguente, venuto a conoscenza del furto, il sovrano non tardò a indovinarvi lo zampino del capo brigante, e persuaso che costui si sarebbe fatto vivo con nuove prove della sua temerarietà, ordinò ai famigli di collocare una grossa tinozza di pece sotto il comignolo di modo che vi rimanesse impigliato chiunque avesse osato discendervi. Trascorso qualche tempo, la banda tornò all’azione grazie al più smilzo dei fuorilegge, ma come questi uscì dalla strettoia del comignolo e stava per toccare il suolo, si trovò immerso nella pece fino al collo e non poté far altro che segnalare a quelli di sopra la condizione in cui era venuto a cacciarsi.
Il capo decise allora che scendesse giù un secondo uomo dandogli tutte le istruzioni perché evitasse la sorte del compagno. Difatti il secondo uomo ebbe l’accortezza di poggiare i piedi leggero leggero sull’orlo della tinozza e di qui saltare nel sotterraneo impossessan dosi di tredici sacchetti d’oro fino. Quindi si rivolse al disgraziato in trappola e gli disse: “Caro mio, a te è toccata una triste sorte. Da questa pece non potrà cavarti nemmeno Iddio. Se non ti ammazzo io ci penseranno gli sbirri ad ammazzarti domani. Ma prima vorranno sapere i nomi dei compagni e tu, volente o nolente, ci rovinerai. Invece io ti giuro che penseremo in tutto e per tutto alla tua famiglia, che non faremo mancar nulla a moglie e figli. Adesso raccomandati l’anima al Padreterno e rassegnati a morire”. Quando terminò di dire queste parole gli tagliò la testa e se la portò con sé avvolta in un panno scuro.
Il giorno dopo, allorché le guardie scovarono il corpo decapitato nella pece, non sapendo a chi diavolo appartenesse, stabilirono di portarlo in processione per le vie della città, sicuri che la moglie o qualche altra persona di famiglia sarebbe scoppiata in lacrime nel riconoscerlo. La gente, invece, nel vedere quello spettacolo rideva, si accalcava e parlava con ammirazione di chi aveva preparato il colpo.
Dal canto suo il capo della banda, ad evitare che la vedova si tradisse dinanzi al cadavere, mandò un suo messaggero a confortarla e a compensarla con una generosa somma di denaro. La poveretta promise che avrebbe tenuto celato il suo dolore, ma proprio nel momento in cui il corteo funebre passava dinanzi alla sua casa, non resse alla pena e prese a gridare. Il brigante messaggero fu pronto però a sferrare un calcio alla giara dell’olio, riducendola in frantumi e lasciò credere agli sbirri che la donna piangesse per. quel danno. Costoro tuttavia, secondo l’ordine del re, tracciarono una croce con un pezzo di carbone sulla porta di quella casa.
Gli altri briganti che si erano mescolati alla folla e seguivano il corteo, avendo notato quel pericoloso segno di riconoscimento si ingegnarono di ripeterlo dieci, venti, cento volte su ogni porta allo scopo di confonderlo e di sviare le indagini. Così accadde che dopo il seppellimento del cadavere, per quanto cercassero in lungo e in largo, gli sbirri non riuscirono a isolare la casa della vedova.
L’episodio destò grande collera nell’animo del re che punì severamente i suoi gendarmi per la dabbenaggine con cui si erano fatti giocare dai fuorilegge. Ma ecco che quando ormai più nessuno se lo aspettava il capobanda si presentò al sovrano in abito di generale e gli disse:
“Maestà, ho voluto dimostrarvi che sono più forte di voi. Il re, dinanzi a tanta ardimentosa lealtà, rimase stupefatto e considerò in cuor suo che un brigante di quella levatura poteva essergli più utile da vivo che penzoloni aI palo. Lo. promosse dunque suo aiutante di campo e nominò i due probi fratelli, ben lieti di abbandonare sedie e caldai, capitani dell’esercito imperiale.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI BRINDISI DI MONTAGNA
Una tradizione vuole che il Castello di Brindisi di Montagna fosse stato costruito dagli Arabi che presero Pietrapertosa e Tricarico. Questa ipotesi serve a dimostrare che la maggior parte degli abitati che gravitano intorno alle Dolomiti Lucane e al territorio di Laurenzana vennero frequentati, probabilmente, da gruppi di popolazioni spinte dalle incursioni dei Musulmani all’interno della Basilicata, per trovare riparo e difesa sui monti e quindi di costruirsi una loro fortificazione.
Nel 1268 Guidone de Foresta, primo signore di Brindisi, prese possesso del castello, che passò nel 1280 a Gerardo de Divort, quindi ad Aegillo di Belmonte, per poi passare, nel XIV secolo, al "Real Fisco".
Nel 1414 ritornò ai signori di Brindisi Baldassarre La Zatta e, successivamente, ad Antonio Sanseverino.
I terremoti del 5 e del 10 dicembre 1456 danneggiarono la struttura e distrusse del tutto la grande fortezza ed il feudo, rimase forse abitato solo nei casali circostanti, come dimostrano i ruderi del feudo di Pietra Morella. Anche qui esisteva già un cenobio definito dalla tradizione "basiliano" (cioè dove reano presenti monaci italo-greci), ma nel XVI sec. pervenne ai Padri Certosini di Padula ai quali fu donato dal Principe Nicola Sanseverino, allora proprietario del territorio di Brindisi.
Nacque così la "Grancia di S. Demetrio", eretta per designazione del rettore Gerardo Church, detto Dionisio Canonico Potentino. La grancia fu dedicata a S. Demetrio da Irene Scanderbergh, figlia dell’eroe albanese e moglie del Sanseverino. Nel 1700 i Certosini estesero i possedimenti su tutto il feudo ampliando l’antico fabbricato, sede del cenobio, costruendovi abitazioni, mulini e ovili.
Il monumento è riconoscibile da una torre di avvistamento con merlatura che sormonta un edificio il cui ingresso è costituito da un grande portale in pietra.
La struttura sembra essere databile alla metà o fine del XVI secolo. Sul lato opposto vi è un altro ingresso che conduceva ad una cappella dove agli inizi di questo secolo si trovava un altare barocco ed una statua di S. Lorenzo. La costruzione ricalca i dettami di S. Bruno, fondatore dell’Ordine monastico certosino, finalizzato al ritiro e alla contemplazione.
L’insediamento vero e proprio di Brindisi di Montagna fu invece ripopolato tra il 1532 e il 1534, quando trenta famiglie di immigrati albanesi provenienti dalla città di Corona scelsero come loro dimora la parte più sicura presso il castello che, intanto, era passato a Pietrantonio Sanseverino IV.
La torre centrale del castello di Brindisi, costruita dopo l’XI sec. dai Normanni, fu spesso utilizzata come cella d'isolamento, di prigione e spesso di patibolo. Quelli che vi trovavano la morte venivano gettati dalla rupe in pasto alle volpi e ai corvi; una leggenda afferma che fu poi trasformata in una chiesetta dedicata a S. Michele dai duchi Antenori, uno dei quali, il gesuita don Gioacchino, vi fece costruire dietro un casotto laboratorio per i suoi esperimenti chimici. Il periodo degli Antenori, che va dal 1634 al 1811, fu il più ricco per il castello, che raccoglieva ricchezze e segreti. Dagli Antenori, poi, passò in proprietà prima ai Battaglia, quindi ai Fittipaldi.
Nel 1861 il castello vide la paura e nello stesso tempo la fermezza dei Brindisini, quando Borjes, Crocco e Di Langlois si unirono per compiere le note imprese nel territorio della Basilicata centrale.
IL CASTELLO DI CAMPOMAGGIORE
Il villaggio sette-ottocentesco di Campomaggiore Vecchio è una vera città abbandonata, dislocata su tre terrazzi principali lungo l’alto corso del Basento. L’antico villaggio fu fondato, come riportano i documenti, dalla famiglia Rendina nel 1741 da un antico feudo e da sedici coloni, ma fu distrutto da una frana il 10 febbraio 1885, costringendo tutti gli abitanti a trasferirsi in località "La Difesuola", dove oggi sorge il paese moderno.
Seguendo la strada che da Campomaggiore Nuovo conduce al paese vecchio si raggiunge il grande Palazzo Baronale, che mostra ancora le possenti mura e gli accenni delle grandi volte a vela. L'impianto sembra ricordare un castello medievale, attraverso cui si accedeva soltanto attraverso un portale che immetteva poi in un cortile quadrangolare sotto il quale corrono dei sotterranei ricavati nella viva roccia. Nella parte posteriore erano i depositi delle dispense e la cucina.
Vi è una storia che riguarda Campomaggiore e la sua città antica, ed è una storia molto recente che riguarda la zona vicina al castello, la Cornaleta.
La località è stata sempre conosciuta con questo nome, ma poiché si trova sul versante sinistro del Basento, in un punto in cui l’acqua forma un ristagno temporaneo, probabilmente deriva dal "carna-leta", cioè "carne marcescente".
Raccontano le leggende che il villaggio di Campomaggiore, che esisteva già nella metà del Duecento, ai tempi dell’insurrezione ghibellina contro l’imperatore Carlo I d’Angiò, venne messa a ferro e fuoco poiché si schierava a favore di Corradino.
Alcuni "alti cavalieri" si recarono una notte in Campomaggiore e presero tutti gli uomini che furono impiccati alla Cornaleta.
Nel corso dei secoli la Cornaleta fu sempre un luogo mal visto e pericoloso, poiché –raccontano i contadini- ogni tanto apparivano delle figure di fantasmi e delle voci che impaurivano persone ed animali. I bambini, che giocavano nei pestatoi del vino e dell’olio in pietra posti sulla sponda del Basento, venivano sempre ammoniti di non avvicinarsi alla Cornaleta.
Recentemente hanno affermato che tutto avveniva perché quei poveri ghibellini non furono degnamente seppelliti poiché restarono a lungo appesi agli alberi con il collo spezzato, in preda agli animali.
Solo da pochi anni non si sa più niente della Cornaleta, da quando il Sindaco di Campomaggiore volle far celebrare una messa in onore dei caduti per la libertà.
Oggi il meraviglioso paese di Campomaggiore Vecchio risorge dalle ceneri della vendetta e della sventura con più coscienza.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI CANCELLARA
Di Cancellara, nella storia, si conosce pochissimo. Dovremo trovare un documento che parla indirettamente del territorio di Cancellara a proposito di Brindisi di Montagna dove, intorno al 1535, una colonia di Albanesi provenienti da Corona (Grecia) ripopolarono il luogo in cui sorge un maestoso castello che si eleva su di una rupe rocciosa.
Il castello, di cui il nucleo più importante è formato da una torre a pianta quadrata, era precedente ad una riparazione del 1240 (reparari potest per homines) dovuta agli abitanti di Brindisi, Pietrapertosa, Trifoggio, Castelmezzano, Castel Bellotto, Campomaggiore, Trivigno, Lauricselli (Lauriosello, presso Cancellara), Accettura, Rodie, Gallipoli Cognato, Garaguso ed Oliveto.
Oggi il castello, in realtà una dimora baronale, si presenta con più corpi di fabbrica giustapposti ed un muro di contenimento, che fanno pensare ad un periodo di ristrutturazione nel XVI secolo.
Alcuni anziani raccontano che questo castello fosse più grande dell’attuale, in considerazione del fatto che ad esso, forse, si univa una cinta muraria che racchiudeva il paese e, quindi, riusciva a difenderlo. Sta di fatto che non è inusuale che si sia conservato solo la dimora principale, mentre le altre superfici furono adibite ad abitazioni private.
Si racconta che quando fu costruito il castello, l’architetto, ignoto, volle costruirne ben 365, numero che ricorda i giorni dell’anno. Forse perché così il barone poteva goderne la luce da ogni angolo.
A proposito della luce vi è un aneddoto molto interessante; pare che ancora oggi, qualcuno conosce una stanza del castello dove non compare per niente la luce. Molti hanno tentato di illuminarla, ma non c’è stato nulla da fare.
Alcuni abitanti di Cancellara pensano che ivi fosse l’inizio dell’Inferno e, per questo, non tutti pensano di trovarla per non finirci direttamente da vivi.
Oggi quasi nessuno conosce questa leggenda, che solo pochi hanno il privilegio di raccontarla.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI CASA DEL DIAVOLO
Vicino lavello ci sono dei ruderi che solo recentemente hanno ipotizzato fossero una terma romana. Nell’antichità, però, questi reperti monumentali vennero interpretati come i resti di un villaggio, che per l’imponenza delle mura doveva certamente possedere un castello vero e proprio.
La terma, realizzata con blocchetti in terracotta dal vivissimo colore rosso, furono sempre interpretati come una casa infestata dal Diavolo, forse anche perché nei sotterranei doveva scorrere un’acqua che, al tempo dei romani, veniva riscaldata. La tradizione, quindi, ricorda sempre la presenza dei diavoli nei siti abbandonati.
C’era una volta un ricco signore che per capriccio della sorte era diventato povero e spesso per disperazione diceva tra sé: “Venderei l’anima al diavolo pur di ritornare ricco come un tempo”.
Un giorno, mentre andava per una strada di campagna il diavolo si fece avanti e gli disse: “Tu vuoi diventare ricco? E io ti accontento; dammi in cambio la tua anima”.
L’uomo rispose: “Non solo la mia anima, ma anche l’anima di mia moglie”.
Il demonio si fregò le mani per la grande soddisfazione e fu pattuito che i due dannati dovessero vivere altri dieci anni. L’uomo infatti tornò ad essere ricco e campò felice e spensierato.
Ma quando stava per giungere il tempo in cui doveva consegnare al diavolo l’anima sua e di sua moglie fu colto da cupa tristezza. La donna, nel vederlo così cambiato, volle conoscerne la ragione e allorché seppe ogni cosa andò a riferirlo al confessore e questi le disse: “Stanotte tu e tuo marito mettetevi addosso l’abitino della Vergine e pregatela con tutto il cuore. La Madonna vi aiuterà”.
Essi così fecero. E mentre andavano a consegnarsi al diavolo, secondo i patti, videro sorgere davanti il santuario dell’Incoronata. Arrestarono il calesse ed entrarono. Terminata la loro preghiera e risaliti sul calesse, l’uomo si trovò accanto la Madonna al posto della moglie, senza che se ne avvedesse.
Giunti a destinazione, il demonio cominciò a sbraitare: “Maledetto, vattene! Mi hai portato la mia traditrice!”.
L’uomo che non si era accorto della prodigiosa sostituzione, rispose: “Dov’è mai il tradimento? Promisi di darti l’anima mia e di mia moglie ed eccoci a mantenere l’impegno”. Ma il diavolo come un ossesso non cessava di agitarsi e di sacramentare. Allora la Madonna si rivelò e disse: “Per questa volta siete salvi. Tu; ricordati che sei padrone dell’anima tua, non di quella della tua sposa. Non hai alcun diritto di cederla al demonio senza il suo consenso. Avanti, torniamo da lei che aspetta nella cappella”.
Il miracolato, sconvolto dall’emozione e incapace di profferire una parola di ringraziamento, spronò il cavallo. Giunti al santuario dell’Incoronata, la Madonna si sollevò in un fruscìo di seta per ricollocarsi nella nicchia e al suo posto egli riconobbe le sembianze della fedele compagna che aveva rischiato di buttare nelle braccia del diavolo per tre tomoli di ricchezza passeggera.
(di: P. Rescio)
IL CASTEL BELLOTTO
Al castello di Bellotto, presso Laurenzana, si presentò un giorno un turco riccamente vestito, su un cavallo così bello e perfetto che soltanto toccandolo ci si rendeva conto che non era un semplice animale.
Il nuovo arrivato giunse al feudatario del casale, si inchinò rispettosamente e disse: “Signore, anche se in questa bella e suggestiva Terra di Basilicata avete sicuramente visto tutto, non mancherete di osservare il cavallo che possiedo”.
Il signorotto si avvicinò, osservò l’animale e disse: “Vedo bene che il tuo cavallo è molto bello, ma non è paragonabile alle suggestioni della mia terra sia d’inverno che d’estate”.
“Certo, signore –disse il turco–, ma vedete… questo cavallo è in grado di portare il suo padrone in alto, in cielo…”.
“Se così è –disse il signorotto– dimmi quanto vuoi per questo cavallo”.
Il turco, allora, rispose: “Il cavallo glielo regalo, Signore, a patto che mi maritate con vostra figlia Flora”. “Nel mentre che rifletto, anche se sei così insolente per l’estrema pretesa, fammi provare il cavallo”. Salì in groppa, ed il cavallo iniziò a volare e a sovrastare il Camastra come un angelo.
Visitò paesi vicini e lontani alla sua terra; visitò prima Laurenzana, poi Albano, i boschi di Garaguso e di Salandra; in Puglia vide le Murge, in Calabria S. Donato, e poi oltre i mari conosciuti sino alla grande moschea.
Passò del tempo e il signore di Bellotto iniziò a stancarsi di quel viaggio; decise di ritornare, ma al posto del regno vide qualcosa di diverso: una grande città con case tutte attaccate l’un l’altra.
Si racconta che durante quel volo erano passati dei decenni, anzi secoli e il signore musulmano di Bellotto vide che parte degli abitanti dal buon cuore erano discendenti di quel turco e di sua figlia Flora, ma per gli altri l’odio imperava nella sua Terra di Lucania.
Fu così che il signore di Bellotto viene visto, ogni tanto, volteggiare fra le montagne in groppa al suo cavallo.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI CASTELGRANDE
Nella fortezza di Castelgrande c’era un castellano dalla barba rossa che aveva avuto dalla Natura due orecchi di asino. Egli non usciva mai dal bellissimo castello posto sul colle del paese per timore che i sudditi lo scoprissero e lo sbeffeggiassero, e ogni barbiere che andava a raderlo veniva regolarmente ucciso e buttato in una botola del grande castello.
Nessuno sapeva darsi ragione di queste misteriose scomparse e a nessuno veniva in mente che la loro sparizione avvenisse entro quelle mura. Costui, però, non avendo più barbieri da utilizzare, sino a quando non incontrò l’ultimo, un poverissimi barbiere padre di dodici figli. Il castellano ebbe così compassione ebbe compassione di ucciderlo e gli disse: “Bada che i tuoi colleghi sono morti per mano mia, perciò non rivelare ad alcuno quello che hai visto. Fai così e non ti verrà torto un capello”.
Il poveretto giurò e spergiurò che sarebbe stato più muto di un tricheco ma da quel momento divenne triste e pensieroso, essendo abituato a chiacchierare di questo e di quello con chi capitava; aveva paura che in un qualsiasi discorso gli capitasse di parlare del castellano.
Egli, addirittura, decise di non dire niente alla moglie, conosciuta in paese come molto loquace.
Non potendo dire nulla e morendo dal fastidio, il barbiere decise di andare presso una cava di pietra per sfogarsi tutto ciò che aveva accumulato in tanti mesi: “Il castellano Barbarossa ha gli orecchi d’asinooooo!”
Chiunque passava lì vicino leggeva sui muri della cava quelle parole e se la rideva così che, in breve tempo nel feudo si seppe che il feudatario si portava dalla nascita quella mostruosa deformità.
Non appena tale voce pervenne alla reggia Il principe si strappò un ciuffo di peli rossi dal dispetto e, supponendo che fosse stato il barbiere a tradirlo, lo fece arrestare e ordinò che lo cucissero vivo nella pelle di un somaro e lo portassero in giro per il paese fino all’ultimo respiro con una scritta sul collo: “A chi la lingua e a chi la spada”.
(P. Rescio)
IL CASTELLO DI CISTERNA
Nei pressi della Torre di Cisterna un contadino aveva una figlia bellissima e sempre allegra che si chiamava Giovanna ed era così spiritosa da rendere tutti lieti con la sua compagnia. Perciò veniva invitata alle veglie, dove raccontava storie curiose e inventava scherzi divertenti. Con la sua presenza e col suo aspetto diffondeva dovunque gioia e allegria.
Il padre era contento, ma stava anche in pensiero per il carattere troppo espansivo di quella sua sempre ridente figlia. Nella città vicina, invece, la figlia del Re, pur essendo bella, si mostrava sempre triste e scontenta. Nessuno aveva veduto fiorire neanche il più tenue sorriso sulle sue labbra, dalle quali non uscivano quasi mai parole di gioia.
Sospirava, alzando al cielo gli occhi velati di pianto. Invano il Re, suo padre, aveva chiamato a corte i più bravi buffoni, con la speranza che i loro scherzi la rallegrassero. La Principessa, davanti alle loro smorfie, diventava anche più triste.
Quando gli parlarono della bella ed allegra Giovanna, il Re pensò ch’ella forse poteva comunicare a sua figlia un pò di felicità. Mandò a chiamare il contadino, che sulle prime si spaventò. Temeva d’aver commesso qualche colpa e che il Re Io volesse punire; ma non trovando nulla da rimproverarsi, credette che la sua Giovanna avesse detto qualcosa d’offensivo nei suoi racconti. Era così sfacciata! Ma Giovanna si mostrò sicura di sé. “Non aver tanto timore”, disse al padre, “e se si tratta di me, fammi chiamare, e saprò come far ridere anche il Re”. Il contadino indossò l’abito migliore, si fece la barba, si pettinò e rigirando il cappello nelle mani si presentò alla Reggia. Venne accolto con rispetto, ma ciò non gli diminuì il timore, anche quando il Re gli rivolse affabilmente la parola: “È vero che hai una bellissima figlia? Dicono che sia veramente bella”.
“E intelligente...”, aggiunse il contadino. “E spiritosa...” continuò il Re. “Anche troppo” ammise il contadino, che si sentiva vicino qualche rimprovero. Pèrciò cercò di scusarla: “E allegra e scherza sempre e fa ridere tutto il vicinato”. “Proprio quello che voglio io” disse il Re. “Mandala corte, perché voglio che sia la damigella della Principessa”.
Al contadino sembrava di sognare e, quando fu in vista della sua casa, gridò alla figlia, che lo attendeva alla finestra: “Pulisciti bene e indossa il vestito delle feste. Il Re ti vuole le a corte per fare compagnia alla Principessa”. Giovanna accolse la notizia con un grido di gioia, e fece per avviarsi verso il castello di Cisterna.
Giunta alla Reggia, disse: “Avvertite il Re che ci sono io”. Dinanzi alla Principessa poi fece un inchino tanto buffo da farla sorridere. E poi la fece ridere, raccontandole quanta paura aveva avuto suo padre dinanzi al Re. Anche la Principessa si divertì ad ascoltarla. In pochi giorni divenne allegra, s’affezionò alla Giovanna e volle che fosse vestita come se fosse stata sua sorella.
Il contadino, a vedere la propria figliuola così elegantemente agghindata, ci godeva.
Passarono alcuni mesi e Giovanna temette che, chiusa nella Reggia, tanto lei quanto la Principessa potessero annoiarsi. Perciò propose alla Principessa di viaggiare, per vedere nuovi paesi, nuovi popoli, nuovi costumi. La Principessa ne parlò al Re, che proibì loro d’allontanarsi dalla Reggia. Due fanciulle sole, per il mondo! Sarebbe Stato uno scandalo.
Il Re restò sconcertato. Ma alla fine trovò che l’idea di Giovanna non era sbagliata. A chi sarebbe venuta la tentazione di ‘dar noia a venti fanciulle tutte uguali?’
Attraversarono campagne bellissime; visitarono chiese e castelli storici, girarono per molte città, seguite da sguardi sorpresi e curiosi.
Seguendo la gioia di Giovanna, tutti gli abitanti di Cisterna, alla fine, abbandonarono per sempre il castello.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI PIANI DI FEDERICO
Nei pressi di Lavello esiste una località che viene chiamata ancora oggi “Piani di Federico”, situata presso l’antica città di Gaudiano. Questo insediamento, nominato per la prima volta nel 1097, fu donato da Ruggero Borsa al Vescovo di Melfi, per cui si trovò sempre sotto le influenze del vescovo melfitano, pur restando in ogni caso un abitato prossimo a Lavello; questa dualità, di appartenere alla guelfa Melfi e di trovarsi in un territorio della ghibellina Lavello, costrinse Federico II a distruggerla, anche se i documenti angioini riferiscono ancora una certa vitalità. Si narra, infatti, come riporta Riccardo di San Germano, che nel 1228 “nel mese di maggio un certo casale della Puglia, detto Gaudiano, è in punizione, per comando dell'Imperatore, distrutto”, poichè dovette rifiutare le tasse dovute a Federico II per bandire la sesta crociata, tasse che nel mese precedente la distruzione, continua Riccardo di San Germano, furono dispensate dal pontefice Gregorio IX, “sotto pena di scomunica, che non si ardissero di dare alcuna cosa all'Imperatore o ai suoi Baiuli per riscatto, dazio o colletta”.
Ora, poco a nord della provinciale Canosa-Lavello, si sono conservati i toponimi di “Masseria Federico” e “Piani di Federico”, presso i quali l’imperatore possedeva un allevamento di cavalli, noto in tutta la Capitanata e nell’Apulia.
Tra questi Federico ne privilegiava uno dalla zampe snelle e dagli occhi grandi e intelligenti.
Poiché nei periodi di pace (ben pochi nel Medioevo!) Federico amava trattenerlo fra le praterie e i boschi del Vulture, in una passeggiata solitaria il cavallo incontrò uno scarabeo ferito poiché schiacciato da un altro animale, e se lo portò nella stalla.
Un giorno che un inserviente si accorse dello scarabeo, il cavallo volle difendere il piccolo animale che rischiava di essere abbattuto dalla pala del servo. Divennero così amici e così iniziarono a raccontare le proprie avventure. “Io –disse il cavallo– sono famoso”. Lo scarabeo, che non si sentiva da meno, disse: “Anche io sono famoso ed onorato”. E così passava il tempo tra la stalla e in groppa al cavallo nelle praterie.
Un giorno vennero a prendere il cavallo che fu tutto vestito in pompa magna, degno di un grande imperatore. “Anche io voglio essere vestito con le vesti d’oro!”, pensò il povero scarabeo. Il maniscalco, che aveva visto l’animaletto, come a rispondergli, disse: “Dove vuoi andare tu, che sei solo un insetto?” e quegli: “Anche io appartengo alla scuderia dell’imperatore”.
Il cavallo, che aveva visto tutto, cercò di consolare l’amico che, sentendosi offeso, andò via dalla stalla e si diresse fuori verso un piccolo orto. Si arrampicò su un fiore e vide un bruco tutto romantico che esclamò: “Com’è bello essere bruchi per poi diventare farfalle leggiadre…” “Non è vero, bruco sei e bruco resterai. Noi, invece, siamo scarabei, animali di razza”. “Allora prova a volare come faccio io!” –e il bruco volò via dopo essersi trasformato in una bellissima farfalla.
Il calabrone, che non poteva volare altrettanto delicatamente come la farfalla, se ne ritornò sconsolato nella stalla, dove nel frattempo era stato ricondotto il bellissimo cavallo amato dall’imperatore. Costui era stato sconfitto, per la qual ragione si era deciso di abbattere definitivamente le scuderie ed anche il cavallo.
Fu così che il calabrone e il grande animale, anche se con una vita diversa, furono accomunati da una ugual fine.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI SASSO DI CASTALDA
A Sasso c’era una volta un Re che amava moltissimo la caccia. Correva per i boschi tutti i giorni, sulle tracce della selvaggina, e si divertiva come un ragazzino. E tutti i giorni, entrando nel bosco, incontrava una veccha che gli tendeva la mano dicendo: “Una moneta, per l’amor di Dio”. Il Re non gliela negava mai, quella moneta. Anzi gliene aveva date già diverse centinaia. Un giovedì d’estate, mentre lei chiedeva l’elemosina, le disse: “Tu mi vai proprio a genio. Chissà che bella casa ti sei fatta, con tutti i soldi d’oro che ti ho dato. Ora vengo a vederla”.
“Ma le pare, Maestà! Io sono soltanto una povera vecchia che campa chiedendo l’elemosina. La mia casa non merita certo la visita di un Re”. “E tu invitami lo stesso”, disse il Re. “Andiamo, non perdiamo tempo”. “Come vuole. Ma non se la prenda con me se alla fine resta deluso”. Si misero dunque in viaggio. Dopo molte ore trovano un cancello aperto. “Eccoci, Maestà. E qui che abito io”. Entrarono in un piccolo giardino, sul fondo del quale c’era una palazzina semplice, ma pulita. Salirono per le scale e arrivarono a un ingresso con quattro porte. La vecchia ne aprì una. Dietro la porta c’era una piccola stanza e, nel mezzo, una ragazza che ricamava. Ma una ragazza tanto bella, che non ho parole per descriverla.
“Maestà”, disse la vecchia, “le presento mia figlia”. Il Re rimase a bocca aperta per lo stupore. Poi esclamò: “Brava! Non sei tu che devi chiedermi l’elemosina. Sono io che devo chiederti il permesso di parlare con questa tua figlia tanto bella”. Poi, senza perdere altro tempo, si mise accanto alla ragazza e cominciò a parlare con lei. Dopo pochi minuti era già innamorato pazzo e quando dovette andarsene, perché era ormai molto tardi, la chiese prima in moglie. Partito il Re, la vecchia domandò alla figlia: “Che cosa ti ha detto quel giovanotto?”. “Si è parlato di tutto”, rispose lei. “E poi, proprio prima di andarsene, mi ha chiesto di sposarlo”.
“E tu che cosa gli hai detto?”. “Gli ho detto che ero contenta di diventare sua moglie, se mi voleva davvero”. “Sei proprio una bella ingrata”, protestò la vecchia. “Avresti dovuto chiedermi il permesso, prima di impegnarti. Comunque, và pure. Non ti trattengo. Attenta però. Quando esci da casa mia, bada a portare via con te tutte le tue cose. Altrimenti saranno guai”. Detto questo, si allontanò buia in volto.
Passano otto giorni, ed ecco il Re con la sua carrozza, pronto a portare la moglie al Palazzo. La ragazza corse a vestirsi, si pettinò in gran fretta, e fece un bel mucchio del suo corredo badando a non dimenticare niente. Dopo un pò era tanto affannata, che le venne la voglia di darsi una rinfrescata al pozzo del giardino. Anzi, per lavarsi meglio, si tolse la collana di corallo rosa che portava sempre al collo, e l’attaccò al ramo di una quercia che stava lì vicino con l’idea di rimettersela subito. Ma poi finì per dimenticarsene, perché il Re continuava a chiamarla. Anzi, se ne andò senza nemmeno salutare sua madre.
Quando furono a metà strada, la ragazza si toccò il collo piena di spavento: “Mamma mia”, esclamò, “ho lasciato la mia collana di coralli su un albero del giardino. Torniamo a prenderla”. “Non pensarci neppure”, disse il Re ridendo. “Ho soldi abbastanza per comperarti non una, ma venti collane di corallo”. “Ma io devo avere proprio quella”, rispose la ragazza con gli occhi pieni di lacrime. “Mia madre mi ha detto che se lasciavo a casa qualcosa di mio, mi sarebbe successa una disgrazia”.
E tanto fece, che il Re ordinò alla carrozza di tornare dietro. La sposa corse nel giardino, trovò la collana appesa all’albero come l’aveva lasciata, e se la mise subito, con un grido di gioia. In quell’istante, il cielo sereno diventò nero di nuvole, e un tuono fece tremare gli alberi vicini. “Mamma mia”, gridò la ragazza. E non aggiunse altro: la sua testa era sparita. Al posto del bellissimo viso che aveva conquistato il Re, c’era adesso una testa da pecora, con la lana fitta e riccia. “Povera me”, pianse la ragazza “ecco il frutto della mia disobbedienza”. E corse subito dalla madre a mostrarle cos’era successo. “Te n’eri andata via?”, domandò la madre. “Si, lo ammetto”, disse la figlia. “Sono partita lasciando indietro la mia collana, e guarda come sono conciata. Ti prego, aiutami a rimediare!”.
“Ormai è fatta, e io non posso più farci niente. Ti sei comportata male. Dovrai tenere questa tua testa da pecora in punizione per il resto dei tuoi giorni”. Pianti e lamenti non bastarono a farle cambiare idea. Per tranquillizzare la figlia, la vecchia le offrì uno scialle di lana perché si coprisse almeno la testa ed evitasse di mostrarsi subito al Re in quello stato”. La ragazza risalì dunque in carrozza, e sedette accanto a Re conciata com’era, coprendosi la testa con lo scialle. Lungo la strada il Re dice: “Questo scialle non mi piace proprio. Che fai così conciata?”. “Ho un gran freddo”, disse la ragazza. “Ho preso lo scialle per coprirmi la testa”.
Ma quando arrivarono al Palazzo, non ci fu più verso di tenere nascosta la disgrazia. Sicché la corte cominciò a presto a farsi gioco della nuova sposa, e il Re si stancò di lei perché non era più bella come quando l’aveva conosciuta. Ma ormai aveva dato la sua parola, e celebrò le nozze con la ragazza come aveva promesso. Intanto però non poteva certo dire di essere soddisfatto. Camminava per i corridoi del castello con la faccia dura, scuro in volto e sempre arrabbiato. Un giorno, per paura che si ammalasse, la Regina, sua madre, gli disse: “Se vuoi tenere Testa di pecora così com’è, tienila pure, e non badare alle chiacchiere della corte. Ma se vuoi sbarazzarti di lei, insegnerò io come devi fare. Ci sono tante donne nel noio regno, non sarà difficile trovarne un’altra di tuo gusto”. “Magari potessi”, sospirò il Re. “È lei la mia sposa, come osso mandarla via?”.
“Ecco come”, disse la Regina. “Prendi le due donne più belle che trovi nel Palazzo, e mettile con Testa di pecora. Poi dai un cagnolino ad oguna di loro. Quella che ti porterà il agnetto più bello, tra sei mesi, sarà la tua nuova sposa”. Il Re accettò il consiglio. Le due rivali trovate dal Re ingozzarono i loro cuccioli di cibi delicati, li spazzolavano e li profumavano notte e giorni. Sei mesi più tardi, il Re volle vedere i tre cagnetti. I primi due erano grassi come vitelli. “Cagnacci”, disse il Re. “Dateli al contadino, non sono roba per me”. Ma quando vide il cucciolo di Testa di pecora, che era rimasto piccolo e magro, provò un gran piacere.
Si celebrarono di nuovo le nozze, si mangiò a crepapelle, e i due innamorati vissero sempre felici e contenti.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI TORRE DEGLI EMBRICI
Quando nacque l’erede al castello di Torre degli Embrici, presso Rivonigro, il Re ordinò di chiamare una fata dei boschi perché predicesse il futuro del neonato. Dopo aver osservato il piccolo, la fata non si decideva a pronunciare parola.
“Darei qualsiasi cosa per compiacervi, maestà. Purtroppo gli astri sono confusi. Non posso dirvi nulla... Sembrerebbe che il Principe debba correre un grande pericolo quando compirà i diciotto anni ma non è sicuro... Forse sarà ucciso da un cervo”.
“Sei sicura di quello che dici?”
“No, maestà. È tutto molto confuso”.
Dopo aver detto questo, la fata si ritirò, lasciando il Re solo con il figlio.
Passarono gli anni e il piccolo crebbe sano e robusto. Come il padre dimostrava una grande passione per la caccia.
Un giorno, al suo diciottesimo compleanno, il principino volle andare a caccia da solo; il padre lo avvertì del destino predettogli dalla maga. “Ammazzarmi? Non temere, non potrebbe mai accadere”–disse al padre.
Quella notte, durante il sonno, il Principe ebbe l’incubo; sognò che un enorme cervo, con corna lunghe e affilate, si precipitava su di lui senza dargli il tempo di difendersi.
Si svegliò in un bagno di sudore. Le parole di suo padre l’avevano preoccupato più di quanto non volesse ammettere. Il sogno si ripeté quasi ogni notte, finché, un giorno, il Principe decise di porre fine alla cosa. Senza avvertire nessuno, prese l’arco e le frecce e si avventurò nella foresta. Camminò a lungo, attento a quello che lo circondava. C’era un silenzio innaturale, non si udiva cantare nemmeno un uccellino. “Questa zona sembra maledetta” –disse il giovane.
Arrivò presso un lago gelato. Saggiò la consistenza del ghiaccio e con delle scarpe pesanti si apprestò a raggiungere l’altra riva. Non aveva percorso che un centinaio di metri quando, alla sua sinistra apparve un enorme cervo simile a quello del sogno.
“È mio!”, esclamò il giovane, incoccando una freccia nell’arco. Ma l’animale fuggì correndo e il Principe si lanciò all’inseguimento La caccia durò più di un’ora. Alla fine il cervo scomparve nella macchia. Intanto il Principe si ritrovò a pensare: “Perchè provocare il destino! Non sarebbe meglio ritornare a palazzo e chiedere aiuto?” Poi, deciso, esclamò: “No. È un problema che devo risolvere da solo”.
Tornò sui suoi passi e seguì le orme del cervo. Si avvicinò con cautela alla macchia dove si nascondeva e...”Benvenuto, Principe. Ti stavo aspettando”. Di fronte a lui si ergeva un uomo e robusto. Non aveva altre armi che un piccolo pugnale legato alla tunica. Aveva un portamento alto e abiti preziosi. “Stavo inseguendo un cervo e…”
“Non lo catturerai. L’ho visto trasformarsi in allodola e fuggire. Gli ho detto che volevi ucciderlo”.
“Ti ha parlato?”
“Certo! Sai chi sono io?”
“No, spero che tu me lo dica”.
“Sono il Re di tutti i territori e sono felice che tu sia qui, perché ho tre figlie da maritare. Vuoi conoscerle?” Il Principe acconsentì.
“Devo avvisarti che correrai gravi pericoli. Dovrai vegliare, un’intera notte il sonno di mia figlia maggiore. Io, ogni ora, passerò a chiamarti. Se ti troverò addormentato, sarai giustiziato. La stessa prova dovrai superarla con le altre due figlie. Se sopravviverai, sceglierai quella che preferisci.
“E se dopo aver superato la prova, non volessi sposarmi con nessuna?”
“Sarai libero di andartene. Se deciderai di sposarti dovrai superare altre tre prove, prima delle nozze. “Daccordo, andiamo”.
Si diressero verso un enorme palazzo dove il Re presentò al Principe le tre figlie. Erano davvero molto belle. Dopo cena si diede inizio alla prima prova, Il Principe andò nella stanza della maggiore, dove campeggiava un’immagine sacra. “Mia madre non vuole che noi ci maritiamo”, disse la Principessa, “perciò ha messo del sonnifero nei tuoi cibi. Non potrai resistere al sonno”.
“Mi si stanno già chiudendo le palpebre. Debbo fuggire! Il castello é circondato da guardie”, disse il poveretto. “Io pregherò per te, vedrai che andrà tutto bene. Ora riposa”.
Infatti, il Principe riuscì a non addormentarsi e il Re dovette ammettere la prima vittoria.
“Hai superato la prima prova. Te ne mancano ancora due, non dimenticarlo!”
La seconda Principessa era bella quanto la prima e anche nella sua stanza c’era un’immagine sacra. “Pregherò per te e avrai salva la vita”, disse la giovane. Il principe era molto più stanco della sera precedente. Fece sforzi incredibili per non dormire e, aiutato dalle preghiere, ci riuscì. La notte seguente, il Principe raggiunse la terza Principessa. “Dopo i suoi insuccessi”, –disse la più giovane— la mamma ha rincarato la dose di narcotico”.
“Pregherai per me?”
“Sì, e ti parlerò tutta la notte. Voglio sapere molte cose di te”. Infatti, il Principe non sentì la necessità di dormire e passò il tempo conversando amabilmente.
“Mia madre non sopporta i nostri pretendenti. Nessuno le sembra degno di noi. Nostro padre è un grande mago e vuole un erede. Così, poiché il regno confina con il nostro, ha deciso di unire le nostre terre. “E perché hanno messo il narcotico nei cibi?”
“Vogliono un uomo particolarmente forte”.
“Tuo padre può trasformarsi in cervo?”
“Certo, e per attirarti qui ha chiesto ad una fata amica di predire il futuro nel modo che sai.
“Sei la più bella e dolce fanciulla che io conosca Vuoi sposarmi?”
“Con tutto il cuore”.
I due giovani passarono le ore a fare progetti per il futuro. Il mattino seguente, il Re disse: “Mia figlia minore ha dichiarato che vuoi sposarti con lei. Ora devi dimostrarti degno di lei e superare le tre prove.
“Che debbo fare?”
“Dietro al palazzo c’è un fitto bosco, pericoloso per tutti. Voglio che tu lo abbatta in un solo giorno. Avrai a tua disposizione degli attrezzi di cristallo”. “Dovrò morire se non ci riesco?” “No, dovrai tornare al tuo regno da solo”. Deciso a provare, il Principe iniziò la prova, naturalmente, gli attrezzi di cristallo si ruppero immediatamente. Stava già dirigendosi dal Re, per ammettere la sua sconfitta, quando giunse la giovane Principessa. “Non disperare. Ti ho portato qualcosa da mangiare. Il Principe accettò e dopo un boccone cadde addormentato. Subito la Principessa estrasse un fazzoletto e facendo tre nodi disse: “Lavoratori, a me! Ho bisogno di voi”. Immediatamente, dagli alberi, sbucarono mille nanetti provvisti d’asce ed in pochissimo abbatterono tutti gli alberi del bosco.
Il Principe si risvegliò e guardò ammirato.
“Come hai fatto?”, domandò alla Principessa.
“Ho ereditato i poteri magici da mio padre. Non dire a nessuno che ti ho aiutato”.
Il giovane si presentò al Re. “Il bosco é stato tagliato, signore”. Il Re guardò e dichiarò: “Sei un giovane straordinario. Ma non posso ancora concederti la mano di mia figlia. Devi superare altre due prove. Hai visto lo stagno di fronte al palazzo? Devi ripulirlo del fango che copre il fondale. Poi, lo riempirai con dei pesci. Prendi questa pala di cristallo per compiere il lavoro”. Il giovane, rattristato, si diresse allo stagno. Era certo di non riuscire nell’impresa.
Dopo pochi minuti, la fragile pala si ruppe. “Che posso fare?”, si domandò. “Non preoccuparti, Principe –lo incoraggiò una dolce voce,– Ti portato uno spuntino. Mangia e riposati. I miei amici ti aiuteranno”.
Il Principe si addormentò e la giovane chiamò i nani; i piccoli amici della Principessa fecero il lavoro in un batter d’occhio. Quando il Principe si risvegliò, l’acqua dello stagno era limpida e si potevano vedere molti pesci nuotare allegramente. “Ho compiuto la seconda prova” disse orgoglioso il giovane.
“Bene. Ti manca un’ultima prova; devi spianare una montagna qui vicino e costruire un palazzo, completo di tutto, pronto per essere abitato. Hai un giorno di tempo”.
Come le altre volte, l’opera dei piccoli uomini fu precisa e veloce. In, di un giorno fu costruito un palazzo meraviglioso. Tutta la corte si trasferì nel nuovo castello e nessuno poté nascondere gioia e allegria. Fu dato un grandioso banchetto e finalmente il Re dette al Principe la sua sposa.
(di: Pierfrancesco Rescio)
IL CASTELLO DI CASTELLUCCIO
Il centro di Castelluccio è uno dei più caratteristici ed interessanti borghi antichissimi della Basilicata che si sviluppano sul versante settentrionale del Parco del Pollino. Località dalle origini molto remote, si ritiene che fosse già esistente intorno al X sec., pare che un tempo fosse un unico insediamento, mentre oggi ne esistono due che distano fra loro poco più di due chilometri. Entrambi, oggi chiamati Inferiore e Superiore, conservano la Chiesa di S. Maria delle Grazie, il Convento dei Francescani, la Chiesa di san Nicola di Myra, il mulino ad acqua e la Chiesa della Madonna della Neve e della Madonna del Soccorso, mentre quello Superiore, invece, conserva la bella Chiesa di S. Margherita e, ovviamente, i ruderi del Castello.
Proprio da questo inizia la storia.
La leggenda narra di due famiglie sconosciute che si contendevano la proprietà dell’antico castello baronale. A chi fosse appartenuto non sappiamo, ma certo è che le due famiglie da secoli pensavano che fosse dell’una o dell’altra.
Finalmente accadde il gran giorno del matrimonio fra i rampolli delle rispettive famiglie e tutto, per molti anni, tornò normale con mai era accaduto sino ad allora. Ma non durò poi così tanto.
La giovane sposa era conosciuta come una fanciulla casta e pudica che non era stata mai vista da alcuno in paese, se non coperta da un velo quando, di domenica, tutti frequentavano la Chiesa di Santa Margherita. Un giorno accadde che quel velo cadesse dal volto della giovanetta e tutti volgessero lo sguardo verso di essa.
Era di una bellezza straordinaria, così incantevole che tutti, in paese, mormoravano e si chiedevano come mai il brutto marito fosse stato così fortunato.
Come accade in ogni paese dove anche i muri hanno orecchie, il giovane baronetto venne a sapere della storia e decise di rinchiudere per sempre la giovane sposa in una torre alta, quella che serviva ad avvistare i nemici, la più irraggiungibile. La poverina fu laaora ripudiata, e ripresero le ostilità tra le famiglie per la contesa della fortezza di Castelluccio Superiore.
Vennero anche realizzati due veri e propri gruppi che si contendevano il territorio di Castelluccio, e fu così che, da allora, le due città vennero distinguendosi e furono separate.
Da allora si racconta che più volte, nei pressi del castello, si sentono alcuni soffi di vento, che a volte si confondono con le voci umane, e pare di sentire ancora i sospiri della giovane sposa, che morì rinchiusa per sempre nella fortezza.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI CASTELMEZZANO
Anche la storia di questo antico castello deve fare riferimento alle vicende della vicina Pietrapertosa. Si racconta che questo insediamento, posto a quasi 890 metri di altitudine, prima che fosse assoggettato dai romani era collegato ad una strada nei pressi del “Camentum” o “Casuentum”, ossia del Basento, diretta verso la valle del Salemme, e che quest’area fu percorsa da Annibale per sposarsi da Grumento antica a Venosa.
Un’altra tradizione, più accreditata, accenna alla contrada Piani, che fu distrutta dai Saraceni nel 1031. Queste zone, che insieme a Pietrapertosa hanno restituito materiali archeologici del VI e V sec.
a.C., furono abitate poiché naturalmente difese dalle rocce ed erano chiamate “arm”. In una di queste “arm”, chiamata Maudoro, vivevano pacificamente alcuni abitanti, che intorno al 900 d.C. furono conquistati dagli arabi di Pietrapertosa.
La storia, vera e propria leggenda, narra che le continue scorrerie dei Saraceni non dettero più pace e tranquillità alla popolazione di Maudoro, che più volte fu costretta a difendersi accanitamente, facendo rotolare pezzi di roccia naturale verso il fondovalle. Studiosi locali affermano, inoltre, che queste “armi naturali” indussero a chiamare quei luoghi “ARM”, indicando appunto tutta la catena delle Dolomiti Lucane.
E qui continua ancora la leggenda. Un certo pastore di nome Paolino sino ad allora era stato abitante di Maudoro e poi di un luogo più sicuro detto “Arm Gervasio”. Questo “Arm Gervasio” era piccolo per gli abitanti, che possedendo non poche pecore avevano penuria di aree per un ottimo pascolo. Mentre portava il suo gregge, si accorse che questo seguiva una strada sino a quel periodo non conosciuta, ma che certamente gli antichi Greci conoscevano alla perfezione; si era addentrato nella parte più orientale poiché più ricca di verdi pascoli, ormai abbandonata da chissà quanti secoli. La bellezza del luogo e la ricchezza dei pascoli indusse Paolino a trasferirsi dall’Arm Gervasio, fondando Castelmezzano, poiché tutti gli abitanti vollero seguirlo in questa nuova colonizzazione, probabilmente riferibile ad epoca molto antica. La verità su questa leggenda sta nel fatto che nell’antichità molte aree della Basilicata erano abbandonate da secoli e numerosi abitanti e monaci vollero sperimentare nuove aree per metere a colture terre dove erano presenti i boschi.
Paolino, quindi, fu il primo abitante di Castelmezzano ed oggi il luogo dove egli dimorava in una grotta prende il nome di Rampa Paolino, accessibile mediante una gradinata, mentre nell’Arm Gervasio fu abbandonato il castello, quello che viene considerato la fortezza di Castelmezzano.
Il nome di Gervasio derivava dal monaco Gervasio, che dopo aver costruito il castello ed una piccola cappella rupestre, scese più giù seguendo il pastore Paolino insieme a tutti gli altri.
(di P. Rescio)
 IL CASTELLO DI LAGONEGRO
IL CASTELLO DI LAGONEGRO
Del castello di Lagonegro oggi non rimane alcuna traccia. Dovette essere costruito dai Normanni, su una rupe denominata Castello, di forma quasi circolare, e quindi facente parte di un nucleo abitato più antico, che poi venne abbandonato durante il popolamento del nuovo borgo.
Sui margini di questa rupe, infatti, furono costruite nel medioevo delle grosse mura di cinta, nel cui circuito vi erano altre torri semicircolari di cui due sono tuttora in piedi, mentre l'altra è completamente distrutta.
Il castello sorgeva sulla vetta della rupe, ma dopo che nel 1552 i Lagonegresi pagarono con un riscatto la loro libertà, furono essi stessi a disperdere le tracce materiali del feroce dominio feudale e ad evitare che un nuovo barone si insediasse nella fortezza. I cittadini pensarono di abbattere fin dalle fondamenta il superbo e temuto palazzo del Barone, e non fu mai permesso a nessuno di fabbricare su quel suolo.
L’area del palazzo rimase nei secoli come piazzetta pubblica e luogo di riunione e di passeggio, finché nel 1858 fu adattata a necropoli ed i sotterranei del palazzo furono utilizzati come sepoltura ed ossario comune.
L’odio dei Lagonegresi verso la tirannia feudale era notoriamente triste: il più crudele fra tutti i signori di Lagonegro fu Gian Vincenzo Carafa.
La tradizione vuole che il Carafa, feudatario del castello, in esso avesse riunito i più scellerati uomini della zona, per farsi aiutare nelle sue imprese e scorribande nel territorio e nella città, senza essere punito da alcuno. Tra i tanti uomini fedeli ed assassini si ricorda un certo Mangaretto “il basso”. Costui non solo angariava i poveri sudditi, ma fece costruire al centro del maestoso cortile del Castello, una specie di torre-vedetta, sulla quale era possibile guardare se nei dintorni vi fosse una pattuglia di cavalieri o poliziotti.
Accadeva, però, che lo stesso Mangaretto si comportasse quasi da padrone del feudo, infischiandosene anche del Barone Carafa, che non poteva nulla contro la prepotenza del suo scagnozzo.
Fu tanto l’odio e l’invidia del Carafa verso lo stesso Mangaretto il basso, che ideò uno stratagemma per ucciderlo. «Carissimo Mangaretto, vieni da me, che voglio regalarti una parte del paese, così che anche tu possa godere del mio regno per sempre». Lo fece sporgere dalla torre-vedetta e, in un attimo, scaraventò l’assassino che realizzò al tonfo un lago di sangue nero. Si dice che nel punto dove Mangaretto cadde nacque un roveto che nessuno è mai riuscito a togliere.
Quando il castello venne abbattuto, i Lagonegresi circondarono il roveto con un circolo di novantadue pietre, cioè il numero dei delitti di Mangaretto il basso.
Un’altra tradizione, però, riporta che in questo castello dimorò la famosa Mon-na Lisa, la famosa Gioconda dipinta da Leonardo da Vinci.
IL CASTELLO DI LAURENZANA
All'estremità del paese, sopra una rupe, spicca il grande castello di Laurenzana. Narra una leggenda che, intorno all’anno mille, giunse a Laurenzana Muettin del Merlo, uno dei tanti piccoli vassalli dell'Italia meridionale, probabilmente proveniente dall’insediamento arabo di Castelbellotto. In Laurenzana non trovò nessun castello e, poichè invidioso degli altri vassalli più potenti i quali già avevano un loro palazzo od una loro fortezza, si prodigò affinchè la sua diventasse la più ardita e spettacolare. A tal proposito si racconta che mancandogli i fondi per tale impresa, Muettin organizzò una banda e cominciò a far rapine nel territorio, sino a quando non potè iniziare i lavori; questa storia dimostra che anche all’epoca i signori erano, a volte, a corto di denari, e non disdegnavano di procurarsene con qualsiasi mezzo, anche e soprattutto illecito.
Nel punto scelto per la costruzione, un cocuzzolo quasi inaccessibile se non attraverso un ponte, viveva un vecchio eremita, custode di un immenso tesoro. Muettin, feroce e ormai fissato, non si curò affatto delle parole dell'eremita, il quale lo aveva ammonito che quel tesoro era sacro e e avrebbe portato maledizioni a chi lo avesse toccato. Uccise l'eremita e, dopo averlo seppellito. cominciò a scavare le fondamenta della poderosa fortezza intorno alla tomba del vecchio eremita.
Ma ogni giorno, uno per uno, gli operai di Muettin, spinti da una forza soprannaturale, andavano a uccidersi sulla tomba dell'eremita; ogni notte Muettin sentiva sempre la stessa voce che gli diceva:«Muettino, Muettino, oggi un altro se n’è andato; gira gira il tuo castello dovrai fartelo da solo; lo farai superbo e bello, ma da solo ci starai, finché ultimo morrai».
Quasi in preda alla pazzia, Muettin, morti tutti i suoi sudditi, continuò a lavorare da solo il suo castello e, giunto al termine, salì sul punto più alto per ammirare la sua opera; mentre contemplava il villaggio ai suoi piedi, la voce parlò ancora:«Muettino! Muettinooo! Vieni, vieni da me!». Il musulmano iniziò a tremare, ma non voleva seguire la voce. Ad un tratto, ecco che si sentì spinto, si voltò e vide che alle sue spalle erano cento mani di scheletri.
Fuori di sé, ormai, corse forsennatamente per il cortile del castello per più giorni, senza mai fermarsi; con il passare del tempo Muettin dimagrì, sino a non avere più pelle, carne, od ossa. Alcuni dicono che la sua ombra oggi corre ancora dentro quel castello.
In seguito l’imponente costruzione passò in mano ad altri feudatari che persero la memoria infelice del castello. Nel corso del XV sec. appartenne agli Orsini del Balzo, nel 1496 ai Poderico e nel 1510 dei Filangieri.
IL CASTELLO DI LAVELLO
Una leggenda tramanda che un certo Arnolino, "lombardo", al quale venne affidata Lavello durante la spartizione del Regno normanno avvenuta a Melfi, costruì la prima fortezza della città.
Oggi si presenta come una costruzione quasi quadrata, robustissima, con un vasto cortile centrale, di probabile costruzione angioina. In origine aveva due ingressi: uno a nord (ora murato) e l’altro, ancora esistente, ad ovest. Vi erano cinque finestre al primo piano e quattro al pianterreno; sette finestre al primo piano e sei a pianterreno nella facciata di prospetto. Il loggiato dell’angolo Sud, con soli tre archi, fu aggiunto successivamente, come ancora dopo fu costruita la torre all’angolo nordovest; certamente l'uno e l'altra insieme alla "scarpa" per ragioni di innovazione nelle tecniche costruttive.
In seguito furono adattati i balconi al posto delle finestre e ricostruito il loggiato con cinque archi.
Ad Arnolino la tradizione fa pure risalire la costruzione di due gallerie sotterranee; si racconta che una di queste trovi l’uscita molto lontano dal castello e fuori dall’abitato di Lavello, in una contrada chiamata Fontana dell'Orso; probabilmente serviva da cunicolo per gli abitanti del castello, in caso di estremo pericolo, ma sembra che il rinvenimento di alcuni scheletri e di armi, verso l’estremità della galleria, sembra riecheggiare altri eventi più oscuri.
L’altra gallerie, invece, si dirigeva al di sotto di una chiesa e, attraverso di essa, passavano le giovani spose sulle quali il signore del castello usava del suo diritto della prima notte.
Una tradizione vuole che un certo signore del castello, conosciuto come Bassettino, pretendeva che le giovani spose lungo il percorso sotterraneo si denudassero lentamente e per ogni indumento lasciato cadere ne dicessero il nome e quindi aggiungessero: "Ecco, o mio Bassettino, ecco a te vengo, son tua; già pronto è il mio petto per te".
Le fanciulle dovevano arrivare alla fine della galleria già nude, quindi entravano in una camera da letto arredata sontuosamente, ma alle cui pareti erano esposti dipinti scandalosi.
Accadde, però, che un giorno erano già pronte, ma Bassettino non riuscì a concludere la sua notte d’amore, perché bastò che la prima e la seconda sposa raccontassero la loro esperienza e dimostrassero che erano uscite così come erano entrate, perché tutte le altre spose, facessero finte di concedersi a quel diritto che Bassettino non era in grado di prendersi.
Si racconta, inoltre, che il Bassetino ne avesse uccisa qualcuna per odio verso le donne, ed ecco perché il cunicolo sembra essere ricolmo di scheletri.
Il castello di Lavello, oggi sede del Municipio, conserva anche una stanza senza porte: A tal proposito si racconta che solo da una piccola finestra si può vedere l'interno della stanza, completamente spoglia di qualsiasi arredo.
La leggenda tramanda che uno dei signori del castello, ancora nel pieno della sua giovinezza, stava per morire; durante l’agonia, arrivò una specie di mago che gli disse: "Scommetto che tu vuoi vivere, è vero? Poiché sono un mago buono, ti accontenterò; però tu devi far questo: devi costruire una stanza senza porte e con una sola finestra, ma che sia piccolissima. La devi costruire tu dall’interno e, se ne saprai uscire, vivrai ancora per cento anni".
Il signore stava per morire perciò, senza paura e con coraggio, si alzò dal letto e costruì la stanza in brevissimo tempo, ma dopo aver terminato, il mago lo incitò: "Pensaci, e vedrai che è facilissimo uscire; pensaci!". E il signore si mise a pensare, a pensare, mentre il mago continuava ad incitarlo dicendogli: "È facilissimo!". Ma il signore non riusciva e allora il mago, gli disse come doveva fare. E il signore: "Come sono stupido! Era così semplice! Grazie, mago!". E uscì; ma non volle dire a nessuno la soluzione datagli dal mago. E così lasciò tutti con il desiderio di conoscere la soluzione dell’enigma.
IL CASTELLO CERVARIZZA PRESSO PALAZZO S. GERVASIO
A sudest di Palazzo San Gervasio, sede di un glorioso castello, sorgeva il villaggio di Cervarizza o Cervarezzo (Cervaricium).
Risulta dai documenti che l’antico casale apparteneva nel Duecento alla Badia di Santa Maria di Banzi. Esso era quindi un villaggio a sé stante con una propria fortificazione. Poiché era sito in “un luogo la cui aria non era affatto salubre”, avveniva che gli abitanti soffrissero la malaria ed avvenivano numerose morti; così, piano piano, la popolazione si spostò in un luogo più salubre: “ne’ vecchi tempi”, si legge in un atto notarile del 1755, “il castello o casale popolato osservandovi tuttavia la vestigia de' caduti edifici e rimaneva Cervarizza alle cinque miglia distante da Banzi e circa un miglio e mezzo da S. Gervasio o sia Palazzo”.
Anche in questo sito abbandonato e sperduto della Basilicata conserva una storia così lontana nel tempo, che non si ricorda neanche il periodo.
Raccontano i contadini che a Cervarizza sorgeva un importante castello lungo la strada che conduceva a Gravina in Puglia. Qui viveva il barone che, servito da due monaci, governava la popolazione con cattiveria e spregio per la vita, chiedendo tasse ed approfittando di qualsiasi fanciulla poiché esercitava lo jus primae noctis. Un giorno, passeggiando verso il paese, incontrò uno dei suoi monaci che gli rivelò una curiosità. La figlia di Mastro Giuseppe, bellissima fanciulla, veniva sempre nascosta al passaggio del barone affinché egli non la conoscesse.
Il barone di Cervarizza, furbo e cattivo, inviò l’altro monaco a casa di Mastro Giuseppe per chiedere della ragazza. Il povero padre non seppe che rispondere all’evidenza, ma non sapeva come fare per sottrarre la figlia a quel mostro. Gli venne un’idea: travestirsi con gli abiti della fanciulla e fare un affronto allo stesso barone, odiato da tutti.
Prese le vesti della ragazza e si armò di tutto punto. Entrò nel castello di notte, in tutta fretta. “Entra, figlia di Giuseppe, entra in questo Paradiso!”, disse il barone. La “fanciulla” si accostò al barone ed infilzò la lama nella pancia dello sventurato. “Tradimento!”, gridò. Accorsero i monaci servi del barone e videro le vesti della fanciulla, lì per terra. Tutti i lacché del barone videro la stanza in un lago di sangue e le vesti trattenute per le mani dal cattivo.
Nessuno intervenne per soccorrere il morente, e anche i sacerdoti furono presi e scacciati a pietrate dal paese di Cervarizza.
Fu allora che Mastro Giuseppe e sua figlia divennero eroi del paese, che per odio decise di trasferirsi in altro luogo, “più salubre” di quell’aria respirata dal barone.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI FORENZA
Nel grande castello di Forenza abitava una fanciulla graziosa, virtuosa, che viveva spesso da sola, essendo suo padre sempre in battaglia alla difesa dello stato angioino. Erano stati in molti a chiederla in sposa per le sue doti fisiche e il suo buon cuore ma ella non si sentiva pronta al matrimonio.
Una sera, mentre pregava, si avvicinò un giovane biondo e bello, che con acconce parole a modo tentò di distoglierla dalla preghiera. La ragazza, turbata, si raccomandò alla Madonna e per sfuggire alle lusinghe di quell'uomo lo pregò di tornare un altro giorno.
Rimasta sola scoppiò in pianto e chiese aiuto alla madre, morta da anni, la quale apparve prontamente e le disse: “Figlia mia, fatti coraggio. Sappi che chi ti si è presentato in belle fattezze è proprio il diavolo. Se vuoi tenerlo lontano, devi ricorrere a questa astuzia: quando tornerà, metterai sul fuoco una casseruola con dentro l'olio e col pretesto di dover friggere lo pregherai di attizzare la fiamma. Non appena l'olio comincerà a bollire, glielo butterai addosso e vedrai che scom-parirà”.
La principessina ringraziò la madre e giurò di fare ciò che le aveva consigliato. La sera successiva, allorché il demonio si affacciò sul-l'uscio per rinnovare la sua dichiarazione, ella lo pregò di aiutarla ad accendere il fuoco in modo che potesse preparargli da mangiare. L'ospite, ben contento di quell'invito inatteso, si mise subito all'opera soffiando e gettando frasche nel camino con tale foga da diventar rosso come un pomodoro.
Finalmente la fanciulla credette che l'olio fosse abbastanza caldo e approfittando di un momento in cui il messere stava con la testa in giù, glielo rovesciò addosso. Ma, non appena il diavolo avvertì la tremenda bruciatura, emise un grido e, per il timore di essersi ridotto peggio di un tizzone, con gran frastuono sprofondò sottoterra.
Giunto urlando all'inferno, i compagni più premurosi gli andarono incontro e gli domandarono: “Chi ti ha conciato in tal modo?”. Quegli raccontò a mezza bocca l'accaduto e della cattiveria della fanciulla di Forenza.
Ma il giorno successivo volle vendicarsi. Si trasformò in una dama di corte e si presentò al castello dicendo che era la moglie vera di suo padre. La fanciulla cadde in disperazione e non sapeva come fare per liberarsi della nuova verità. Ma il fato volle che all’interno del castello vi fosse una cappella dove era venerata la Vergine Maria, la quale volle salvare la vergine mostrandole, per caso, la veste della donna.
Apparve la coda del diavolo, che venne bruciata definitivamente da un candelone, già acceso, posto dentro l’edificio sacro. Le di dolore furono così forti che il povero diavolo sprofondò per sempre nell’abisso. La fanciulla divenne forte e coraggiosa, come a dire :
Quann’ la fémin’ vòl fa
fac’ chióv’ e nivicà
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI GALLIPOLI-COGNATO
Nelle colline del bello e suggestivo Parco Forestale di Gallipoli-Cognato gira voce che non bisogna mai raccontare i sogni.
In particolare, si racconta che nel parco si aggiri un vero e proprio folletto; pare che sia uno spiritello alto un palmo e mezzo con tanto di ventre e un cappello largo ed appuntito, che la notte si accoccola sul petto degli uomini e delle donne presi di mira. Allorché si parla di oppressione e di soffocamento è appunto lo Gnomo o Scazzamurello che calca e cavalca. Oltre che oppressivo può essere anche ladro, ma per puro diletto.
Un massaro di Accettura raccontava che la notte gli prendeva i buoi e li conduceva a pascolare e quando lui li scopriva tranquilli a ruminare in mezzo all’erba si guardava bene dal ricondurli alla stalla perché lo Gnomo avrebbe potuto offendersi e nel sonno tornare a calcare e cavalcare a modo suo bestie e padrone, uccidendoli tutti all’occorrenza. Si racconta pure che c’era una bella giovane maritata ingaggiata per la raccolta delle castagne. Di lei s’era invaghito uno Gnomo che un giorno le disse: “Beh ogni mattina che vai a lavorare in campagna farò in modo che tu trovi un tarì in mezzo alla strada, ma bada di non dir nulla a tuo marito”
Un giorno che il marito l’accompagnava, arrivata al solito posto la donna si chinò a raccogliere il tarì e il marito chiese sospettoso: “Che hai trovato?”. “Un bottone” rispose quella. “Gnornò. Fammi vedere”, la frugò nel corpetto, scoprì il tarì e minacciò di picchiarla se non avesse detto la verità. E la ragazza dovette dire che era un folletto cascamorto a farglielo trovare tutte le mattine.
D’allora in poi non solo non ne trovò più, ma per vendetta lo Gnomo le fece sul seno una tale calcata che poco mancò non le schiacciasse l’anima.
Un’altra ragazza, ugualmente maritata, se lo vedeva comparire di continuo nel caldaio e allorché si fece animo e gli chiese del denaro il folletto rispose: “Era per questo che mi tenevi in caldo? Beh fai conto di non avermi mai conosciuto”. E se ne uscì sdegnato. Si sa infatti che gli gnomi non accettano che si parli interessatamente di denaro.
Ad Albano c’era invece una tessitrice che non si sa bene se per il rumore prodotto dal telaio o per antipatia della persona uno gnomo aveva cominciato a perseguitare. Le faceva dispetti a non finire. Una notte le spezzava l’ordito, un’altra le arruffava i gomitoli, un’altra ancona le rovesciava il lume a terra o le sporcava la cisterna.
Su denuncia dell’infelice arrivarono i carabinieri che non solo non riuscirono a identificare l’autore di quei misfatti, ma furono messi in fuga da una misteriosa sassaiola e uno per uno la notte stessa calcati e cavalcati.
Guai, insomma, a prenderlo di petto. Dato che è l’ozio il padre dei suoi capricci, meglio lusingarlo e fingere di divertirsi.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI LAURIA
Sulla vetta di un monte roccioso che domina il vallone Caffaro e la rupestre Lauria Inferiore, si elevano i muri e gli avanzi delle torri del castello di Lauria Superiore.
Pare che questo fosse dapprima appartenuto ad un certo Ruggiero di Lauria, quindi fu dei Sanseverino e dei duchi di Candia.
La leggenda narra che in questo castello i feudatari ospitassero le più belle fanciulle della regione, per istruirle nell’arte dell’amore e dello spionaggio, inviandole quindi presso i signori che ne facessero richiesta.
Racconta il Salvino che tempo fa un anziano del luogo giurava che il nonno di suo nonno, vissuto nel castello, aveva scorto molte lettere di questo del tipo: "Quando a te fosse a grado, a me sarebbe grandissima grazia avere meco madonna Niccolosa o madonna Lisa per dieci giorni, per poter stare solo con lei…".
Si racconta che un giorno, una di queste belle fanciulle, cresciuta da uno dei signori del castello, si fosse innamorata di un inserviente. Il signore, preso dall’ira, uccise il servo pensando di rimanere solo ed ancora amato come un tempo.
Ma una notte di tempesta, la fanciulla chiese al signore di seguirla nei sotterranei, dove lì avrebbero assaporato il frutto dell’amore. Nello scendere le scale, il signore vide aprirsi una porta: era il fantasma dell’ucciso che pretendeva l’amore più caro del signore, cioè l’anima. Si racconta che il signore fosse precipitato da una finestra del castello, gettato dalla fanciulla e dal fantasma del servo, e da allora si sentono ancora degli spifferi che raccontano questa orribile storia…
Il castello, comunque, oltre che leggendario centro di smistamento di belle fanciulle, fu il centro della resistenza agli assalti del generale francese Massena, che espugnò e punì duramente la città di Lauria, insorta dopo l’occupazione francese.
IL CASTELLO DI MONTESERICO PRESSO GENZANO
Anche per questo come per altri castelli, non si trovano precise notizie circa le origini. Alcuni ne fanno risalire la costruzione addirittura al tempo dei Romani, ma molti lo ritengono giustamente di età normanna.
Alcuni, come Willemsen, hanno ritenuto che, poichè di modeste proporzioni, si tratta di un luogo di villeggiatura più che di difesa, ma recenti studi ne dimostrano il contrario, se si pensa che accanto ad esso vi fu un esteso villaggio.
Verso la fine del sec. XIII il castello apparteneva ad Aquilina Sancia, ma successivamente passò ai Sanseverino e, nel 1348, a Francesco del Balzo.
Sempre più spopolata dalle pestilenze e dalle modifiche ambientali, tra il 1400 e il 1430, la borgata di Monteserico venne via via dimenticata, mentre il castello rimase abitato o, comunque, frequentato.
Dal XVII alla fine del XVIII sec. fu proprietà del genovese Grimaldi dei Doria e di alcuni discendenti della famiglia Sancia. Rimase abbandonato, quindi, per più di mezzo secolo, finché non lo acquistarono i baroni Dell’Atti Cetti, nel 1857, che poi lo vendettero ai Cafiero, nel 1875, ma allora il castello era già divenuto un luogo inabitabile.
Una leggenda racconta che all’interno del castello vi fosse un immenso tesoro.
Nel 1897 il popolo di Genzano, in seguito ad un sogno fatto da un vecchio saggio, si riversò in massa in quel luogo e si mise a scavare sul fianco settentrionale del castello in cerca della Madonna sognata dal vecchio.
Il lavoro durò parecchio tempo e fu ripreso negli anni successivi con il risultato di gravi lesioni alla struttura.
Sicuramente dopo la Prima Guerra Mondiale il castello fu in parte restaurato, come dimostra la presenza di soppalchi in calcestruzzo e le travature in cemento, ed abitato da Lida Borelli. Oggi appartiene alla famiglia Di Chio di Spinazzola.
Il maniero, sobrio nella sua struttura architettonica sorge sulla cima del Monte che dà il nome alla contrada a 557 metri sul livello del mare.
La struttura è composta da una torre quadrangolare centrale ed un recinto più basso e con tratti murari a scarpa.
Superato un ponte ed il portale di acceso, vi troviamo una breve corte quadrata, la quale separa il mastio dalla massa esterna che lo recinge. La pianta del piano terra è divisa in due parti, con un arco che sostiene una volta a botte a sesto acuto.
Ai due piani superiori, che oggi non conservano traccia della loro antica struttura, si accede mediante una scala a chiocciola.
Da un solo lato il castello è unito alla spianata per mezzo di un ponte levatoio; dagli altri lati si erge a picco sulla nuda roccia.
IL CASTELLO DI MONTICCHIO
Non tutti sanno che il casale ed il castello di Monticchio erano abbastanza lontani da quello che oggi viene conosciuto come Monticchio.
Oggi si intende il luogo dove sorge l’Abbazia di San Michele sugli splendidi Laghi, ma in realtà il vero Monticchio è il cocuzzolo di una collina e l’area circostante siti nella località "Sgarroni" a Rionero in Vulture.
I resti del castello si trovano dopo aver raggiunto la sommità della collina adiacente alla masseria San Vito e rappresenta una serie di fortificazioni che difendevano il Vulture sin dall’età prenormanna. In quest’area i monaci benedettini avevano cristianizzato le campagne.
Anche Federico II non disdegnò questi luoghi, come ben sappiamo, e della tipica architettura sveva sono alcune fasi costruttive della Badia di S. Ippolito, in particolare la torre cosiddetta "campanaria" –in realtà un elemento da difesa con due livelli ben distinti.
Ritornando al castello vero e proprio, solo tre ambienti sono oggi visibili, a pianta pseudoquadrata, ricoperti da rovi e querce.
Al di sopra la struttura muraria emergente si conserva un arco acuto ghierato (XII secolo), successivamente tamponato e poi rinforzato da una muratura di sostegno esterna, di età angioina.
Terremoti e smottamenti continui costrinsero gli abitanti ad un repentino abbandono, e nel caso di Monticchio hanno coperto la storia di questo castello e di questi monumenti.
Il villaggio, costituito dalle numerose strutture e case, era anche conosciuto come "Casal Cornuto" (cioè "Casale con le mura merlate") i cui abitanti sono tenuti nell'età sveva a riparare il castello di Melfi.
Qui nel 1279 Enrico, trovandosi nel suo castello, incontrò alcuni uomini della sua terra che "evaginato burdone", cioè estratta la spada, lo ferirono gravemente ad una coscia giustificandosi perchè "i diritti ed i servigi che erano soliti destinare a lui come gabelle per la Corona se li teneva lui indebitamente".
Ma la storia non finisce qui, perché costoro, inoltre, il giovedì dopo Pasqua suonarono le campane ad armi inseguendolo a colpi di pietra gridando "mora! Mora!", tanto che costrinsero Carlo I ad aprire un'inchiesta sulle ragioni di tali comportamenti.
Non sappiamo come andò a finire l’inchiesta, ma conosciamo bene gli eventi successivi che portarono i padroni delle terre a sfruttare sempre di più il Sud e la Basilicata, portando poi a fenomeni di ribellione, erroneamente chiamati "brigantaggio".
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI MURO LUCANO
Pare che questo castello fosse già stato costruito prima della conquista normanna, cioè intorno all’VIII secolo, anche se l’attuale architettura sembra attribuirgli una cronologia al XIV-XV sec.
Si pensa, quindi, che facesse parte di un complesso sistema di fortificazioni che gravitavano sulla montagna del Vulture, all’indomani del fenomeno di colonizzazione longobarda e bizantina che interessarono il territorio, che allora gravitava nell’area pugliese.
Si racconta che in questa antica fortezza avvenne un atroce e misterioso assassinio, quello della regina Giovanna I per ordine di Carlo di Durazzo, verso la fine del secolo XIV.
Non tutti gli studiosi, però, sono concordi sul fatto che il castello di Muro Lucano fu luogo dove avvenne il delitto, come, del resto, anche sul modo in cui la regina fu assassinata.
Il popolo vuole il castello come luogo di pericolosi trabocchetti e paurosi sotterranei, nei quali la spietata regina faceva sparire i suoi amanti dopo una notte d’amore.
Nel 1477 re Ferrante d'Aragona vendette Muro con il relativo feudo a Matteo Ferrilli, il cui successore, il figlio Giacomo, non avendo alcun erede, concesse alla figlia Beatrice tutti i suoi possedimenti. Questa sposò Ferdinando Orsini, duca di Gravina in Puglia, e quindi, dal 1530 in poi e fino all’abolizione del feudalesimo, il castello appartenne agli Orsini.
Il tremendo terremoto del 1694 danneggiò l’intero complesso in maniera disastosa, facendo crollare l’intero ultimo piano. Fu così che, probabilmente, le nuove costruzioni fatte eseguire dagli Orsini e le profonde modifiche strutturali apportate nell’ultimo secolo fino ai nostri giorni gli hanno dato l’aspetto attuale.
Il vasto edificio, anche se non sembra costruito con piano prestabilito, sembra adattarsi alla morfologia della roccia su cui sorge.
Il cortile è di forma molto irregolare e conduce, per mezzo di una gradinata, ad un altro cortile dalla forma rettangolare circondato da porte che immettono in locali adibiti a depositi. Entrando in questo secondo cortile si nota una cisterna scavata nella roccia. A sinistra vi è una scala che conduce verso la Gran Torre, mentre sulla destra c'è la grande scala a rampe, per la quale si saliva, da un lato, in due grandi vani che, uniti insieme, formavano il teatro; dall’altro lato si accedeva all’appartamento nobile, crollato durante il terremoto del 1694.
Nella vastissima sala d’armi si entrava da una grande portale che si apre sulla destra, situato all’estremità del primo cortile.
Dalla sala si accedeva al cosiddetto "appartamento del principe", formato da tre grandi camere, con un oratorio detto del Cardinale; a sinistra, in altri vani grandi e piccoli, dall’ultimo dei quali si usciva su di un giardino pensile.
IL CASTELLO DI OPPIDO LUCANO
Nessuno sa chi possa essere stato ad edificare il castello di Oppido.
Dall’area stessa dei suoi ruderi e dallo spessore delle mura si comprende perché venne definito con il termine di "Castro fortissimo" e "Magnum Castrum".
Il castello non fu mai stabile dimora per i baroni, forse perché appartenuto quasi sempre alla Corona. I primi padroni, comunque, risultano i francesi Pietro de Sonmerouse (1269), Roberto de Drois (1306) e Pietro de Glaix (1309); la fortezza fu quindi ceduta a principi angioini e durazzeschi, finché, sotto, il regno di Giovanna I e sotto i primi re Aragonesi, venne in possesso della famiglia Zurlo, che ne fu proprietaria sino al 1480. Per più di due secoli, quindi (1500-1721) fu degli Orsini, principi di Taranto.
L'abbandono definitivo del castello avvenne con l’estinzione della Casa Orsini.
Passato il feudo in altre mani, i nuovi padroni non vi fecero che rare apparizioni, restando il castello affidato a funzionari del Regno.
Dopo l’abolizione della feudalità, il vetusto edificio andò sempre più deperendo e alla fine fu venduto per poche migliaia di lire.
La storia di questo castello favoleggia che il compratore, mentre faceva apportare delle modifiche edilizie, trovò un plico ancora suggellato, con lo stemma degli Orsini, principi di Taranto –lo stesso che si può vedere sul vecchio portale d’ingresso–.
Incuriosito subito lo aprì per leggerlo. Il documento, poiché era scritto in latino, non fu tradotto dall’ignorante compratore, che per l’occasione si recò da un vecchio prete pregandolo di tradurgli il contenuto del plico. Il prete tradusse: "Poiché lo hanno fatto a me, io lo farò anche a te. Non so chi sarai né quando leggerai, ma sono sicuro che ci cascherai. Te lo dico: è una bugia; ma se scavi per tre metri, dove ora c'è la stalla, qualche cosa troverai. Or vediam come la metti: sì o no. Cosa farai? Forse ci cascherai!".
Il prete manifestò che era chiaro fosse una burla, ma il compratore la pensò diversamente, e comunque non avrebbe fatto nulla. La notte seguente invece, da solo, iniziò a scavare; solo che non riuscendo in una sola notte proseguì nelle successive. Ogni notte, il compratore si alzava dal letto per andare a scavare forsennatamente, sino a quando, dopo tanta fatica, una cassetta.
La prese, ma era pesante, perciò prima di aprirla, volle aspettare dopo un piccolo riposo; intanto pensava a sè ricco e padrone di un castello meraviglioso, che avrebbe oscurato la fama del Magnum Castrum che aveva acquistato. La storia, accanto al nome, dei grandi feudatari di Oppido avrebbe ricordato anche il suo! Tremando, aprì la cassetta, ma niente, nè oro, né gemme; ma solo ancora un plico. Lo srotolò con mano febbrile e lesse soltanto una parola: "Blennus!". Non sapeva il latino, ma dovette certamente comprenderne il significato; anzi si arrabbiò così tanto che si allontanò per sempre da Oppido, dopo aver rivenduto il castello.
IL CASTELLO DI PESCOPAGANO
Nel IX e X secolo, quando infierivano le incursioni dei Saraceni, ognuno di questi volle costruire – sembra – in ogni città un castello, o almeno una torre.
La città di Conza era troppo esposta alle incursioni dei barbari. che ne conoscevano la sua importanza come piazzaforte; ma, smantellata dai terremoti, afflitti e decimati gli abitanti dalla malaria, non si affidava più alla resistenza e ad un sicuro insediamento stabile, quindi la maggior parte dei cittadini emigrò sui monti, dove era più facile difendersi, e in luogo più benigno.
L’esempio degli abitanti di Conza fu seguito da quelli dei casali, formandosi così il Castrum Petra Paganae. In realtà tutti sanno che un sistema di fortezze e centri fortificati doveva già esservi su quei monti, tenuto conto che in Pescopagano, Montecalvo e Caivano –località situate nel circuito di Conza– trovarono rifugio, dopo la battaglia del Volturno, i settemila Goti che si arresero poi a Narsete.
Le notizie sicure sui primi feudatari abitanti del castello risalgono al 1164: al conte Gionata di Balvano.
Nel XIII sec. possiede Pescopagano Raynaldo de Ponzellis Gallico, investito del feudo da Carlo I d’Angiò, dopo la caduta di Manfredi a Benevento. Nel 1331 per fellonia del feudatario Filippo Stendardo o Stenderogo il castello con tutto il feudo passò al regio demanio.
Roberto d’Angiò ne fece donazione alla regina Sancia di Maiorca, che lo alienò a Mattia Gesualdo. I discendenti di costui diedero tanto filo da torcere ai poveri vassalli di Pescopagano che, con i continui piani giudiziari, stancarono il Sacro Real Consiglio. Gli abusi e le violenze finirono soltanto con l’abolizione del feudalesimo.
Chi volesse osservare oggi il castello, vedrebbe un mucchio di neri macigni, coperti di edere e di rovi, senza una via praticabile.
La tradizione racconta che qui, invece, vi era il ricco Pietro Pagano, nemico di Dio e degli uomini.
Avvenne però che, verso la mezzanotte di un giorno di un anno ignoto, la gallina cantò tre volte di notte, e subitamente si udì uno rimbombo, un boato sotterraneo e più e più volte si scosse e tremò la terra. Allora rovinò il castello e si videro quei dirupi che prima non erano.
E così fu che il paese, dal nome di quel signore, rimasto sepolto sotto quelle rovine, si chiamò Pescopagano o Petra Pagana.
Indubbiamente questo aneddoto ricorda i tristi tempi del feudalesimo e il terremoto del 1466, riportato da Lodovico di I Raimo nei suoi annali: "Ai 14 gennaio 1466 ad hora nona fu un gran terremoto e durò più d’un miserere dicendosi ben per agio; e per la virtù di Dio nullo male successe a Napoli, ma nella Provincia di Principato Citra più e più terre foro guaste vidilicet Buccino, Pascopagano, Consa et altre Terre".
E l’altro più funesto ancora dell'8 settembre 1694 che distrusse quasi interamente l’abitato e fece rimaner sepolte sotto le macerie più di seicento persone.
IL CASTELLO PICERNO
Si racconta che nell’antichità Picerno avesse un altro nome, Acerrona; lo dimostrano alcune tombe risalenti al II sec. a.C. rinvenute in contrada Serralta, già Campolongo, ma probabilmente si tratta di due insediamenti distinti, di cui Picerno sembra essere quello più esteso a ridosso del torrente Ontrato.
Lungo le suggestive e tortuose strade del paese non manca il castello, i cui resti sono evidenziati dai ruderi di una torre circolare, nella contrada urbana detta “Bassa la terra” o “Toppo S. Leonardo”. Quest’ultimo toponimo deriva dalla presenza di un monastero addossato al castello appartenente, come riporta la tradizione, alla famiglia Pignatelli.
Si racconta che all’interno di questo castello la vita dei baroni fosse alquanto comoda, poiché solo il popolo andava a lavorare portando poi i tributi all’interno della fortezza. Qui la moglie del barone, bellissima donna, subiva le angherie del marito, che portava all’interno ogni sua amante facendo soffrire la giovane innamorata. Il barone non volle sapere di quel dolore ed il cuore della donna si feriva ancora di più.
Un giorno, lungo le strade del villaggio, venne un forestiero proveniente dalla Puglia che vide la donna affacciata al balcone del castello. Appena egli la vide pensò: “E’ bellissima, ed io l’amerò per sempre”. Ed iniziò a cantarle e a scriverle in segreto l’amore infinito. La giovane donna non sapeva chi fosse a mandarle lettere e canzoni e, da illusa, pensò che fosse il marito che intendeva chiederle perdono. Un giorno, infatti, il barone le chiese di offrirsi per una notte d’amore.
Fu una gioia per la donna, che ritornò per pochi attimi felice come un tempo. Il suo sorriso, per un giorno divenne gioioso ed ella stessa iniziò a cantare sulla grande balconata del castello. In quel momento passò lo straniero, che dentro di sé si era arricchito dell’amore più nobile, ma ascoltando la canzone intuì che essa era dedicata allo spregevole barone.
Le cose non furono proprio come la baronessa le aveva pensate. Il barone decise di portarsi ancora le sue amanti nel castello e lei riprese a rattristare.
La trasmissione di memorie vuole che il povero viandante decise di andare via, pieno di dolore, per sempre da quel luogo, mentre la baronessa rimase infelice per sempre. Un’altra tradizione dice che la giovane donna comprese il dolore dello straniero, fuggì dalla tortura del marito ed amò per sempre il viaggiatore.
A voi e ai discendenti di quei Picernesi sta la scelta del finale della storia che più aggrada.
IL CASTELLO DI PIETRA MORELLA
Fuori dell’abitato di Brindisi di Montagna esisteva un villaggio con masseria fortificata dal nome di Pietra Morella. Qui esisteva già un cenobio “basiliano”, ma nel XVI sec. pervenne ai Padri Certosini di Padula ai quali fu donato dal Principe Nicola S. Severino.
Nacque la grancia di S. Demetrio, eretta per designazione del rettore Gerardo Church, detto Dionisio Canonico Potentino. La Grancia fu dedicata a S. Demetrio da Irene Scanderbergh, figlia dell’eroe albanese e moglie del S. Severino. Nel 1700 i Certosini estesero i possedimenti su tutto il feudo ampliando l’antico fabbricato sede del cenobio costruendovi abitazioni, mulini e ovili. Il monumento è riconoscibile da una torre di avvistamento con merlatura che sormonta un edificio il cui ingresso è costituito da un grande portale in pietra. La struttura sembra essere databile alla metà o fine del XVI secolo. Sul lato opposto vi è un altro ingresso che conduceva ad una cappella dove agli inizi di questo secolo si trovava un altare barocco ed una statua di S. Lorenzo. La costruzione ricalca i dettami di S. Bruno, fondatore dell’Ordine monastico certosino, finalizzato al ritiro e alla contemplazione.
In una piccola casa presso il feudo, nel Cinquecento, abitava una ragazza graziosa, virtuosa e orfana che viveva un po’ con i risparmi che le avevano lasciato madre e padre e un po’ col guadagno che ricavava tessendo il fustagno.
Erano stati in molti a chiederla in sposa per le sue doti fisiche e il suo buon cuore ma ella non si sentiva pronta al matrimonio. Una sera, mentre pregava, si avvicinò un giovane biondo e slanciato il quale con acconce parole tentò di distoglierla dalla preghiera. La ragazza, turbata, si raccomandò alla Madonna e per sfuggire alle lusinghe di quell’uomo lo pregò di tornare un altro giorno. Rimasta sola scoppiò in pianto e chiese aiuto alla Vergine, la quale apparve prontamente e le disse: “Figlia mia, fatti coraggio. Sappi che chi ti si è presentato in belle fattezze, per meglio tentarti, è nient’altro che il diavolo. Se vuoi tenerlo lontano, devi ricorrere a questa astuzia: quando tornerà, metterai sul fuoco una casseruola con dentro l’olio e col pretesto di dover friggere lo pregherai di attizzare la fiamma. Non appena l’olio comincerà a bollire, glielo butterai addosso e vedrai che scomparirà”. La ragazza ringraziò la Vergine e giurò dl fare ciò che le aveva consigliato.
La sera successiva, allorché il demonio si affacciò sull’uscio per rinnovare la sua dichiarazione d’amore, ella lo pregò di aiutarla ad accendere il fuoco in modo che potesse preparargli da mangiare. L’ospite, ben contento di quell’invito inatteso, si mise subito all’opera soffiando e gettando frasche nel camino con tale foga da diventar rosso come un peperone. Finalmente la fanciulla credette che l’olio fosse abbastanza caldo e, approfittando di un momento in cui il messere stava con la testa in giù, glielo rovesciò addosso. Apriti cielo! Come il diavolo avvertì la tremenda bruciatura, emise un grido e, per il timore di essersi ridotto peggio di un tizzone, con gran frastuono sprofondò sottoterra.
Giunto urlando all’inferno, i compagni più premurosi gli andarono incontro e gli domandarono: “Chi ti ha conciato in tal modo?”. Quegli raccontò a mezza bocca l’accaduto e i diavoli, feriti nel loro orgoglio per colpa di un babbeo che si era lasciato beffare da una verginella, lo misero in mezzo e gli dettero il resto infilzandogli il sedere con mazze ferrate e uncini roventi.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI PIETRAGALLA
Lo stupendo castello di Pietragalla ha oltre sei secoli di vita ed è ornato da finestre con capitelli; nell'interno, fino a qualche tempo fa, accoglieva armi antiche e quadri di Luca Giordano e di altri maestri di buona scuola napoletana.
Dovette essere ricostruito dopo il 1456, essendo stato distrutto dal tremendo terremoto di quello stesso anno che sconvolse l’intera Basilicata, che rase al suolo pure la vicina cittadina di Casalaspro, i cui abitanti superstiti –racconta una leggenda– si riversarono appunto a Pietragalla e lavorarono sia alla ricostruzione del castello che delle nuove case, che potessero accoglierli.
L'antica rocca richiama l'eroica resistenza del popolo pietragallese, che nel 1861 si raccolse tra le sue mura per difendere e sgominare le orde di duemila briganti comandate da Borjes e da Donatello Crocco.
"Era il 16 novembre 1861… si comprese che era da aspettarsi da un momento all'altro l'arrivo delle orde brigantesche. I più notabili signori del paese si riunirono, si decise di opporre ostinata resistenza. Si pensò che, essendo il paese sparpagliato, da tutte le parti, e però non facile a guardare convenientemente, il meglio che si poteva fare era di concentrare la difesa in un sol punto. Si prescelse il Palazzo Ducale sia perché capace di contenere molta gente, sia perché esso forma come l'acropoli del villaggio e lo domina quasi tutto.
Poco dopo vespro si dispose che tutti i vecchi, i fanciulli e le donne delle famiglie più notabili, che sarebbero stati i più esposti alle violenze brigantesche, si raccogliessero nel Palazzo Ducale, col più necessario".
Il castello fu ripetutamente assalito dai briganti, che tentarono in ogni modo di entrarvi, ma i Pietragallesi resisterono valorosamente, compiendo numerosi atti di eroismo.
Tra questi si ricorda di aver salvato un’anziana nobile dall’essere sgozzata proprio da Carmine Crocco; costui, mentre stava affilando il coltello, fu distratto da un bambino che tentò di abbassargli i calzoni. Fu allora che un pietragallese riuscì a sottrarre la nobile donna rinchiudendosela in casa e nascondendola in un baule.
Nella notte, poi, alcuni nobili, per la prima volta insieme ai popolani, scacciarono alcuni cavalli dei briganti, che erano allo stato brado per abbeverarsi.
Per più di sedici ore la resistenza e la tattica difensiva di pietragalla ha resistito al desiderio di violenza e vendetta dei briganti, sino a quando non giunsero rinforzi da Acerenza e da Potenza e i briganti furono sgominati.
IL CASTELLO DI PIETRAPERTOSA
Chi non conosce la meraviglia delle possenti mura del castello di Pietrapertosa? Certo, ognuno sa che al tempo dei saraceni, quando imperversavano per le province di Matera e Potenza, un avamposto militare fu creato da un arabo che tutti chiamavano Bomar, ma del castello di Pietrapertosa non si conosce più nulla.
Un tempo, racconta qualche contadino, sull’altissima rupe dove sorge il castello andavano a pascolare gli animali e si pensava che nessuno, ormai da secoli, abitasse quei luoghi così aspri nel paesaggio e nel clima.
Un giorno uno di questi pastori, proveniente da Castelmezzano o dal casale di Trifoggio, volle portare le pecore sino ai piccoli a freschi praterelli del castello. Ma appena entrò in esso udì qualcosa di incomprensibile: "Aiutami! Aiutami, mio signore, sono imprigionata nelle mura della torre!". Dopo aver udito quelle parole, il pastore fu preso dallo spavento e fuggì di corsa lasciando il bestiame. Subito corse sino al paese per raccontare l’accaduto, ma nessuno gli credette.
Sbeffeggiato da tutti, decise di ritornare a monte del castello, ma con grande meraviglia vide tutto il suo bestiame ammazzato.
Il povero pastore cominciò a lamentarsi e a battersi il petto per la grave perdita ed iniziò ad avvertire di nuovo quelle parole incomprensibili. "Aiutami! Sono…", ma le parole non furono terminate che il pastore prese un bastone e, colmo di rabbia, iniziò a scrollare il legno come un forsennato. "Vuoi prenderti gioco di me, eh?, ma adesso ti faccio vedere io!". Vibrò un colpo presso la torre e provocò un buco nella parete che dava sul dirupo verso la chiesetta di S. Antonio. Da quella parete sbucò una piccola ape luminosissima che subito volò nel cielo, ma mentre iniziava a volare diceva: "Ah, finalmente! Erano mille ani che non vedevo la luce da quando il saraceno mi rinchiuse fra le pietre poiché voleva che io non esprimessi alcun desiderio per nessuno".
E scomparve.
Il povero pastore iniziò allora a lamentarsi per il bestiame perduto, in realtà poche pecore poiché era già povero; stava già pensando di non ritornare più dalla moglie per non raccontarle di aver perso gli animali per un’ape… quando apparve nella notte di nuovo l’ape. "Cosa vuoi, ancora? Và via!"
"Noo, non disperare –disse l’ape- ha voluto uccidere le bestie per preoccupare gli eventuali tuoi accompagnatori, ma so che tu sei buono e sarai ricompensato".
Il pastore si addormentò, e il mattino successivo trovò un sacco pieno d’oro e tanto bestiame da non tenervi testa.
Fu allora che nacque la leggenda di un’ape sulla montagna del castello di Pietrapertosa che fece felice un uomo semplice che non conosceva la gioia di una grande ricchezza.
(di: P.Rescio)
IL CASTELLO DI POTENZA
Il castello di Potenza, come si può ancora vedere se venissero rimosse tutte le abbondanti opere murarie aggiunte in tempi seriori, sembra una costruzione non anteriore al 1200, cioè probabilmente di età angioina, della quale è ancora possibi-le riconoscere una torre, ma con tutta plausibilità è forse quello che rimane di un complesso fortificato più antico.
Esso fu l’antica dimora dei feudatari, ma fu anche la prima prigione di Potenza, grande centro commerciale dell’antichità posto sulla via Erculia.
Nel 1268, dopo la sconfitta di Tagliacozzo ed il supplizio di Corradino di Svevia, i feudatari di Potenza dovettero seguire anch'essi le conseguenze della sconfitta del giovane re, avendo parteggiato palesemente per lo svevo.
Dice il Riviello che "si narra che l’antica dimora dei conti sia stata una volta l'antico castello con la sua latissima merlata ed inaccessibile torre segnacolo di potenza e di minaccia sia per gli abitanti della citta, che contro i nemici, la quale fatta logora e screpolata dal lavorio dei secoli e dalla forza dei terremoti venne più volte mozzata dal piccone del fabbro, nella stessa guisa che la forza del progresso e la folgore della rivoluzione distrussero il dominio feudale degli antichi signori".
In quell'occasione il castello fu occupato ed affidato ad un regio castellano, mentre i vecchi feudatari vennero presi, imprigionati, accecati o impiccati dentro la stessa fortezza.
Di qui si ha un’idea che l’intera costruzione occupasse un grande spazio, sia in estensione che in altezza, e di cui noi non possiamo renderci completamente conto.
Dopo la concessione della contea di Potenza ad Innico di Guevara, i feudatari presero dimora fissa nel palazzo della contea, abbandonando il castello, il quale non più curato dai suoi padroni.
Fu così che venne ceduto, nel 1626, ai Cappuccini che decisero di utilizzarlo come convento e poi come ospizio per i pellegrini che, da Napoli, decidevano di percorrere la Basilicata attraverso i santuari più famosi e poi giungere e Bari e Brindisi per dirigersi in Terra Santa.
L’Ospizio-Ospedale rimase in possesso dei Francescani fino al 1810, anno in cui fu tolto ai religiosi ed adibito ufficialmente a sede dell'Ospedale San Carlo.
IL CASTELLO DI RAPOLLA
Pochissimo si conosce del castello di Rapolla. Sappiamo, per esempio, che Rapolla, posto a 439 metri sulle falde nord-orientali del Vulture, è di origini alquanto incerte ed il suo toponimo pare derivare dal lucano “rappa”, con il significato di spina o luogo di spine o di “località coltivata a vigneto”, attività nota nel territorio.
Una bolla di Papa Giovanni XX datata 14 luglio 1028, e un'altra bolla di Urbano II del 1089, dimostrano però che la diocesi di Rapolla fosse subentrata a quella di Cisterna (presso melfi), che nel secondo documento non viene più menzionata. Certo è anche il fatto che un tempo vi era un castello che rivaleggiava con quello di Melfi se nel 1059 Roberto il Guiscardo vi confinò il nipote Ermanno. Va ricordato inoltre che nel 1137 i soldati di Lotario III assalirono la città con l'appoggio dei Melfitani, che la occuparono definitivamente nel 1183; risulta ancora chiaro che la presenza di questo insediamento accentrato viene giustificata dal suo simbolo materiale, cioè le strutture fortificate. Restano dunque le mura, forse preesistenti all'invasione normanna, mentre forse la fortezza fu distrutta nel 1254 da Galvano Lancia che la prese d'assalto “con una moltitudine di soldati e cavalieri, rendendola al completo abbandono”.
All’interno del castello vivevano, alla corte del feudatario, due servi, fratelli: l’uno ricco, ma veramente avaro, l’altro povero ma generoso. Quest’ultimo, vedendo che dal fratello maggiore non poteva sperare nessun aiuto e quel giorno aveva più fame di un maiale, decise di andarsene per le vie di campagna a raccogliere funghi, lumache e quant’altro vi potesse trovare.
Saltando di fratta in fratta scorse da lontano una comitiva di briganti che rappresentavano il terrore di quei paraggi e per non subire offesa riparò in un bosco sulla collina e si nascose tra i rami di una vecchia quercia.
Per combinazione i malviventi, penetrati nel bosco, si fermarono proprio ai piedi di quella quercia e, scavato un fosso, vi sotterrarono tutte le monete d’oro e gli oggetti preziosi che avevano arraffato nella contrada di Ginestra. Dopo di che si allontanarono lasciando sul posto una rozza croce che servisse da segnale. Il giovane, che era rimasto nascosto sino al dileguarsi dei briganti, scese dall’albero, disseppellì il tesoro, lo ficcò nel suo sacco e tornò in fretta al paese.
Per misurare la quantità di oro su cui aveva avuto la fortuna di metter le mani mandò un ragazzino alla casa del fratello perché gli prestasse uno staio. Il fratello, insospettito dalla richiesta, pensò di spalmare di colla la base interna del recipiente: infatti, il fratello non si accorse che una piastra d’argento era rimasta attaccata al fondo dell’utensile. Come l’invidioso congiunto riebbe indietro lo staio e vi scoprì la piastra, comprese a volo di che natura fosse la merce pesata dal fratello e si precipitò a chiedergli quale diavolo lo avesse aiutato ad accaparrarsi il bottino.
Il giovane, smascherato, iniziò a raccontargli l’accaduto e l’altro, che era un mostro d’ingordigia, ingelosito di quella fortuna, pensò di eguagliano dirigendosi anche lui al bosco e qui aspettare al varco i briganti con la fresca refurtiva.
Male però gliene venne, giacché quelli, accortisi della sparizione del tesoro, avevano giurato di vendicarsi del misterioso ladro e ogni giorno uno di essi si appostava in quelle vicinanze per individuarlo e dargli la giusta lezione.
E infatti, non appena l’incauto si fu arrampicato sulla quercia per acquattarvisi, il brigante di guardia uscì dal cespuglio, puntò la doppietta e lo impallinò al sedere facendolo precipitare a piombo sul terreno da misero uccellatore smascherato.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI RIPACANDIDA
A Ripacandida c’era una volta un re che mentre andava a caccia vide un uomo intento a zappare il suo campicello. Il sovrano s’informò’ di quanto guadagnasse e quegli rispose: “Quindici grani”.
Il re disse ancora: “Che ne fai?”. E lo zappatore: “Cinque li presto, cinque li butto e cinque li restituisco”. Il re volle sapere il senso di queste parole e l’uomo precisò: “I cinque che presto sono per i miei figli che nella vecchiaia penseranno al mio mantenimento; i cinque che butto sono per mia moglie, ché da questa non mi aspetto più nulla oltre ai servizi che mi sta facendo adesso, e gli altri cinque li restituisco ai miei genitori che mi hanno allevato”.
“Bravo” disse il sovrano “ma questo non devi confidarlo a nessuno. Potrai riferirlo solo quando avrai visto cento volte la mia faccia”.
Lo zappatore promise di obbedirgli. Appena il re tornò al palazzo, convocò principi e ciambellani e disse loro: “Chi indovinerà quel che ora vi dico lo farò padrone di cinquanta paesi”. E ripeté le parole dello zappatore.
I principi ascoltarono attentamente e ciascuno di essi, desideroso di ottenere il premio, si lambiccò il cervello per riuscire a spiegare il rebus. E uno di essi pensava: “Come mai è venuta in testa al sovrano questa scommessa? Qualcuno, certo, gliel’ha provocata. E allora bisogna sapere chi è costui”.
Così pensando decise di percorrere la strada che il re aveva battuto il giorno precedente.
Dopo aver camminato per un bel pezzo s’imbatté nel piede su un cumulo di monete ancora più grande del primo; le monete, però, erano tutte d’argento. Donato si piegò di colpo per impossessarsene prima che qualcuno venisse a impedirglielo, ma anche questa volta sul più bello la Fortuna venne inflessibile ad arrestano.
Con la coda tra le gambe si allontanò per entrare nell’ultima stanza. E qui, chi l’avrebbe mai detto? legata a una fune pendeva la sua zappa. Donato, confuso e mortificato, si voltò dall’altra parte per non guardarla. In quell’istante rivide la Fortuna che con aria severa gli indicava l’arnese: “Donato, prendi quella zappa. Ti servirà a trovare ciò che hai sempre desiderato, se sarai capace di scavare nel fondo più profondo della terra”.
Il contadino prese la sua zappa e se ne tornò a casa deciso a seguire i consigli della fata. Ricominciò pazientemente a rivoltare i maggesi, seminò il grano come si conviene, e quando venne la stagione della mietitura si avvide che il raccolto era così abbondante che non c~erano aie capaci di contenerlo né sacchi sufficienti a raccogliere i tornesi che via via ne ricavava.
Allora Donato si rese conto di quanto fossero preziosi gli insegnamenti ricevuti e tutti nel circondano si convinsero che soltanto nel lavoro è lecito cercare ricchezza e fortuna.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI RUOTI
Nel castello di Ruoti c’era un Re, tanto malato che nessuno credeva più possibile una sua guarigione. I medici avevano fatto di tutto per tentare di salvarlo, ma a nulla erano valsi i loro sforzi. Successe che un giorno, i tre figli del monarca, dopo aver visitato il loro padre e convinti ormai della sua fine, si misero a piangere nel giardino del palazzo. Erano ancora in lacrime, quando si fece avanti un vecchio che chiese: “Perchè piangete, figlioli?”
“È per nostro padre che ci sta per lasciare per sempre. Non ce rimedio per il suo male”.
“Io ne conosco uno!” –Replicò lo sconosciuto– “È l’acqua della vita. Chiunque la beva, guarisce da tutti i mali”.
“Dove si può trovarla?” –chiese il maggiore dei Principi. “Nessuno lo sa con esattezza, ma nulla si trova senza fatica. Chi la trova ce l’ha”.
Grazie, buon uomo –dissero i Principi.
Senza perdere altro tempo, il maggiore dei tre corse da suo padre per avere il permesso di cercare l’acqua della vita. “No, figlio mio,anch’io ne ho sentito parlare molte volte, ma nessuno, di tutti quelli che l’hanno cercata, è più tornato indietro”. Il Principe, però, insistette tanto che il padre acconsentì. “La mia vita vale poco, ormai sono vecchio, quindi non rischiare per me. Sii prudente, promettimelo!” Dopo di che il Principe si mise in cammino. Lo fece tanto che, giunto all’inizio del bosco, quasi travolse un piccolo trovava a passare di lì. “Fammi strada, ranocchio!” “Si può sapere dove corri con tanta fretta?”, chiese il nano. “Sei curioso e stupido!”, Fu la risposta del Principe –Dove vado, e perché, a te non interessa!”, “Me non importa, giovane superbo, ti fermerà la gola!”. Il Principe scansò l’uomo pensando: “Le parole di nessuno non raggiungono il cielo”. Continuò la sua marcia finché, molte ore dopo, si trovò di fronte a delle alte montagne. “Superare queste montagne mi costerà parecchia fatica. Devo trovare un passo. Lo trovò, dopo ore ed ore, ma la vegetazione e le rocce erano così intricate che finì per rimanere bloccato ed imprigionato tra due rocce in una gola. Frattanto, il Re ed i suoi figli, attendevano con ansia il ritorno del Principe maggiore. Passarono molti giorni senza che accadesse nulla. Il secondo dei tigli si presentò al padre e disse: “Voglio andare a cercare mio fratello e l’acqua della vita”. Il Re acconsentì. Così anche il secondo Principe partì e anch’esso, alle soglie del bosco, incontro l’omino, che gli chiese: “Dove corri con tanta fretta?”. “Vado per i fatti miei! –Disse il giovane ridendo– “Ti importerà parecchio il mio percorso!”.
“Certo che no, giovane superbo! Ti fermerà la gola!”
Il Principe proseguì, senza più degnargli attenzione... per poi fare la stessa fine di suo fratello. Rimase infatti imprigionato tra le rocce della stessa gola. Passarono i mesi senza che al palazzo giungessero notizie. Così, anche il terzo Principe si mise in viaggio. Trovandosi di fronte all’ometto del bosco, che gli chiedeva dove andasse con tanta fretta, rispose: “In cerca dell’acqua della vita. Mio padre, il Re, è gravemente ammalato. Puoi aiutarmi?”
“Certo che sì! Sei un giovane gentile e meriti aiuto. L’acqua della vita si trova in un castello incantato, dove nessuno è mai potuto entrare fino ad ora”.
“Cosa lo impedisce?”
“La porta non ha serrature e quindi è impossibile aprirla. Inoltre, dentro ci sono due leoni affamati e feroci”. Il Principe, pensieroso, guardava l’uomo che gli stava davanti. Allora chiese: “Visto che sapete tutto, buon uomo, sapreste dirmi cosa dovrei fare per superare questi ostacoli?” “Certo che Io so. Prendi questo bastone di ferro e questi due pani. Col bastone colpirai per tre volte la porta e vedrai che si aprirà. Una volta dentro, darai un pane ad ogni leone, vedrai che si calmeranno, quindi potrai raggiungere la fonte e prendere l’acqua miracolosa, ma tieni conto che dovrai fare tutto prima di mezzogiorno. Solo così potrai tornare da tuo padre”.
Il Principe ringraziò e partì.
Giunto al castello, tutto funzionò come previsto dall’ometto: la porta si apri, i leoni mangiarono il pane e si calmarono. Il Principe giunse in una sala e vide, trasformati in statue, i cavalieri che avevano fallito nell’impresa. Cercò i suoi fratelli e non li trovò. Sopra una tavola c’erano una spada ed un pane. Il Principe prese entrambe le cose, passò quindi in un’altra stanza dove, con grande sorpresa, vide una splendida Principessa che gli disse: “Grazie di aver sciolto l’incantesimo che mi teneva prigioniera. Se vuoi, potremo sposarci entro un anno. “Perchè dobbiamo aspettare così tanto tempo?” Chiese il Principe. “È perchè devo riflettere prima di prendere una decisione così importante, inoltre devo riordinare il mio regno che si trova ancora soggetto al terribile maledizione. Ma ora prendi l’acqua che ti serve e vattene su bit entro mezzogiorno dovrai essere fuori dal castello”. Il Principe velocemente raggiunse la sorgente dell’acqua della vita. Riempì un vaso d’argento e corse verso l’uscita. Fece appena in tempo perchè subito dopo la porta si richiuse alle sue spalle.
Felice di essere riuscito nell’impresa, si allontanò da quei luoghi e, dopo molto cammino, giunse in un villaggio dove decise di fermarsi per mangiare e riposarsi. Riprese poi il viaggio di ritorno, preoccupato per la sorte di suo padre e dei suoi fratelli.
All’uscita del bosco, rincontrò il nano. Scese da cavallo e lo abbracciò per ringraziarlo dell’aiuto tanto prezioso che aveva ricevuto.
“Non dimenticherò che mi hai aiutato, amico. Vienimi a trovare a palazzo. A proposito, non ho visto tra i cavalieri prigionieri dell’incantesimo, i miei fratelli... Ne sai qualcosa?”
“Non meritano la tua preoccupazione! Sono superbi, orgogliosi e hanno il cuore arido. Sono stati puniti per la loro insolenza e si sono trasformati i rocce in una gola tra le montagne. Li ho maledetti io stesso”. “Perdonali, –supplicò il Principe– si saranno già pentiti”. “D’accordo. Vai nella gola, quando li avrai trovati toccali con questo ramo di mandorlo, ma che sappiano che ti devono la libertà. Non mi nominar tutto il merito della loro salvezza deve essere tuo. Questo ti metterà al riparo, forse, dai loro tradimenti. Il Principe ringraziò il nano e si diresse verso il palazzo dove il Re attendeva con ansia. Quando il Re ebbe bevuto un sorso di acqua della vita e fu quindi salvo, il Principe disse: “So dove si trovano i miei fratelli e vado a liberarli... Non temere, padre, non corro nessuno pericolo”. “Porta con te l’acqua che è avanzata, forse ti potrà servire”. “L’ho già presa e inoltre ho sostituito la mia spada con quella che ho trovato nel castello incantato insieme al pane. Ho tutto nel mio zaino”. “Ben fatto, figlio, sii prudente e torna presto con i tuoi fratelli”. Il Principe si rimise in viaggio. Arrivato nella gola, vide i suoi fratelli che, nel frattempo, si erano trasformati in pietra. Fece come gli era stato detto dal nano ed essi tornarono in vita. Tutti insieme ripresero la via del ritorno.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI RUVO DEL MONTE
La storia di Ruvo del Monte non è proprio conosciuta da tutti. Si sa, per esempio, che nel 1435 fu espugnata, dopo fiera resistenza e, quindi, fu incendiata dal condottiero Caldora, di parte angioina perché il feudatario di Ruvo, Antonello Gesualdo, era partigiano del re Alfonso.
Questa storia ci rivela che la città dovette risorgere dalle fondamenta o, comunque, dovette subire un rinnovamento urbanistico tipico di tutti gli insediamenti della Basilicata a partire dalla metà del XV sec.
Erano iniziati, però, anche tempi duri: allo spadroneggiare dei nobili e dei briganti, si aggiungeva la paura dei Turchi e dei corsari, che piombavano improvvisamente, incendiavano messi, rapivano uomini, donne e bambini per portarli in Oriente.
In quest' epoca e comunque non oltre il 1500, si deve porre la costruzione del castello con la sua forte e maestosa torre che domina ancora oggi il paese.
Gli anziani raccontano che, un tempo, si usava ancora dire ai bambini, per non farli allontanare troppo dall'abitato: "Non andate lontano, potreste essere afferrati dai zannieri (giannizzeri, ovvero scagnozzi)"; questo perché era naturale che il feudatario di un tempo imprecisato aveva il gusto di rapire bambini e fanciulle per seviziarli e fargli scherzi continuamente. I bambini, tanto rimanevano spaventati, che avevano poi paura anche di andare a lavorare nei campi del signore una volta divenuti adulti.
Ma cosa avveniva in quel castello?
Si sa, ed in effetti è stato scoperto di recente, che il castello era ricco di segrete che si racconta fossero piene di cadaveri di bambini: erano gli scheletri di quelli che non avevano potuto resistere alle terribili torture.
Un giorno uno dei giovanissimi del paese decise di comprendere cosa ci fosse di strano in quella costruzione, anche perchè i suoi amici non parlavano di ciò che avevano subìto durante le torture. Al pomeriggio, vide alcuni popolani entrare nel maniero; egli si intrufolò tra gli intercapedini delle mura ed ascoltò: "Signore maestoso, vorremmo farti notare che qui le nostre donne ed i nostri bambini sono ancora più monelli. Prova a fare tu qualcosa". Il signore annuì e se ne andò.
Quella sera sparì un ragazzino, ed il nostro eroe cercò di intrufolarsi nel castello: ci riuscì e vide… una cosa da non crederci!
Il signore del castello, vestito da diavolo, torturava il bambino, che era legato, con… una piuma!
La piuma veniva posta ai piedi del poveretto che rideva e gridava: "Pietà, basta, non lo faccio più, ti prego, farò il buono".
Quel bambino, al nascosto, fece un grande sorriso e disse fra sé: "Anche io dirò ai miei figli di stare attenti agli giannizzeri del signore del castello".
IL CASTELLO SAN CHIRICO RAPARO
Superata la chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, e dopo aver superato per tornanti qualche viuzza nel centro storico di San Chirico Raparo, si raggiungono alcuni ruderi rappresentati da uno spesso muro che gli abitanti chiamano “castello”. Esso, in realtà, faceva parte di una torre a pianta quadrangolare dove risiedeva il potente barone che possedeva anche la chiesa-grotta di San Michele al Monte Raparo.
All’interno del castello, come si sa, avvenivano numerose feste durante la quali avvenivano fatti inspiegabili. Si racconta che una volta fu trovato un uomo impiccato in un sotterraneo, mentre un’altra volta scoppiarono le botti dove era depositato del buon vino lucano, pronto per la grande cena. Anche il barone, in effetti, non sapeva come mai avvenissero quegli strani fatti e decise di indagare assoldando un sacerdote della chiesa parrocchiale di san Chirico. Costui, da furbo, aveva inventato un modo per movimentare le feste. Aveva meditato di continuare a realizzare eventi strani senza indagare su quelli inspiegabilmente accaduti.
Passò qualche mese quando il barone, in occasione dell’anniversario del suo matrimonio, chiese al sacerdote di controllare che le vivande fossero al loro posto e fuori pericolo da un intervento soprannaturale. Non fece i tempo a parlare che si udì un forte rumore simile al tuono. Tutti si affacciarono dalle finestre e dalle feritoie del castello, ma non si vide nulla; solo il sacerdote sapeva, poiché aveva messo in una grotta della polvere greca per farla saltare in aria. Ma il bello doveva ancora venire.
Lo spavento fu così forte, che il furbo pensò di trovare un motivo per sollazzarsi alla corte del castello, e per sempre questa volta. Con il consiglio del barone si era deciso di dare un vitalizio al religioso, affinché egli badasse che eventuali spiriti del castello fossero placati dalla presenza religiosa. Ciò sta ad indicare che in quelle zone, nel Medioevo, non sempre gli abitanti erano così legati al culto cristiano, ma invece cadevano nella superstizione pura e semplice come gli antichi pagani. Accadeva, dunque, che anche i religiosi trovassero qualche espediente per far rinsavire il popolo, ricorrendo anche a pratiche magiche che gli ignoranti ritenevano di grande effetto. Nel caso del castello di San Chirico Raparo, il sacerdote rimediò più della fede del volgo, ma anche del barone.
Arrivò così la sera della festa, ed il sacerdote aveva preparato qualche sorpresa che anche gli invitati pensavano fosse una trovata del barone. All’improvviso, durante il ballo, vi fu un tremendo e vero terremoto che tutti corsero fuori, tranne il malefico sacerdote. Egli aveva creduto che fosse un altro di quei boati che egli stesso provocava, ma quando furono tutti all’esterno, le mura del castello si richiusero seppellendo per sempre l’uomo.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI SAN FELE
L’insediamento di San Fele, posto a circa 872 metri s.l.m. sull’estremità nordoccidentale della Basilicata, quasi al confine con il territorio di Calitri, in Irpinia, si trova nel punto in cui si incrociano le strade fra Atella, Rapone, Muro Lucano e Ruvo del Monte, fatto che impone di supporre che l’insediamento corservi molto di più di quello che è visibile, soprattutto se si pensa ad un eventuale presenza normanna e sveva nel territorio.
Nei pressi sorge il luogo detto Perno o Pierno, dove sorge la chiesa di Santa Maria, probabilmente costruita sotto gli auspici di Riccardo di Balvano prima del 1175, la quale potrebbe quindi far ubicare l'antica Armaterra sulla cosiddetta Civita di S. Fele.
Arroccata quest’ultima su di un’altidudine di 960 metri, conserva una struttura a pianta rettangolare che fa individuare quel “castrum Sancti Felicis” a cui erano tenuti alla manutenzione, nel 1277, gli abitanti di Rapone, Ruvo del Monte (Sancti Thome de Ruvo), Bella e del casale di S. Maria di Perno. Dalla relazione di Arduini del 1674 sappiamo che il castello era “di forma bislonga e fabricato a guisa di un vascello, ma è quasi distrutto e con la sola prospettiva di mura (...) Federico II (...) lo strinse anchora, e per renderlo del tutto inespugnabile, e lo fiancheggiò di alcune mezze lune e torrioni, le vestigia de quali si vedono, benchè rovinate e disfatte”.
In questo castello, prima che fosse ridotto alla stato di rudere, si racconta che era abitato da marito e moglie, che vivevano piuttosto miseramente, quasi di stenti. Una mattina, spinto dal bisogno, l’uomo disse alla donna: “Speriamo di riuscire a buscarmi una giornata di lavoro in campagna. Andò infatti in un fondo e trovò da zappare. Mentre zappava, passò l’imperatore che gli chiese: “Vecchio feudatario, come ti sei ridotto?” “Eh, signor, mi sto cercando di guadagnarmi qualcosa per pagarti le tasse e per non morire di fame Ma non ce la faccio più per la debolezza. Sai, non sono abituato a lavorare”.
“ Ora ti darò io un pezzo di pane”, rispose il re, “ma non devi darlo a nessuno. Devi mangiarlo solo tu con una fetta, e potrai saziarti per molto tempo e fare a meno di venire a lavorare; attento, ripeto a non darlo a nessuno”.
Il vecchio castellano se ne tornò rianimato a casa e la moglie nel vedere quel pane gli domandò: “Chi te 1’ha dato?” “Stà zitta moglie mia. Me l'ha regalato l’imperatore in persona e mi ha detto che con questo pane saremo sazi chissà per quanto tempo e che non avrò più bisogno di lavorare”. Allora la moglie suggerì: “Perchè non lo portiamo alla comare che ha bottega, così ci dà in cambio un pò di pasta?” “Forse forse hai ragione”, disse il marito, che tuttavia si dispiaceva di tradire la promessa fatta al benefattore, portò alla comare il pezzo di pane, per averne in cambio pasta e i olio, ma anche ceci fave cicerchie.
Terminate le provviste il bravuomo fu costretto di nuovo a rimediarsi la giornata e, ripassando l’imperatore da quelle parti si sentì rivolgere meravigliato “Ancora qui ti trovi? Che ne hai fatto del pane che ti ho regalato? Ti dissi che non dovevi darlo a nessuno. Basta, ora te ne regalo un altro e saraà pena se lo dai a qualcuno”.
Quando il vecchio tornò a casa tutto contento la moglie vide il pezzo di pane e riprese a tentarlo “Marito mio, portiamolo alla comare, vedrai quanto bendidio ci darà”.
“Eh no, cara moglie, ne va di mezzo la mia vita. Quel signore me l’ha detto e ripetuto”. “Ma diàmogliene almeno una metà”, insistette la donna. “Beh; la meta si può anche darla”. Si lasciò convincere, “Avanti, prendi il coltello e dividiamolo in due”. Ed ecco che, così facendo, vennero fuori dal pane tante di quelle monete d’oro che la moglie per la gioia, cadde ai suolo e morì. Il vecchio castellano, allora, lasciò passare del tempo, prese il pane con tutti i tarì che c’erano dentro, e si trasferì in casa della comare e là visse felice cent anni, abbandonando del tutto il castello di San Fele.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI SANT’ARCANGELO
A circa a tre chilometri da Sant'Arcangelo sorgono ancora maestose le mura di un grande palazzo baronale chiamato "della Cavallerizza". Il toponimo fa intendere che il luogo era una posta per cavalli o, invece, un luogo fortificato dove sorgeva, probabilmente, un villaggio distinto da Sant’Arcangelo.
Vi si vedono ancora alcune ampie stanze, che rammentano il medioevo, i racconti superstiziosi e i potenti feudatari.
Questo palazzo, per lo più un edificio baronale, fu edificato da Eligio della Morra ed era composto di tante stanze per quanti giorni ha l'anno. Intorno vi si ammirava un incantevole e vasto giardino, tanto che quella contrada si chiama ancora "Mura di Giardino".
Qui risiedeva il feudatario di Sant’Arcangelo non avendo ancora costruito nell'abitato il palazzo baronale, e vi si divertiva nel domare e crescere i cavalli di razza.
Due volte l'anno, da contrade vicine e lontane, veniva grande quantità di gente per la fiera dei cavalli di don Eligio.
E non solo compratori di professione, ma anche signori e signorotti, che rimanevano colpiti, oltre che degli splendidi esemplari equini, del numero e della vastità delle stanze del castello che, ovviamente, Eligio faceva mirare ai suoi ospiti.
Ogni stanza aveva un suo nome; impossibile elencarli tutti; si sa, però, che erano presi o da antichi guerrieri o da santi o da fenomeni naturali; C'erano. per esempio, le stanze di Enea, di Ulisse, di Achille, di Orlando, di Rinaldo, di San Leone, di San Gregorio, di San Gerardo, della tempesta, del fulmine, della luna, della nebbia.
Erano tutte affrescate con scene o episodi che ne giustificavano il nome; caratteristiche erano, per esempio, le stanze di Ulisse e di Orlando: nell'una si vedeva l'eroe greco in atteggiamento pensoso e circondato da sei donne, di cui una nuda ma vista di dietro; più in alto, alcune dee con delle coppe in mano; sulla volta tante navi piene di cavalli e di sirene; sulla parete di fronte Ulisse, la moglie, il figlio e i Proci. Nell'altra stanza, in quella di Orlando, si vedeva una grotta con dentro Angelica e Medoro e più in là il paladino che con una mano sradicava un albero e con l'altra si batteva la fronte; sulla volta, Carlo Magno tutto triste e Gano sorridente; sulla parete di fronte Orlando mangiava cavalli.
Quando i signori di Sant'Arcangelo si costruirono il palazzo in città, la Cavallerizza perse molto del suo splendore e lentamente, a causa sia delle intemperie sia dell'abbandono, andò sempre più in rovina.
IL CASTELLO DI SAPONARA DI GRUMENTO
Il grande castello, soggiorno gradito dei Sanseverino e tipico esempio di dimora principesca, sorge sopra un colle che domina la valle dell'Agri a breve distanza dalle rovine di Grumento.
In questa fortezza, che era ricca di oltre cento sale morirono per avvelenamento i fratelli Jacopo, Sigismondo e Ascanio, figli. di Ugo Sanseverino e di Ippolita Monti.
Ugo aveva avuto, per la sua fedeltà a Federico d'Aragona, il feudo di Saponara l’1 maggio 1497 e la giurisdizione civile e criminale di Castel Saraceno; perciò suo fratello Girolamo iniziò ad odiarlo e particolarmente per aver avuto tre maschi, che gli toglievano la successione di Saponara.
Trovandosi i tre figlioli di Ugo in Taranto, furono invitati da Girolamo ad una caccia a Montalbano e, nella cena che seguì, da un fiasco sigillato fu dato da bere del vino avvelenato ai tre fratelli.
Questi, giunti nel castello di Saponara, si ammalarono e, nello spazio di sette giorni, morirono.
La madre Ippolita Monti fece erigere ai tre figli i noti monumenti nella chiesa dei SS. Severino e sono a Napoli.
Il castello, dopo il tragico avvenimento, rimase per un lungo periodo di tempo abbandonato, finché nel 1523 ne fecero il loro covo alcuni briganti, il cui capo Chiachio era molto temuto nella zona.
Ma, dopo qualche anno, nacque discordia tra Chiachio ed un suo luogotenente, che si era stancato di quella vita, e ne seguì ben presto una lotta, combattuta nello stesso castello, alla fine della quale il capo brigante solo e ormai vecchio dovette allontanarsi per sempre dalla zona e la storia ne perse le tracce.
L'avvenimento però fu risaputo fin nella capitale del Regno e fu fatto oggetto di un poema da parte di uno sconosciuto poeta del tempo; il poema, di cui purtroppo si è perso, forse aveva un titolo del tipo "Chiachio di Saponara ovvero la vera Istoria della triste fine di un brigante e la punizione delle sue malvagità".
Con l'avvento del nuovo capo il castello di Saponara vide delle profonde trasformazioni e perse a poco a poco la sua cattiva fama, fino a diventare uno dei più importanti centri, oggi si direbbe mondano-culturall della zona.
Amavano soggiornarvi principi e signori, artisti e letterati e le cento sale del castello ben potevano ospitare quella folla di personalità: una tradizione, tuttavia non confermata, vuole che durante la seconda metà del settecento il castello di Saponara venisse chiamato "Gioiello del Regno", ma i tempi cambiarono e anche Saponara perse il suo splendore...
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI TIMPA CASTELLUCCIO
Presso la fortezza piccolissima di Timpa Castelluccio, presso Muro, c’era un contadino che aspettava un figlio ed era uscito prima dell’alba, a guardare le stelle, per fare l’oroscopo al nascituro come a quei tempi si usava. Mentre osservava gli astri passò un cavaliere con uno scudiero e una muta di cani.
Vedendo il contadino guardare il cielo, il cavaliere domandò: “O buon uomo, che fate qui a quest’ora?” “Aspetto un figlio, e una indovina ha detto a mia moglie che il nostro bambino piccino diventerà il futuro Re di Timpa”. “E le stelle cosa dicono?” “Che stanotte in questi dintorni, da una famiglia di poveri contadini, nascerà il Re di Timpa, e che un re lo terrà a battesimo”. “Eh, via!”, rise il cavaliere, “come puoi credere a queste frottole? I figli dei contadini non divengono re!”.
Il cavaliere lasciò lo scudiero, seguì il contadino e intanto pensava: “Non dirò certo a quest’uomo che sono proprio io il Re di Timpa, ma qualcosa devo trovare per stornare questo predizione che mi rovina”. Quando giunsero alla cascina il bambino era già nato. “Com’è bello!” disse il cavaliere. “Io non ho figli e, se mi date questo per figlio, vi farò ricchi”. La madre si ribellò all’idea che le portassero via il piccino, ma il padre, che teneva ai denari, cercò di persuaderla.
“Vedi”, disse, “fra signori si conoscono, e forse è proprio questa la via perché nostro figlio diventi re, come vogliono le predizioni”. La donna cedette.
Battezzarono il bambino col nome di Alfonso, per riprendere un nome che già aveva una fama sul trono di Spagna, e poi lo avvolsero in una coperta di lana. Il cavaliere lo prese e, con quel fagotto fra le braccia, raggiunse lo scudiero in un fitto bosco. Gli dette subito il suo fardello e gli ordinò: “Uccidi questo bambino e buttalo in mare”. Lo scudiero tentò di dissuadere il Signore dal mettere in pratica il suo disegno Ma il Re insistette, minacciando di mandano via se n avesse obbedito. Allora il buon uomo prese il bambino e portò nel più folto del bosco; lo nascose in una tovaglia poi seguì il suo sovrano fino alla reggia. L’uomo abitava una casetta in mezzo al parco. Poi riprese la strada del bosco, cercò la grotta dove ave lasciato il bambino e lo ritrovò che piangeva per la fame. Portò allora a una contadina sua conoscente, che aveva avuto da pochi giorni un figlio, e le raccomandò di allevarlo e cura, dandole del denaro per compensarla.
Dopo quella sera, lo scudiero tornò spesso a vedere il piccolo che cresceva bello e fondo, lo raccomandava alla nutrice e la compensava ancora delle cure che prodigava. Cosi passarono i giorni e gli anni e lo scudiero, che non aveva avuto figli suoi, si sentiva sempre più legato al bambino che aveva salvato, e che, perciò, gli pareva un po’ suo.
Il bimbo, ormai ragazzino, una mattina incontrò una bambina della si stessa età, che stava raccogliendo qualche fiore. Egli restò a guardarla a lungo, senza osare di rivolgerle la parola. Da quella mattina quasi ogni giorno la Principessina tornò in giardino, trovando sempre il ragazzo col quale nacque ben presto una serena amicizia.
La Regina si accorse di tutto e ne parlò al Re, che chiamò lo scudiero e gli disse che era necessario allontanare subito i due giovani.
Al momento del distacco si dissero addio con gli sguardi che con le parole. Dopo vari mesi il padre, che la adorava, pensò di inviarla da suo fratello, che era un amico del Re di Spagna. Quando lo zio credette che il tempo avesse cancellato dal cuore di lei il ricordo del giovane, bandì una grande giostra, nella quale i più nobili giovani del suo regno e dei reami vicini avrebbero combattuto in scontri e duelli, e promise che la Principessa avrebbe offerto di sua mano il palio della vittoria al vincitore.
Alla sfilata si presentò anche, per ultimo, un giovane, su un purosangue candido: portava lo scudo senza alcuna insegna, segno evidente che nobile non doveva essere. Lo strano giovane tuttavia legò sulla sua corazza un fazzolettino rosa leggerissimo, quasi a indicare che quello era il suo emblema e la sua insegna. Chiarastella, seduta al posto d’onore, si sentì mancare dall’emozione riconoscendo immediatamente un dono di addio che aveva dato a quel ragazzo.
Dopo il duello, l’unico vincitore fu il personaggio misterioso. La Principessa, commossa oltre ogni dire, si alzò, si chinò verso il Re e gli chiese il permesso di concedere, come premio al vincitore, la sua mano; e avutone un lieve cenno di assenso, porse la sua mano al bel cavaliere.
Il Re di Timpa, presente in incognito alla giostra, riconobbe il giovane giardiniere, ma non fece opposizione. Così il ragazzo divenne il futuro successore di Timpa.
(di: P. Rescio)
LA TORRE DI SATRIANO
Tra Picerno e Tito, su di un colle difficile da scalare, si eleva una torre alta, di base quadrata, fra i ruderi di una città abbandonata. Si tratta solitaria testimone della distruzione di Satriano, grande centro lucano che nell’antichità fu sede di diocesi, quindi insediamento importante lungo la strada che da Potenza raggiungeva le parti più meridionali della Calabria passando per la Valle del fiume Mèrcure.
Satriano ebbe sempre degli abitanti irrequieti verso la Corona Imperiale, ed era già famosa per vicende che rasentavano la ribellione. Questi sentimenti, ricordati dai centri attuali di Tito e Satriano di Lucania, furono la causa della sua distruzione.
Un giorno, nei primi anni del Quattrocento, passavano per il paese alcuni gentiluomini della città di Campagna (prov. di Salerno); erano degli armigeri che provenivano dalla città di Terlizzi, in provincia di Bari, da cui avevano prelevato una bellissima fanciulla che era stata scelta come damigella e cameriera della regina Giovanna II di Napoli.
Quando gli uomini d'arme passarono per Satriano per potersi ristorare un pò i paesani restarono meravigliati dell'arrivo della bella terlizzese e le si fecero vicini e tutti volevano vederla al suo passaggio, dimostrandole con apprezzamenti anche pesanti, il loro compiacimento. Gli accompagnatori rimasero seccati di questa folla e cercavano di passar oltre, quando alcuni ragazzacci si aprirono il varco e con la forza rapirono la donzella e la trascinarono via.
La folla fuggì, mentre i gentiluomini pregarono, scongiurarono, perché fosse ridata loro la fanciulla; e finalmente l'ottennero, ma solo il giorno successivo.
Mortificati, ma indignati, i cavalieri ripresero lì cammino verso Campagna. Giunti a destinazione informarono la regina Giovanna dell’accaduto, ed essa ebbe motivo di vendicarsi dei continui affronti di Satriano; i nobiluomini fecero suonare a raccolta i loro fedelissimi soldati, mentre spargevano la notizia dell'affronto fatto a loro e alla cameriera della regina. Ecco che tre compagnie di soldati partono per Satriano: arrivano di mattino, salgono per il paese, uccidono per le strade, entrano nelle case; assetati ancora di vendetta appiccano lì fuoco agli edifici: tutto è bruciato...
Satriano fu un mucchio di rovine, su cui rimase emblematicamente solo la torre.
Gli abitanti superstiti si rifugiarono nei paesi vicini e vi portarono lì tragico racconto, tramandato di generazione in generazione, abbellito di episodi.
Nella torre, si racconta, è ancora sepolto, custodito dal diavolo, un grande tesoro, di cui s’impadronirà un dannato all'inferno che, a mezzanotte, con un 501 colpi di scure, reciderà un sambuco.
IL CASTELLO DI TRECCHINA
Il castello di Trecchina è situato in posizione eminente e circondato da folti e rigogliosi castagneti.
Ivi convennero spesso dame e gentiluomini dai feudi vicini, per cacce e altri divertimenti del tempo, coi quali il duca cercava di alleviare le sofferenze delle giovini spose.
Molte spesso, oltre alle tristi leggende, tuttora in voga tra il popolo, di signori tirannici, di scene di sangue, di trabocchetti, di veleni, vi sono fatti mondani, come sembra accertato a Trecchina (al contrario di molti altri feudi della Provincia), che non ebbe feudatari oppressori, ma signori che non si avvalsero mai dei privilegi odiosi, che la civiltà del tempo pur loro conferiva a diritto.
Più che di un castello, si deve parlare di un palazzo baronale, che fu fatto costruire nel 1530 dal feudatario Antonio Palmieri, barone di Latronico.
Piccolo il feudo, piccolo il castello, formato di due piani: quello a piano terra, composto di otto vani e di un lungo corridoio centrale: era addetto agli armati, ai familiari, ai depositi, alle cucine; e quello superiore addetto al feudatario, composto di sei vani e di un vasto salone.
In esso immetteva la lunga gradinata interna, che si partiva da una specie di peristilio, compreso fra il corridoio e il portone d'ingresso.
Sui lati sud e nord lunghe file di feritoie, insieme ad una torretta merlata posta sulla parte centrale del palazzo e ad un'altra torre posta sulla strada d'accesso, difendevano la dimora del signore, mentre sul lato est, strapiombante sulla valle, s'aprivano gli ampi e soleggiati veroni.
Il castello non era una ricca e splendida dimora, poiché abitato dal feudatario solo nelle saltuarie e brevi visite alle terre, né una solida costruzione perché già verso la fine del 1750 era in rovina, prima cioè che lo spaventoso terremoto del 1783 ne abbattesse le ultime vestigia.
Anche la sua posizione assai elevata lo rendeva maggiormente esposto all'opera deleteria del tempo.
Il castello visse il suo periodo più bello e più romantico con Giovanna Zufia, moglie di a Gianbattista Pescara e duchessa della Saracena (1615).
La duchessa Giovanna, di cagionevole salute, venne a stabilirsi per lungo tempo nel ridente per quanto modesto maniero.
IL CASTELLO DI VITALBA
Molte storie, si sa, nascondono una verità. Le vicende del popolamento medievale, inteso come una serie di nascite ed abbandoni di centri abitati, come Vitalba presso Atella, denotano che le condizioni economiche non erano per tutti tranquille.
Prima che il casale fosse abbandonato in età angioina, c’era una famiglia afflitta da povertà e disgrazie infinite che si era ridotta a due soli stretti parenti: il nonno e una nipote che si arrangiava da cucitrice. Il re di quel paese, che aveva fama di essere assai capriccioso, un giorno volle che qualcuno gli indovinasse quanto valeva la sua barba. Ordinò pertanto alle guardie di far salire su al palazzo tutti coloro che fossero passati per quella via. Passò il primo cittadino, le guardie lo condussero davanti al sovrano il quale gli ordinò di sedere e gli impose: “Tu devi indovinare quanto vale la mia barba”. Il povero cristiano non seppe che rispondere e di conseguenza fu mandato in prigione. Passò il secondo, poi il terzo e poi il quarto e a ciascuno capitò la stessa sorte.
Intanto il nonno e la nipote pativano sempre più freddo e fame; essi abitavano in un sottano nelle vicinanze del palazzo reale e per rimediare qualcosa dovevano transitare dove le guardie fermavano i passanti. Allora la nipote disse al vecchio: “Vai su alla reggia e quando sei dinanzi al re digli che nell’ora della morte la sua barba vale quanto la tua”.
Il nonno, spinto dal bisogno, passò per quella via, le guardie lo chiamarono e gli ordinarono di salire dal re.
E il re gli rivolse la stessa domanda. Il vecchio rispose: “Quando morirai, Maestà, la tua barba varrà quanto la mia”.
“Bene!”, esclamò il re stupito. “Chi ti ha imbeccato?”
“Nessuno” rispose il vecchio.
Il re replicò: “Bada, devi dirmi la verità se no ti mando in prigione”.
Il vecchio, intimorito, allora rispose: “Perdonami la superbia. E’ stata mia nipote”.
“Oh, bravo! Conducimi qui tua nipote” fece di rimando il re.
Il vecchio, mai immaginando come se la sarebbe cavata, andò a chiamarla e il sovrano, volendo premiare l’acume della fanciulla e assicurarsi un pò di giudizio a corte, pensò bene di darla in sposa all’erede al trono.
(di: P. Rescio)
STORIE E LEGGENDE DEI CASTELLI IN PROVINCIA DI MATERA
il castello Tramontano di Matera
Il Castello Tramontano è situato su una collinetta, chiamata collina di Lapillo, sovrastante il centro storico della città di Matera.
In stile aragonese, il Castello, con un maschio centrale e due torri laterali rotonde, smerlate e dotate di feritoie, fu fatto costruire a partire dal 1501 dal Conte Gian Carlo Tramontano, feudatario di Matera. Il nuovo Re di Napoli, Ferdinando II, aveva promesso ai Materani di non cedere più la città ad alcun feudatario, dopo che questa si era già liberata più volte dal giogo feudale pagando diversi riscatti per restare città libera ad autonomo reggimento, cioè dipendente direttamente dalla Corona Reale. Invece il Conte Tramontano, che vantava crediti nei confronti dell’Erario Reale, chiese ed ottenne la Contea di Matera nel 1496.
Il Conte si rese presto inviso ai Materani in quanto con il passare del tempo si riempì di debiti, per far fronte ai quali tassava la popolazione con gravose imposte. Cominciò così la costruzione del Castello, che era situato su una collina dominante la città, al di fuori delle mura cittadine, con lo scopo di controllo “feudale” dei terreni circostanti più che di difesa della città stessa. Pare che poi la costruzione avrebbe dovuto comprendere altre torri di difesa, una delle quali è stata rinvenuta sotto la centrale piazza Vittorio Veneto di Matera insieme ad altri ambienti ipogei. Per la costruzione del Castello furono spesi ben 25.000 ducati e ciò andò a gravare ancor di più sulla popolazione.
Fu così che alcuni cittadini, stanchi dei continui soprusi, si riunirono nascosti dietro un masso, che da allora fu chiamato u pizzon’ du mal consigghj, cioè la pietra del mal consiglio, ed organizzarono l’assassinio. Il 29 dicembre 1514 il Conte, appena uscito dalla Cattedrale, fu assassinato in una via laterale della stessa, che fu successivamente chiamata in modo eloquenteVia del Riscatto. Il Castello restò dunque incompiuto.
Dal 2008 è interessato, insieme al parco circostante, da lavori di restauro terminati nel 2011.
Quando Matera fu feudo degli Orsini, duchi di Gravina di Puglia, un Francesco Perron, presidente del tribunale della Sommaria, recatosi a Matera per una informacion del stado cosi descrive questa città: "La città di Matera situata su un altopiano è circondata da buone mura, e da fossato naturale di roccia dura; vi è un buon castello non ancora finito di costruire, lontano dalla città un tiro di balestra e situato su di un colle, dominante la medesima e circondato dalla vigna e dal giardino del barone".
Intorno al XVI sec. era signore di Matera il conte Giovan Carlo Tramontano "strano conio di uomo. che improntava nel rovescio ogni maggior contraddizione, comeché ardito e astuto, doppio e leggiero ad un tempo, e quanto prodigo e generoso altrettanto avido e crudele; che umile e povero qual usciva da S. Anastasia, casale di Napoli, sapeva divinir ricco e onorato, ascese si sublime da assembrarsi tra signori di grado e di feudi, fregiato della nostra Contea".
La sua larghezza di vivere dovette fortemente indebitarlo: a Napoli, infatti, aveva condotto una vita di lusso, superiore a quella di patrizi ben più qualificati.
Giunto in Matera, iniziò a vessare i cittadini con non poche tasse, con cui saldare le molte migliaia di ducati tolti a prestanza nelle passate emergenze; e, per far fronte nel contempo a sempre maggiori dispendi, non si curava affatto dello stato della popolazione.
Accortosi che la comunità, ridotta quasi all'estrema miseria, non l’amava e che i nobili, per lo spirito d'indipendenza, lo odiavano del tutto, pensò di premunirsi contro possibili sommosse e si innalzò una rocca di difesa sopra una collina che domina la città, donde "con qualche specie di soffioni, sagro, falconetto. gerifalco, mezza-colubrina, verrato o petardo che fosse, avrebbe potuto prenderne vendetta".
Verricelli nella sua Cronica della Città di Matera nel Regno di Napoli (1595 e 1596): "La città è tutta admurata con altissime torri, quali all’antica quale a tempo che si combatte con balestri hera inespugnabile cossì come oggi sarebbe a guerre senza artelleria et a tempo che la maestà di Re Ferrante donò questa Città Carlo Tramontano di Santo Nastaso casal di Napoli con farlo Conte; il detto Conte si sforzò ad murarla tutta con lli borghi et parte de colline dentro e già cominciò a fare il Castello ad modo del Castel novo di Napoli anzi più superbo et ni fè edificare solo una faciata con uno torrione grande in mezzo et uno per ciascun lato più piccoli a tempo che si pagava la giornata de l'homi sey grana et altre tanto del cavallo et si despese con danno del populo docati vinti cinqua milia como oggi si può videre nelle scadde di notar Roberto Agata il quale tenne conto di detta fabrica".
Nel 1515, sempre a Matera, avvenne la tragica fine di Giancarlo Tramontano; egli, infatti, nonostante le sue precauzioni, uscito dal Duomo, si prestava ad entrare nel cunicolo segreto che aveva fatto scavare e che conduceva al Castello, quando venne trucidato da alcuni popolani che da mesi attendevano che fosse s loro portata.
Il castello vero e proprio presenta elementi progettuali sia vecchi che nuovi. Il fossato e la considerevole altezza del torrione centrale servono da impedimento all'avvicinarsi delle macchine ossidionali. L'enorme spessore delle murature inoltre è inversamente proporzionale all'altezza dei torrioni che risultano fortemente ribassati per resistere alle sollecitazioni degli spazi dei cannoni. La torre centrale è identica, come modello, al Castel Nuovo..
Secondo la testimonianza dl Francesco Perron –riportata dal Sarra– la civita di Matera era chiusa in parte da mura cordonate e conformate, inferiormente a scarpata e, in parte, difesa da fossato naturale di roccia dura...
Lungo le mura spiccavano torri cilindriche, anche cordonate, in nu-mero di sei. Da un manoscritto anonimo attribuito dal Gattini al sacerdote Belisario Torricelli, si apprende che le sei torri lungo le mura furono fatte edificare, a proprie spese, da un certo Metello, valoroso capitano, che riportò vittorie sui Saraceni e prese stabile dimora nella citta.
Di queste sei torri non ne rimasero in piedi che due: l’una detta appunto di Metello o "matellana, l’altra di Capone, nome di un cittadino di Matera
Secondo alcuni le vecchie mura erano costellate di porte principali e secondarie; tra queste ultime si ricordano quelle della civita o della torre metellana –dalla quale si scendeva sul versante barisano–; della postergole, dalla quale si raggiungeva il fondo della gravina.; del giudice Pirrotto e infine la porta empia o dei santi, dalle quali si accedeva sul versante del Sasso Caveoso.
A cavaliere della civita si ergeva il castello. "Questo maggior propugnacolo da ultimo con merli, balestrieri, spalti, torrioni, corridoi coverti, segrete, alloggiamenti… si trovava in un grande spiazzo sul sito più elevato dell’abitato..."(Gattini).
Non se conosce l’epoca della costruzione; tuttavia la si può porre verosimilmente verso il IX-X sec.
Esisteva certamente nel 1160, perché si ha notizia del castellano di quell'anno, un certo Bisanzio. "È noto che il castello nel sec. XV apparte-neva a Giovanni Orsini del Balzo il quale nel 1448 lo donò ai cittadini"(Contillo); fu quindi diroccato e sostituito da abitazioni private.
(P.Rescio)
il castello di Bernalda (MT)
Il castello di Bernalda è un momento situato nell’omonima città, in provincia di Matera.
Il castello di Bernalda si trova in una posizione dominante sulla valle del Basento orientato verso sud-ovest. Fu costruito nel 1470 ma recenti scoperte fanno risalire la presenza di una fortificazione già in epoca Normanna e la forma delle sue torri fa supporre che fosse addirittura di origine Angioina. Il castello attuale è quello fatto erigere da Bernardino de Bernaudo segretario di re Alfonso II di Napoli. Dal nome del feudatario prenderà il nome l’intera città. Nel 1735 vi dimorò Carlo III di Borbone, il quale volle visitare i territori del suo regno, appena acquisito, in seguito alla guerra di secessione polacca.
Il castello ha una forma quadrangolare ed ha tre torri angolari, questa tipologia architettonica è propria dei castelli costruiti alla fine del 400. Le torri hanno una forma cilindrica con la base più larga in confronto alla sommità. Originariamente la struttura era molto più grande e comprendeva altre torri. Ma con il tempo e con continui aggiustamenti il castello fu molto rimaneggiato nelle dimensioni. Le tre torri rimaste hanno delle fortificazioni rivolte sia all’esterno della struttura che all’interno del castello. Nella parte interna del castello vi sono diversi cunicoli, uno in particolare raggiungeva la Val Basento ed era una via di fuga in caso di assedio, a causa della paura di quest’ultimo De Bernaudo fece costruire più di dieci pozzi acquiferi per avere una riserva illimitata d’acqua.
L’antico castello di Bernalda fu e ricostruito al tempo di Bernardino de Bernauda –segretario dei re Alfonso II, Ferdinando e Federico d'Aragona– su un edificio più antico. Il feudatario, che edificò anche la città, che quindi prese il nome dal suo padrone, presso l'antica Camarda.
Indubbiamente il castello è aragonese, anche se la sua prima costruzione va posta sotto i normanni, quando Riccardo da Camarda ebbe in feudo le terre dell'attuale Bernarda e di Ferrazzano. Per oltre un, dal 1300 al 1470, il castello fu ben mantenuto ed abitato dai vari signori, tra i quali si ricordano Pietro Tempesta e Bernando del Balzo.
Dal 1470 in poi troviamo il castello disabitato: forse a causa di uno dei frequenti e tremendi terremoti che sconvolgevano periodicamente la regione, e precisamente a quello del 1466, che distrusse –come vuole erroneamente una tradizione– tutto l’abitato di Camarda. E tutta la zona restò spopolata o, comunque, relativamente abitata, nonostante che Pirro del Balzo, feudatario di Venosa, tentasse di farvi dimorare non poche famiglie fuggiasche di Schiavoni, Albanesi o Greci. Lo stesso Pirro pensò di ricostruire il castello, ma non ne fece nulla, premendogli forse più Venosa e così solo nel corso del XVI sec. diede inizio ai lavori di ricostruzione.
Tra i successivi abitanti del castello, va ricordato don Nicolò di Peres-Navarette, che con privilegio del 28 marzo 1607 si intitolò duca di "Bernauda".
Il castello domina la valle del Basento e ancora oggi fa bella mostra di sè. Degno di nota è il fatto che nel castello fu ospitato, nel 1735, Carlo III di Borbone, il quale, agli inizi del suo regno, volle personalmente visitare i territori del napoletano avuti in seguito alla guerra di successione polacca.
Le mura di cinta assecondano la natura del terreno; sono per lo più perpendicolari e, per brevi tratti.
Non si conosce con esattezza il numero delle torri, poiché attraverso i vari rimaneggiamenti il perimetro si è andato sempre più restringendo. Allo stato attuale, oltre alle tre ancora i piedi, esistono tracce di almeno altre cinque.
Esse erano formate da un piano interrato, adibito prevalentemente a deposito, da un piano terreno, i cui mezzi d’offesa guardavano prevalentemente all’interno, e da due piani superiori aperti sul cortile, ad eccezione del torrione sud.
Il castello possiede almeno quattordici pozzi, che dimostrano chiaramente come doveva essere difficile per gli abitanti della rocca procurarsi acqua in caso di assedio.
(di P. Rescio)
il castello del Malconsiglio di Miglionico (MT)
Il Castello del Malconsiglio è il castello di Miglionico (Matera), costruito su un colle della città a partire dall’VIII-IX secolo, in una posizione strategica, noto per aver ospitato nel 1485 la Congiura dei baroni. Ebbe due successivi ampliamenti, il primo nel 1110 ed il secondo nel 1400. Ha la forma di un parallelogramma, fiancheggiato da sette torrioni, alcuni quadrati (i più antichi), due bitorri e altre circolari, poste ai vertici della costruzione.
L’entrata attuale è posta a Nord-Est, mentre quella originaria distrutta dal terremoto del 1857 era rivolta a Sud. Al suo interno, e precisamente al piano superiore, vi sono l’androceo ed il gineceo, ilSalone del Malconsiglio, dove si tenne la congiura, e la Sala della Stella o degli Spiriti, la parte più bella e segreta del castello, con il soffitto a stella e con degli scrigni dove venivano custoditi i tesori ed i documenti più preziosi.
Appartenne nel tempo al conte Alessandro di Andria, ai Sanseverino di Bisignano, ad Ettore Fieramosca, ai Pignatelli, ai Caracciolo ed alla famiglia Revertera, duchi di Salandra.
Il Castello da roccaforte a residenza
L’architettura castellare in Basilicata è ricca di notevoli complessi per la maggior parte poco conosciuti ed indagati. I manufatti nella maggior parte dei casi portano i segni di notevoli trasformazioni: le originarie roccaforti normanne, le poche fabbriche sveve, i castelli angioini e aragonesi, a partire soprattutto dal cinque-seicento, sono quasi tutte trasformate in residenze gentilizie per le grandi famiglie comitali. L’esistenza di complessi fortificati nel territorio della regione trova riscontri in documenti fin dal secolo IX e X e soprattutto in epoca normanna a partire dalla metà del secolo XI. Spesso il toponimo degli abitati è preceduto dalla specificazione di castellum o castrum che indica la natura fortificata del luogo e già nell’ambito del territorio circostante Miglionico molti centri portano questa definizione. Alla fine del sec. X essa è comune a Tricarico e Tolve coinvolti in uno scontro con una banda di saraceni insediati nel castrum di Pietrapertosa; nell’anno 889 il sito di una proprietà nei pressi del Bradano appartenente al monastero longobardo di S. Vincenzo al Volturno è indicata come limitrofa al castellum Montis Caveosi e per tutto il trecento il castrum Jugurij indica il sito di un antico borgo fortificato nel territorio di Pomarico. Dalla seconda metà del secolo XI i due termini, con molta più precisione, indicano esclusivamente i nuclei fortificati mentre per i centri abitati diventa prevalente l’uso del termine civitas e i nuclei minori sul territorio, che con i centri maggiori costituiscono l’ossatura del sistema insediativo sviluppatosi e consolidatosi a partire dalla fine del secolo X, sono denominati casali. La costruzione delle più importanti roccaforti normanne nel territorio lucano, il castello di Melfi centro politico della nuova entità statuale, il nucleo originario del castello di Lagopesole, risale alla prima metà del secolo XI ma le tracce di una diffusa presenza di strutture castellari, purtroppo quasi cancellate dalle trasformazioni successive, si rinvengono in tutti gli abitati sedi di importanti famiglie comitali. A Tricarico è edificata la grande torre e l’annesso castello poi trasformato in convento francescano; altri grandi strutture fortificate sorgono a Brienza, ampliate e restaurate in epoca angioina e infine daiCaracciolo a partire dal secolo XVI; a Moliterno il castello è ampliato in epoca angioina e poi completamente ricostruito dai Carafa prima, e dai Pignatelli nel XVI e XVII sec; a Laurenzana il castello normanno sorge su una imponente rupe e sarà ampliato nel secolo XV dai Dal Balzo e dai feudatari successivi, i Poderico e i Filangieri; a Lavello l’imponente struttura attuale di epoca aragonese sorge su un preesistente edificio normanno mentre a Montescaglioso il castello edificato nei primi decenni del secolo XII è ristrutturato dalla famiglia Cattaneo nel XVII secolo. In Basilicata un aspetto particolare dell’architettura castellare è rappresentato dai centri medioevali abbandonati i quali conservano tracce consistenti delle originarie strutture fortificate. Uno dei complessi più imponenti dell’intera regione è quello di Uggiano a Ferrandina.
Tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo si estendono gli interventi sui manufatti esistenti, e soprattutto si attiva una nuova committenza legata all’affermarsi delle grandi famiglie feudatarie che in ogni paese di Basilicata erigono le proprie residenze o ampliano i castelli già esistenti intervenendo spesso anche sulle cinte fortificate degli abitati, ampliate ed allargate. Queste condizioni si affermano e si sviluppano soprattutto nella prima metà del trecento e nel secolo successivo quando la piccola feudalità angioina degli ultimi decenni del duecento è sostituita dalle grandi famiglie legate ai D’Angiò prima e alla monarchia aragonese dopo. I Sanseverino edificano castelli e palazzi fortificati a Tricarico, Miglionico e Marsico, i Del Balzo costruiscono il castello di Venosa e restaurano quello di Montescaglioso, la famiglia Tramontano innalza il Castello Tramontano a Matera e i De Bernardo la fortezza di Bernalda. Se gli impianti insediativi delle strutture normanne sono strettamente correlate al luogo nel senso di assecondare con dislivelli ed un’apparente disomogeneità delle strutture che si adeguano ai pendii ed alle asperità orografiche, le poche costruzioni federiciane, si rapportano al sito per adeguarlo ad un rigoroso impianto geometrico. La suggestione esercitata dalle fabbriche imperiali sulla committenza successiva è notevole ed è rintracciabile negli impianti a parallelogramma e quadrangolari di alcuni complessi lucani tra cui spicca il castello di Miglionico. Il grande manufatto è edificato sulla sommità di una collina prospiciente il centro storico dal quale probabilmente era separato dal declivo naturale del pendio che chiaramente è stato modificato con terreno di riporto e la costruzione di un terrapieno per consentire il collegamento tra abitato e castello. Il nucleo originario è costituito da tre ali edificate ed assemblate secondo uno schema perfettamente quadrato di cui il quarto lato, rivolto verso l’abitato non è occupato da edifici ma era certamente definito da una cinta che conteneva l’ingresso. La struttura ha torri circolari poste agli angoli intervallate da alcune torri quadrate mentre la forma triangolare di un recinto aggiunto sul lato non edificato, all’interno e all’esterno del quale si addossano successivi ampliamenti tra cui la chiesa completamente trasformata nel secolo scorso, è determinato dal rapporto con l’orografia dell’area. Al piano terra l’impianto è scandito da una serie di ambienti modulari coperti da volte a crociera mentre al piano superiore la scansione si ripete con coperture a botte a sesto rialzato nel settore meridionale e a crociera costolata nell’ala nord-occidentale. La presenza delle eleganti e slanciate costolature nell’area della residenza comitale unitamente ad una monofora tardo-gotica in un ambiente di raccordo, le piccole monofore della cappella, quella sottostante il loggiato secentesco e i due portali ogivali, uno per l’accesso al piano superiore e l’altro al pianoterra, confermano la datazione del nucleo originario del complesso ai primi decenni del sec. XIV. Il paramento esterno in pietrame locale in molte parti evidenzia interventi successivi seguiti forse a crolli o determinati da lavori di manutenzione che in alcune aree si presentano come vere e proprie sopraelevazioni che interessano le falde dei tetti la cui orditura è stata modificata: le ipotesi di un ampliamento, nel senso di un sopraelevazione di tutto il complesso, necessitano ovviamente di una verifica approfondita direttamente sulle strutture. L’area dell’accesso ha subito notevoli trasformazioni anche in tempi recenti con crolli e demolizioni effettuate subito dopo la vendita dell’immobile da parte del comune che ne era venuto in possesso dopo le leggi abolitive della feudalità. In questa zona, tra l’altro, sono presenti alcuni elementi erratici, collocati sull’edificio adiacente l’accesso, una costruzione tardo ottocentesca innalzata sui resti delle murature della cinta e nell’archivolto in tufo dell’ingresso. Una scultura tardo romanica di spoglio rappresentante un leone proviene forse dal portale originario o da qualche altra fabbrica, come anche le mensole trecentesche, analoghe ad alcune esistenti nelle navate della Chiesa Madre che definiscono l’imposta dell’attuale portale del Castello mentre lo stemma del Sanseverino di Bisignano apposto lateralmente nell’attuale accesso era collocato sicuramente sull’ingresso originario. Al lato meridionale più tardi sarà aggiunta un’altra costruzione, contenente un’ampia sala oggi divìsa in due ambienti, che determina anche la trasformazione in grande loggiato del corpo immediatamente antistante. Le caratteristiche dell’edificio, anche se definito da strutture tipiche degli impianti di difesa, sono quelle di un grande complesso la cui funzione è tuttavia legata soprattutto alla residenza di una grande famiglia comitale, elemento che con il passaggio del feudo di Miglionico dal Sanseverino alla famiglia Revertera che lo acquista nel 1624, determina la definitiva trasformazione del castello in residenza baronale. Ai decenni successivi all’acquisto risale il nuovo sistema distributivo del complesso, organizzato in una prima fase lungo un profondo loggiato addossato al lato settentrionale del cortile che più tardi è arricchito da un serie di archivolti in tufo, e successivamente è prolungato verso gli altri lati del quale quello rivolto a sud è caratterizzato da un porticato coperto a crociera.
L'avvenimento storico che ebbe per centro questo castello è la Congiura dei baroni contro re Ferdinando d'Aragona il Vecchio.
Nel 1485 i turbolenti e malcontenti baroni si riunirono in un salone del castello, di straordinaria grandezza. Quel dramma, che finì con la tragica catastrofe di quasi tutti i baroni della stessa dinastia Aragonese e con la rovina e lo scompiglio del popolo.
La Sala in questione fu d'allora chiamata del "Mal Consiglio". Notare che il re stesso venne in quella circostanza nel castello.
Da quanto si è riferito "può argomentarsi da chi non l’ha veduto quale esser dovesse la sua grandezza. per albergare un Re con la sua Reale famiglia, tanti Signori e seguito di ciascuno e quindi comprendersi ancora quale in quel tempo esser doveva la sua importanza da tenere in sicura difesa così grandi congiurati.È perciò che la sala specialmente nella quale tali cose si trattarono con tanti simulati ragionamenti, ha mantenuta sempre la sua celebrità, col distinto nome di Sala del Mal Consiglio, quale con ammirazione, nel passato. è stata sempre visitata". La sala vera e propria, però, fu distrutta dal terremoto del 1857.
Poiché il pian terreno è diverso dal piano superiore, che fu fatto costruire dal conte di Andria Alessandro –sembra– nel 1110; poiché il pian terreno, nel detto anno, era già mal ridotto; bisogna parlare, circa l'origine, dell’VIII-IX secolo.
Non si conosce però la data precisa. Così pure si perde nell’antichità la data certa del primo barone del castello.
Al castello si accedeva per un’antica attraverso cui si entrava nell’atrio interno e, al centro, si vedeva una grande ed antica cisternane, e la lunga gradinata, a capo della quale.
Nel 1487, dopo la congiura dei baroni, Ferrante d’Aragona lo concesse a Giovanni Nauclero I Sanseverino, che dopo la cacciata degli Aragonesi da Napoli, ne furono proprietari quasi ininterrottamente fino al 1624, anno in cui l’acquistò Ippolito Revetera dei Duchi di Salandra.
Questi signori lo persero in virtù di espropriazione forzata nel 1829 e, nel 1861, infine, in seguito a un decreto fu incamerato al Demanio.
Il castello ha la forma di un poligono ad otto lati, ma in realtà presenta un nucleo quadrangolare rinforzato, ai vertici, da torri a pianta circolare raccordate da cortine, al cui centro vi è una torre quadrilatera, "se non che dilato d’innanzi è poco più corto di quello di dietro e sta sito alla punta della crociera verso il sud, su di un terreno pietroso cinto alla base da grosse mura con terrapieni, e fiancheggiato da sette torrioni, due dei quali, negli angoli di dietro. sono formati a doppie torri, più quattro bastioni a scarpa, con le loro sommità coronate da merli".
Il suo ingresso, preceduto da un lungo e largo spianato, è rivolto a nordest, ma forse l'ingresso originario era però a fianco della presente, cioè guardava il sud.
(di P. Rescio)
il castello di Valsinni (MT)
Il Castello di Valsinni, in provincia di Matera, dove visse la poetessa petrarchista Isabella Morra, fu edificato presumibilmente su una pre-esistente fortificazione longobarda, nei primi anni dopo il 1000.
Nel suo libro «Isabella Morra e Diego Sandoval de Castro» Benedetto Croce cita le origini del maniero facendole risalire ad un Castrum Romano posto a difesa dell’ultima chiusa sul fiume Sinni, che da quel punto in poi si apre verso il Mar Jonio. Il Castello deve il suo valore storico e la sua notorietà alla poetessa che vi nacque, intorno al 1520, e vi fu uccisa dai fratelli a circa 26 anni d’età quando scoprirono la sua relazione con Diego Sandoval de Castro, barone di Bollita.
Il castello con il feudo di Favale (odierna Valsinni) era pervenuto ai Morra, potente famiglia di origine irpina, attraverso Menocca Vivacqua di Oriolo, agli inizi del 1500, ed essi ne furono i feudatari, con alterne vicende, per circa 140 anni, fino al 1638.
Dal 1921 il castello è di proprietà della famiglia Rinaldi.
Visitare il castello di Valsinni significa riportare e rievocare la nobile figura e la pietosa storia di Isabella Morra, poetessa dalle poche, ma calde pagine, vibranti tutte di un affetto vero e potente.
Il castello di Favale sorgeva in luogo alpestre e selvaggio, non molto discosto dal mare, sopra il fiume Sinni. Fu questo che diede il nuovo nome alla terra, che oggi si chiama Valsinni.
Il feudo baronale dipendeva dai Sanseverino, principi di Salerno, grande famiglia con la quale i Morra vantavano comune origine normanna. Il primo feudatario di Favale fu Antonio Morra, il cui figlio, sposando Luisa Brancaccio, genera, oltre a sette fratelli, la piccola Isabella
Isabella cresceva sana nell’amore della poesia. Lettrice assidua di poeti, grande sognatrice di gloria, chiusa tra gente rozza, in quel luogo selvatico.
Il tetro castello la impauriva: le grandi sale erano fredde e mute, soprattutto dopo che il padre e l’amato fratello Scipione divennero esuli in Francia. Nel bosco che circondava il castello la fanciulla dovette vivere solitaria per alcuni mesi, mentre i suoi fratelli passavano, come tutti i signori del tempo, fra cacce e banchetti.
Dal castello si scorgeva la vetta del monte di Favale, e Isabella tentò comunque di fuggirne data la sua indole petrarchesca. Essendo amica di Antonia Caracciolo, forse si innamorò di suo marito, l’affascinante Diego Sandoval de Castro, con il quale intraprese una fitta corrispondenza.
Nella sua camera, durante la notte nel 1546, i barbari fratelli, che avevano conosciuto le intenzioni della sorella, e soprattutto di Sandoval, piombano furibondi sopra l’infelice Isabella e, a colpi di pugnale, pongono fine ai suoi miseri giorni.
(di P. Rescio)
il castello Berlingieri di Policoro (MT)
Attestato già nel Catalogus Baronum (XII secolo), il castello di Policoro sorge a pochi chilometri dalla costa jonica, su di una motta in posizione dominante non solo sulla modesta borgata di casupole a punta, ma sull’area un tempo ricoperta dall’imponente Bosco Pantano, ormai ridotto ad un’ombra di quello che fu, specie dopo la bonifica ad opera dell’Ente Riforma degli anni ’50: prima di allora, per la sua estensione, era considerato “seconda foresta d’Italia”.
Nel 1232, stando a Riccardo di San Germano, Federico II vi si fermò a radunar le truppe per la spedizione contro i Saraceni di Sicilia.
Il territorio di Policoro, assieme al castello, fu poi oggetto della politica di massiccio infeudamento operata dal potere angioino. Dopo alterne vicende (è doveroso menzionare, però, che in alcune carte del XVI secolo la struttura castellare viene ancora annotata qualeturris) che ne hanno radicalmente cambiato l’aspetto, è attualmente oggetto di nuovi lavori di ristrutturazione.
Il torrione che si può notare nell’immagine settecentesca fu demolito (i contrafforti residui sono visibili alle spalle della struttura), e con il materiale di risulta furono costruiti nuovi ambienti a scopo abitativo.
Pochissimo si conosce del castello di Policoro. Sappiamo che il 5 ottobre del 1239 Federico II impartisce alcune disposizioni sui castelli cui la popolazione doveva provvedere alla manutenzione. Tra coloro che dovevano stimare e provvedere alla riparazioni ordinarie e straordinarie l’imperatore svevo aveva nominato Guidone del Guasto per la Terra di Bari, la Terra d’Otranto e tutta la Basilicata.
Tra i castelli demaniali sono nominati il castello di Brienza nel Giustizierato di Principato, la "domus Girifalci" sul Bradano (in Terra d’Otranto), i castelli di Matera, "Turris Maris", Acerenza, Melfi, Muro e San Fele, oltre a quattordici castelli feudali ed altri dieci luoghi fortificati.
Nell’elenco dei castelli e delle relative località i cui abitanti dovevano provvedere alla riparazione è nominato il castello di Policoro, cui erano tenuti a riparare gli abitanti di Policoro, Scanzano, Colobraro, Rotondella e Trisaia, più altri abitanti delle contrade vicine.
Ciò significa che il castello di policoro doveva difendere un vasto entroterra, ma di cui non si conosce alcuna fase costruttiva.
Gli stessi abitanti di Policoro vogliono individuare nell’antico castello la Masseria Berlingieri, sontuoso palazzo baronale del XVI-XVII sec., dove pare avvenissero degli strani fatti legati alle vicende dei briganti.
Si racconta, infatti, che uno socnosciuto brigante si fosse rifugiato nella Masseria Berlingieri e avesse attentato alla moglie del signore del Palazzo. L’odio per la tentata violenza fu così grande, che la stessa donna uccise il giovane mentre dormiva nel suo letto.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI PIZZOCORVO
Presso Pizzocorvo, una fortezza-masseria a sud di Matera presso Ferrandina, c’era un Re che non aveva figli e per averne avrebbe fatto l’impossibile. Cercava dunque d’essere gentile e caritatevole con tutti, specialmente con la povera gente, nella speranza che la riconoscenza degli altri gli fosse d’aiuto. Non era però altrettanto nota la ragione di tutta quella sua bontà, né si sapeva ch’egli sperava, come ricompensa, di avere un figlio. Ma dopo aver fatto tante opere di pietà il re si stancò e cambiò stile di vita.
Non ascoltava più le richieste d’aiuto; chiuse il cuore alla compassione, e si rifiutò si dare soldi ai più poveri. Divenne anzi cupo e scontroso. Si chiuse nella reggia, senza ricevere più nessuno, neppure la Regina. La notizia del mutamento del re non era ancora andata per il mondo, quando alla porta della città giunse un vecchio pellegrino stanco che camminava a stento, quasi strascinando per terra la lunga barba.
Dopo quello che aveva udito sul conto del re, si meravigliò moltissimo di non trovare nessuna buona accoglienza alla porta. Non volevano neppure farlo entrare, perché vecchio, stanco e povero.
Venne rifiutato dagli ospedali, scacciato dalle mense, e alla fine cadde mezzo morto dinanzi alla porta del palazzo, guardata non soltanto dai soldati, ma anche da cani ferocissimi. Stava per essere addentato e arrestato, quando arrivò la regina, che ancora serbava un po’ di pietà per i disgraziati. Alle lamentele del pellegrino, ella cercò di scagionare il Re, rivelando il dolore segreto ch’egli aveva di essere rimasto senza eredi. Il pellegrino sorrise amaramente e, scuotendo la bianca testa, disse: “Il re, tuo marito, sbaglia prima a far del bene per uno scopo suo personale e sbaglia ancora a non farlo più, essendo stato deluso. Tu che sei più virtuosa di lui, compi almeno un’opera di pietà, ma senza volere ricevere in cambio nessuna grazia. Aiutami a rialzarmi, ma non pensare al figlio, che verrà se Dio vorrà”.
Dopo qualche mese la regina, con grande commozione, annunziò al re d’attendere un bambino. La stessa cosa, più in segreto, disse la domestica al proprio marito. Nacquero così due bellissimi bambini, somiglianti fra loro come gemelli: uno della regina, l’altro della domestica. Il primo venne chiamato Federico; il secondo Nino.
Crebbero insieme. Insieme impararono a giocare. Insieme impararono a parlare. Insieme impararono a cacciare; e, poiché i tempi lo richiedevano, insieme impararono anche a guerreggiare.
Ma la spina nel cuore del re non si era totalmente spuntata, perché, osservando con attenzione la condotta dei due giovani, s’accorse che il figlio della domestica era più dotato del suo. La differenza era lieve, era addirittura impercettibile, ma Nino aveva sorriso un istante prima di Federico. Era più destro nei giochi, più sicuro nella mira dell’arco, più agile nel cavalcare, più rapido nel maneggio della spada.
Il re era geloso di lui e non lasciava occasione per umiliarlo e rimproverano. Un giorno, nell’assenza di Federico, giunse a ferirlo sulla fronte. Nino però non lo tradì mai; disse d’aver battuto la testa contro lo spigolo d’una tavola. Poi, per celare la cicatrice, si calcò bene il cappello sulla fronte, cercando di non scoprirsi. Capì però che l’aria della corte non gli era più propizia. Chiese licenza al re e partì in cerca di fortuna.
Il re era soddisfatto. Chi soffrì della decisione di Nino fu Federico, che lo amava davvero come un fratello. Egli non era mai stato geloso dell’amico e non aveva mai fa pesare sul compagno il suo titolo di principe. “Dunque”, gli andava dicendo, “non t’importa nulla me! Tu dici di volere andare in cerca di fortuna. Ma noi stata per te fortuna nascere in questa reggia e crescere insieme a me?”.
Alle parole di Federico, il figlio della domestica si commosse, ma fu irremovibile. Piantò il coltello nel terreno e da lì spuntò una sorgente, e disse all’amico: “Ecco, questa sarà la fonte delle mie notizie. La vedi zampillare, chiara e fresca, vorrà dire che godo buona salute. Se la vedrai torbida, vorrà dire che sono ai malato o mi trovo in disgrazia”. Balzò in sella, spronò il cavallo e sparì.
Ogni mattina, Federico andava alla fontana, che per m ti giorni si mantenne abbondante, limpida e fresca.
Per molto tempo la fontana si mantenne abbondante e tersa. Ma dopo un po’, improvvisamente, divenne arsa e torbida.
Nino, durante un temporale presso Pisticci, si rifugiò in una grotta, dove cercò di entrare anche una cerva. “Entra pure e sii la benvenuta”. Ma la cerva, facendo l’atto d’aver paura, iniziò a parlare: “Grazie. Ma ho paura dei cani, che vogliono mordermi”. Nino legò i cani che erano con lui, ma la cerva continuò: “Grazie, ma temo che il cavallo mi uccida con i suoi calci”. Nino legò le zampe del cavallo. “Sarebbe bene smontare l’arco e spuntare le frecce”, continuò a dire la cerva “e infine legare anche la spada”.
A questo punto la caverna fu scossa da un boato e riempì di fumo. La cerva sparì ed al suo posto un orribile mostro: era l’Orco, che aveva preso la forma cerva per attirare lo sfortunato cavaliere in un tranello.
La mattina dopo, Federico vide la fontana che, con goccioloni quasi neri, sembrava piangere per la sorte di Nino. principe decise subito di correre in aiuto dell’amico.
Arrivò presso Pisticci dove vide che il paese era in lutto per la scomparsa del giovane, creduto ormai morto. Alla vista di Federico, che era la copia perfetta dell’amico, tutti esultarono, portandolo in trionfo alla reggia. Federico non volle rivelare chi egli fosse. “Che cosa ti è accaduto?”, gli chiedeva la principessa. “Non ricordo”, rispondeva Federico. “Sei forse entrato nella foresta dell’orco?”. “Può darsi”. “Hai forse visto la cerva fatata?”. “Mi pare di sì”. “L’Orco si trasforma spesso in quell’animale tanto grazioso...”. Federico capì tutto. Trovò la foresta, entrò nel folto bosco dove gli apparve la solita bellissima cerva. Anche allora scatenò il temporale. Allora anche Federico si rifugiò nella caverna. Anche allora la cerva, fingendosi timorosa, gli chiese d’entrare, pregandolo di legare i cani e il cavallo, di rompere l’arco, di spuntare le frecce e di chiudere la lama della spada. Ma Federico fu più accorto del suo amico, perché ormai sapeva che nella cerva si celava un terribile mostro.
Sguainata la spada, le tagliò la testa. La caverna fu scossa da un boato, si riempì di fumo, e ai piedi di Federico, invece della cerva, un orribile mostro giaceva in una pozza di sangue. Segui un silenzio nel quale Federico udì il flebile lamento dell’amico, che era incatenato sul fondo della caverna. Lo liberò e lo portò all’aperto. Arrivarono a Pisticci, ma presto partirono per la loro casa comune, ovvero Pizzocorvo.
IL CASTELLO DI ALIANO
Una tradizione vuole che Aliano fosse stata fondata tra VI e VII sec. d.C. sul luogo di un’antica fortificazione, il “Praesidium Allianum”, dal nome del fondo rustico appartenente al potente romano Allius. Questa storia, quindi, affonda le sue radici nell’antichità più oscura.
Passavano in quella zona eserciti di normanni e di bizantini per contendersi le terre a ridosso della pianura ionica, quando ad Aliano, piccolo borgo medievale, arrivarono alcuni pellegrini diretti verso la città di Potenza per venerare la tomba del vescovo Gerardo.
Gli Alianesi erano conosciuti per l’ospitalità, ma in quei periodi di guerra non c’era tanto da fidarsi, per cui i pellegrini furono messi al corrente che dovevano dimorare nel castello, ospiti del conte della zona. I pellegrini furono contenti e, dopo aver cenato, si apprestarono ad entrare nelle camere messe a disposizione del conte.
In realtà solo uno di questi era un normanno infiltratosi nel gruppo che, rimasto sveglio tutta la notte, tentò di forzare la porta principale del castello per far entrare, questa volta, non altri pellegrini, ma i nemici dei Bizantini. La spia tentava e tentava, ma il portone non si apriva. Una forza oscura impediva di aprire il portone. Preso dalla preoccupazione, l’uomo, senza svegliare alcuno, si affacciò da una finestra della fortezza, e vide…nulla! Guardò ai piedi della costruzione, ma nella notte gli sembrava che il castello fosse sospeso in aria, senza alcun appoggio. Fuggì verso la stanza degli ospiti, ma pur provando a dormire, pensava di rimandare il tutto alla notte successiva. Ma non riuscì a prendere sonno.
Il giorno seguente il paese era in fermento, poiché si diceva che, nella notte, si erano visti dei cavalieri normanni che, ad un certo punto, si erano portati indietro. Essi, in realtà, non vedendo alcun segnale della spia, pensarono che fosse accaduto un intoppo non pianificato, come in effetti avvenne.
Passò la giornata tranquilla e la notte si preparò a scendere sul villaggio. La spia, questa volta, aveva uno strumento appuntito per forzare il portone che avrebbe consentito la conquista del borgo. Niente, provò e riprovò, ma niente. Il conte, nel frattempo, si era accorto degli strani movimenti dell’uomo e lo seguì sino all’ingresso del castello. Fu allora che egli vide qualcosa di incredibile: la spia aveva aperto la finestra ed era rimasto incantato di fronte a quella visione della notte precedente: il castello era sospeso nell’aria.
Forse Dio volle che la città, per un certo periodo, dovesse ancora appartenere ai Bizantini, ma è certo che San Gerardo di Potenza ebbe un devoto pellegrino che prima lavorava da spia per conto dei Normanni.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI CALCIANO
Nessuno conosce l’origine di Calciano. L’interpretazione del toponimo riporterebbe alla presenza, nel territorio, di materiale da costruzione, oppure da "Gaudianum", altomedievale, che indica una presenza longobarda e di un paesaggio ricco di foreste.
Forse si tratta –ma è tutto da verificare– dell’antico casale fortificato di Andriace, un insediamento che i documenti attestano donato nel 1068 Roberto di Montepeloso (Irsina) al vescovo di Tricarico, per passare alla Badia di Santa Maria di Banzi. Una carta indica i confini di Andriace riprendendoli da una carta dell 1100 esibita in un giudizio nel 1774: "… dalla porte di Petrolla, dal fiume Salandrella come va per Porticella sotto i monti Jugali e va per Portella e per Alvano con retrocorso va al vallone che mette capo alla pianura, cominciando a Matina e va al vallone detto Saponara fino a confini di Bellicoro (Policoro). Dalla terza parte, da’ confini di Bellicoro per Jugones al fiume Salamandra".
L’insediamento fu venduto nel 1354 al vescovo di Tricarico. Il casale, che mutò la propria denominazione in Casale di San Pietro, risulta disabitato nel 1575, periodo in cui il villaggio risulta ancora abitato in quell’area che gli abitanti di calciano indicano, appunto, la "Calciano Vecchia".
Qui, tra le numerose e splendide grotte del vecchio insediamento, alcuni narrano che fu costruito il Monastero di S. Pietro, l’unica costruzione vera e propria di Calciano Vecchia.
Sembra che solo più tardi, però, un signore del luogo scacciò i monaci cattivi e si insediò nel monastero trasformandolo in castello o dimora baronale.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI CAPUTO
Nel territorio del Comune di Stigliano sorge il castello di Masseria Caputo; si tratta di una torre con ambienti padronali dell’Ottocento, che documenta un periodo veramente d’oro per la Basilicata, prima che il suo territorio fosse completamente sfruttato e depauperato della sue ricchezze silvo-pastorali.
Qui, un tempo, viveva mastro Giuseppe Caputo, da tutti ritenuto un uomo fortunato: lavorava poco, guadagnava quanto gli bastava e trascorreva la giornata chiacchierando, mangiando e bevendo con gli amici. Era panciuto, basso, largo di cintura e due gambe corte. Portava un paio di calzoni così ampi che potevano contenere un tomolo di fave, aveva la testa grossa, un grossissimo naso da peperone due piccoli occhi.
Era soprattutto un gran ghiottone di frutta e non si faceva pregare specialmente se si trattava di fichi. Si considerava soddisfatto solo quando aveva svuotato il paniere che aveva dinanzi. Allora si puliva le labbra col palmo della mano due o tre volte, si allentava i pan-taloni e allegro cantava: “Megera megera, tienimi contento quanto ti pane tienimi gagliarda questa ciccia specie quando mi è vuota”.
Vedovo senza figli abitava, nei tempi che Stigliano era appena un villaggio, in una strada che portava a Cirigliano dove, come dicevano gli antichi, si radunavano le streghe.
Una notte mastro Giuseppe, mentre ronfava stando supino sul letto, cominciò a sentire un fonte dolore di pancia. Dapprima cercò di sopportare pensando al paniere di fichi della mattina, ma poi non ne poté più, s’infilò i calzoni e uscì di casa per un bisogno.
Non l’avesse mai fatto! In un attimo si vide circondato da gatte nere. “Buonasera mastro Giuseppe”, cominciarono. E chi gli dava un pizzico al sedere nudo, chi gli tirava l’orecchio, chi gli abbassava il cappello sugli occhi. Mastro Giuseppe si vide in pericolo e voleva scappare, ma le gatte aumentavano di numero e lo assediavano contro un tronco d’albero di giuggiole.
Allora si credette perduto e cominciò a pregare e a piangere perché non gli facessero del male. Le streghe alla fine ne ebbero compassione e proposero in coro un patto: “Mastro Giuseppe Caputo, noi ti lasceremo per fatti tuoi quando ci reciterai due versi”. “Mi chiamo mastro Giuseppe Caputo, in questo giro mi sento stretto, se questa volta arrivo a scampare non mi vorrò più intrippare”.
Le streghe alla fine lo lasciarono in pace.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI CIRIGLIANO
Il toponimo di Cirigliano, dall’evidente origine romana, rimanda all’antico casale nominato nel Catologo dei Baroni e i cui abitanti erano tenuti, nell'età sveva, a riparare la fortezza di Anzi.
Deserto nella prima metà del Cinquecento, nella prima metà del secolo successivo risulta di nuovo abitato.
La brevissima storia di Cirigliano non può che riportare ad una vicenda legata al castello che, nel paesaggio urbanistico, è riconoscibile dalla torre circolare di età aragonese con beccatelli pensili.
La storia, raccolta presso alcuni pastori, racconta un fatto di sangue avvenuto nella torre.
Il signore del castello possedeva due bambini, fratelli, che crebbero d’amore e d’accordo per moltissimi anni.
Per lungo tempo il signore ebbe ad accudire ed educare i figli, quando uno di questi si macchiò di un delitto efferato: si era invaghito di una fanciulla del paese, l’aveva rapita ed uccisa in un raptus, ma non volle raccontare nulla al padre.
Un giorno, dopo alcuni mesi, venne a bussare alla porta del castello un’antica amante del feudatario di Cirigliano che gli raccontò tutto dell’accaduto, visto che in paese le voci volano come il vento e non hanno muri od ostacoli.
L’amante del feudatario confessò, inoltre, che quello scellerato era suo figlio: "Tua moglie, pace all’anima sua, mi chiese di scambiare due neonati per non farti dispiacere: così la fanciulla nata da lei l’ho presa io, mentre il bimbo mio l’ho dato a te!"
Il segreto era così crudo, che il povero feudatario si impiccò proprio nella torre di Cirigliano.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI COLOBRARO
La nascita del paese di Colobraro, si sa, viene ricondotto alla distruzione e all’abbandono della colonia greca di Eraclea, durante la guerra di Roma contro Pirro re dell’Epiro. Costruita nei pressi di un cenobio di monaci italo-greci dediti al culto di S. Maria del Cenofio, ebbe fama e nome per lo strano nome che porta, proveniente da "coluber", cioè serpente. E da qui inizia la nostra storia.
Il villaggio sorge su rocce ripidissime e le strade di divergono e convergono con suggestione. Pare che il castello baronale, posto in cima, conservi alcuni segreti che non tutti conoscono. Ad esempio, che nel fondo dei suoi pozzo si trovano centinaia di serpenti che dal contado vi trovano rifugio.
Un giorno il barone del castello ingaggiò alcuni suoi bravi per prendere alcuni di questi serpenti per far spaventare i sudditi di Colobraro. "Così" –egli diceva-"nessuno oserà più parlare contro di me che sono il padrone assoluto!"
Uno dei suoi bravi volle intrufolarsi tra i numerosi sotterranei del castello, ma non vi fece più ritorno. Gli altri compagni iniziarono a preoccuparsi, ma il barone non volle ascoltare, da insensibile che era, alcuna scusa per non andarci. "Andate, vi dico, ed il tesoro che è colà ve lo regalerò tutto", ma niente, nessuno ci andò e furono impiccati tutti.
Furono giorni di terrore per tutto il paese, poiché il barone diventava ancora più duro con i suoi sudditi. Tutti, in paese, sapevano che egli cercava qualcuno che sfidasse i luoghi impenetrabili della sua meravigliosa dimora per prendere quei serpenti. Colobraro, il paese dei serpenti, stava per vivere un giorno memorabile. Fu così che si presentò alla corte un giovane volenteroso; non era bello, ma amava la fanciulla del barone: occhi azzurri, dolcezza infinita per scoprire il segreto dei serpenti. "Tu volere mia figlia? Ma neanche per sogno!" Il giovane si dispiacque e disse:"Tu non conosci il segreto dei serpenti, ma mettimi alla prova, poiché tu dici che scoprirò il tesoro che essi custodiscono"
Il barone accordò ed il giovane si calò da uno dei duecento pozzi del castello. Si intrufolò fra le pareti rocciose ed umide di Colobraro, quando vide… un vero tesoro! Prese qualche serpente e salì frettolosamente per il pozzo.
"Allora, cosa hai visto?", e il giovane: "Dammi in sposa la tua bellissima figlia e solo dopo lo saprai: eccoti anche le ricchezze che ho trovato". Così diceva e apriva un sacco pieno di monete d’oro luccicanti. Venne il giorno del matrimonio e il barone organizzò una festa sontuosissima.
"Dimmi il segreto, forza!"
"Te lo dirò subito; ho scoperto chi sono quei serpenti: sono le anime dei baroni cattivi e Dio vuole che essi, dopo la morte, paghino le colpe col restare in fondo al pozzo".
Fu così che Colobraro, paese dei serpenti, ebbe un barone buono e generoso sino alla sua morte.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI CRACO
Craco oggi appare un paese abbandonato o, meglio, una città morta, ma alcuni abitanti dalla cultura e gentilezza eccezionali come il vigile Tuzio e l’anziano Pietro Tuzio impongono di studiare e salvare questo grande centro della Basilicata.
In realtà l’insediamento di Craco è documentato per la prima volta nel 1060, quando si trova inserito tra i possedimenti dell’arcivescovo Arnaldo di Tricarico, e intorno al 1168, quando il primo feudatario è un certo Erberto. Ancora nel 1176-1179 Craco è in mano di Roberto di Pietrapertosa, giustiziere regio, che possiede con il collega Fulco di Miglionico una corte con l’assistenza di due giudici di Montepeloso (Irsina) e del camerario di Forenza.
L’idea del feudatario riporta subito all’evidenza più consistente, cioè alla torre quadrangolare che si erge sull’abitato. Essa, in origine servita da scale di legno, all’interno doveva essere organizzata in una serie di stanze e soppalchi, le cui tracce sono ancora visibili dalle pareti esterne.
Quasi con certezza, è questa torre ad essere la sede in cui troviamo Goffredo, feudatario nel 1239, che per ordine di Federico II vi rinchiude alcuni prigionieri lombardi. Si racconta che qui Federico II avesse rinchiuso questi prigionieri in botti di legno e, provocando in esse un foro per guardare l’interno, li uccise, per sperimentare se l’anima uscisse dal corpo dei cadaveri.
Con la morte dello svevo e con la successione al regno dell’imperatore francese Carlo I, cioè dopo il 1266, scaturisce che la città fu posseduta da Pietro de Beaumont, e pochi anni dopo, nel 1277, registra 83 "fuochi", cioè famiglie.
Più oscure si fanno le vicende successive, secondo le quali il feudo passò alla famiglia Monforte alla fine del XIII sec., per poi passare alla famiglia Del Balzo e agli Sforza nel XV sec. Nel corso del secolo successivo Craco appartenne alla nobile famiglia dei Sanseverino, i quali promossero certamente uno sviluppo urbanistico, durante il quale sorgono i grandi palazzi nobili, come Palazzo Maronna, dove vivevano famosi farmacisti; Palazzo Carbone, già della famiglia Rigirone, ubicato nella parte più settentrionale ed estrema dell’abitato, fu costruito anche in quest’epoca.
Palazzo Carbone è ricordato nella vicenda storica della Basilicata della fine del Settecento sino al compimento dell’Unità nazionale, quando la società lucana iniziò a registrare segni di dinamismo e di rinnovamento; sulla scia del rinnovamento riformatore napoletano andò crescendo, nella popolazione contadina, un nuovo ceto dirigente noto come "borghesia rurale", formatosi dall’unione di "massari", professionisti ed intellettuali. Con le sommosse e i tumulti avvenuti a Potenza, Montescaglioso, Cancellara, Matera, Rionero e Ruoti, Craco assiste al tentativo dei contadini di occupare le terre comunali e quelle ecclesiastiche indebitamente occupate. Fu proprio da Palazzo Carbone che i vecchi nobili si rifugiarono tutti con armi e munizioni; essi, presi dallo spavento delle rivolte, dopo una riunione plenaria, spararono contro gli insorti che si erano adunati a valle. Fu così che i ribelli subirono la sconfitta tra il marzo e l’aprile del 1799 ad opera delle forze guidate dallo spietato cardinale Ruffo.
La sconfitta degli ideali repubblicani e la prosecuzione dei saccheggi da parte delle vittoriose truppe francesi causò la rinascita più cruda e violenta del brigantaggio.
Il resto è storia attuale: nel mentre si realizzavano le fognature, negli anni Cinquanta-Sessanta, l’acqua infiltrò nei terreni argillosi ed iniziò a provocare disastri e lesioni profonde effetto di numerose frane di scorrimento.
Gli ultimi abitanti del luogo dicono che la causa di tutto era il serbatoio dell’Acquedotto, che immettendo le acque nelle fognature ne impregnava il terreno.
Quella torre e quel castello, che fecero nascere Craco potendolo difendere dalle incursioni nemiche, ora sono considerate causa del completo spopolamento.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI FERRANDINA
Nel luogo dove sorge l’odierna Ferrandina, un tempo, insisteva il castello di Ferrazzano o Ferracciano, un centro che alla fine del XII sec. era posseduto da Riccardo de Camarda. Qui pare fosse successo un fatto che sconvolse totalmente questo abitato.
Abbandonato e deserto, fu rifondato, sembra, nel 1470 e nominato Ferrandina in onore di Ferdinando d’Aragona, dopo che gli abitanti del vicino castello di Uggiano corsero a ripararsi dal violento terremoto.
Ma la storia è proprio questa?
Non sappiamo, eppure sembra che questo Riccardo di Camarda fosse un terribile signore che vessava la popolazione di tasse e gabelle sino all’inverosimile per la sua piccola e sfarzosa corte.
Un giorno venne al castello un signore con delle ricche vesti; egli si presentò al castello di Ferrazzano e al cospetto di Riccardo; egli offrì ricchi tessuti al signore, che non ne volle sapere di comprare dato il caro prezzo. Allora, il viandante si allontanò dicendogli che li avrebbe regalati alla popolazione di Ferrazzano.
La leggenda continua e dice che una volta che gli abitanti di Ferrazzano indossarono quelle meravigliose vesti, diventarono così belli che i loro vicini di Uggiano, e soprattutto le fanciulle, facevano a gara per sposarsi con loro.
Fu così che quasi tutti gli abitanti di Uggiano si trasferirono a Ferrazzano.
Anche se le date non coincidono, la storia racconta che quel viandante era proprio Ferdinando d’Aragona, il cui figlio rifondò davvero l’antica Ferrazzano, ma dopo aver demolito il castello del tiranno.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI GANNANO
Nel castello di Gannano di Sotto, una bellissima masseria fortificata in agro di Stigliano, vivevano due fratelli: uno ricco di nome Giuseppe, e l’altro povero di nome Tommaso. Costui si recò, dal più grande per chiedergli qualcosa da mangiare, e prontamente gli fu offerto un intero maiale. Ma la moglie di Giuseppe che era egoista ed antipatica, rimproverò il marito per quel ricco regalo, e lanciò a Tommaso una maledizione: “Che tu possa andare a mangiartelo con la grandissima diavola!”.
Il povero Tommaso, come si sentì addosso il maleficio, anziché prendere la strada di casa, si mise alla ricerca della grandissima diavola. Caminina e cammina, gli apparve un vecchio al quale chiese “Ci vuole, molto per trovare la diavolessa”. E il vecchio disse: “Devi scendere trecento gradoni nel fondo della vallata e allora quella ti domanderà: Hai visto qualcuna che è più bella di me?, E tu dovrai rispondere: ho camminato, ho incontrato per monti e per mari e mai ho incontrato qualcuna più bella di te”.
“Giunto all’ultimo dei trecento gradoni, Tommaso bussò alla porta e la grandissimà diavola gli chiese: “Che vuoi?”. Ed egli rispose: “Ti porto questo maiale per poterlo mangiare in tua compagnia”. La diavolessa, bendisposta per quella gentilezza, lo fece accomodare, arrostirono il maiale e alla fine del pasto gli regalò un fazzoletto aggiungendo: “Ciò che desideri con questo lo avrai”.
Tommaso piegò in quattro il fazzoletto e, arrivato, a casa dalla moglie le disse: “ Maria, appicca il fuoco alle masserizie”. E Maria, stupefatta: “Se appicco il fuoco come faremo a sedercì e a dormire, marito mio?” “Fai come ti dico, non ti preoccupare”.
La moglie obbedì e il marito, toccando il fazzoletto, pronunziò: “Voglio un palazzo più grande di quello del re”. E subito apparve il palazzo, completo di mobili, tappeti, cavalli e carrozze. Tommaso saltò in una di queste per andare a invitare la cognata ed il fratello.
L'avara cognata, con tanto di occhi sgranati, volle sapere da Tommaso come avesse fatto a cambiare la sua vita. E Tommaso, ingenuo, raccontò tutto per filo e per segno. Allora la donna, che si riteneva più astuta della diavolessa ordinò al marito di fare la stessa cosa. Giunto a destinazione, la grandissima diavola, che abitava poco distante da Gannano, accolse con un ghigno il dono e domandò a Giuseppe che cosa avesse spinto a donarle un maiale; Giuseppe disse che la moglie avrebbe desiderato un fazzoletto capace di trasformare ogni cosa che toccava.
“Certo”, rispose la diavolessa, “certo, eccoti accontentato, ma devi dirle che deve toccarsi come faccio io adesso”. Gli toccò la fronte con la bacchetta, e Giuseppe, tornò a passo veloce dalla moglie. Le sfiorò la fronte con la bacchetta e, all’istante, la donna fu tramutata in oro e chiuse per sempre gli occhi.
(P. Rescio)
IL CASTELLO DI GARAGUSO
Il centro di Garaguso ha certamente origini preistoriche. Ritrovamenti che risalgono all’XI sec. A.C. sino alla colonizzazione greca fanno pensare ad un insediamento che controllava la viabilità che dalla zona costiera di Metaponto raggiungeva Potenza ed il Vallo di Diano, toccando anche Monte Croccia e Serra di Vaglio.
C’è chi dice che nel Medioevo Garaguso si chiamasse Andriace (forse l’attuale Scanzano), e sicuramente un significato a questa interpretazione deve esserci, ma considerando la bella cittadina attuale, sappiamo che nel borgo antico di Garaguso è presente, a fianco alla Chiesa Madre dedicata a San Nicola di Myra uno stupendo palazzo che dà l’impressione di un castello: è Palazzo Revertera, grande e massiccio, che si staglia sulla formazione dolomitica, con i suoi sotterranei scavati nella roccia e le stanze disposte lungo un impianto rettangolare.
Si tramanda che circa tre secoli fa nel palazzo avvenne un fatto orrendo: era nato il bambino del barone e la città, per l’occasione, organizzò una festa per salutare tutta la famiglia Revertera, ma quello stesso giorno il bambino sparì misteriosamente.
Sia il barone che sua moglie si misero a cercare l’infante, ma nulla fu trovato.
Una tradizione vuole che il bambino sia stato trovato da una famiglia di pastori che lo accudì e lo crebbe come uno dei tanti, ma un’altra tradizione dice che ancora oggi, nelle giornate ventose, si avvertono le voci dei genitori che chiamano il bambino.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI GATTINI
In questa masseria viveva il padrone che, in un tempo imprecisato, si ammalò e chiamò il suo servo più fidato.
“Giovanni –disse– sto per morire perché ormai la vecchiaia non perdona. Ti chiedo solo un ultimo favore. Mio figlio è troppo, ancora giovane per provvedere ai campi e al territorio. Promettimi che gli darai un’occhiata e lo consiglierai al meglio”. “Non preoccuparti, padrone –disse Giovanni–non lo abbandonerò mai”. “Va bene, ora posso morire, ma mi raccomando!, non fargli vedere il ritratto della Principessa d’oro che si trova in quella stanza segreta che tu sai”. “Certo, non preoccuparti”. Ed il padrone morì in santa pace.
Il dolore fu grande per tutti gli abitanti del casale e vi fu anche un solenne funerale campestre. Dopo la cerimonia, Giovanni prese il figlio del padrone e lo condusse nella Masseria.
“Vieni, devo indicarti le stanze di questo grande palazzo”. Ma il giovanotto rispose prontamente: “Come, non sai che sono già stato qui e che conosco ogni stanza…?” “Si, ma non conosci le segrete; vieni, ti indicherò le stanze più nascoste…”
Al giovane padrone non sfuggì che di tutte le stanze visitate, alcune piene di tesori e vettovaglie, ne mancava una il cui ingresso era una piccola porta. “Giovanni, dammi la chiave di quella porta!” “No, padroncino, ho promesso a tuo padre che non l’avrei fatto!”
Il piccolo s’indispettì: “Allora te lo ordino!” “Come vuoi, rispose a malincuore il servitore”.
Non appena fu aperta la porta, apparve un quadro dorato che rappresentava una donna bellissima. Era la principessa d’oro.
Alcuni raccontano che i due visitatori rimasero così impietriti dalla vista di un ritratto così bello, che ancora oggi i visitatori di casa Gattini ne vanno ancora in cerca.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI GEMS
Può sembrare strano che un palazzo di campagna possa chiamarsi Gems, eppure qualcuno racconta che questa antica dimora fosse stata abitata dalla famiglia De Gemmis, originaria di Altamura. Questa famiglia aveva deciso di fondare qui lo sviluppo della sua economia, in contrada Conconi, vicino alla chiesa di Santa Pelagia.
All’interno vi era ancora una cappella, dedicata a Santa Maria della Croce, e vi si svolgeva soprattutto un’economia olivicola.
Sin qui nulla di speciale, perché si conosce come fosse la vita di campagna di quei tempi.
Un giorno la signora Gems –così la chiamavano, in forma dialettale per “De Gemmis”–, ebbe a partorire Giovanni, un bel pargolo paffuto che, nel corso degli anni, divenne forte e bravo nella conduzione dell’azienda familiare.
Ma venne il giorno della disgrazia. Giovanni, mentre preparava l’olio per l’ottima stagione delle olive, precipitò all’improvviso in un pozzo profondissimo poco lontano dal palazzo. “Aiuto! Aiuto!” –gridò Giovanni, ma nessuno potè pensare che il povero Giovanni fosse precipitato proprio lì. Infatti, la zona è ricca di sorgenti e di cavità, per cui il richiamo di aiuto si sentiva ovunque per le campagne, trasformandosi in una specie di ululato.
I genitori, che ormai da due giorni cercavano il bravo e forte figlio, organizzarono con pastori e contadini salariati una battuta di ricerca. Nulla da fare; sembrava impossibile trovarlo.
Passò del tempo, e quell’ululato non si sentiva più; tanto che, scambiato per verso di un animale, di notte si interrompevano le ricerche; ma dopo, con rinnovato fervore, ripresero le ricerche, ma con meno speranza.
Era ormai il tramonto di un giorno qualsiasi e il padre di Giovanni andò a ritirarsi proprio nella cappella della Madonna della Stella. “Ti prego–disse pregando la Madonna–, fammi trovare mio figlio, e magari mi sacrifico io al posto suo…” All’improvviso ripresero ancora quei versi, che in quel momento si resero nitidi e distinti. “Aiuto! Aiuto!”, ripetevano. Il povero Giovanni, rimasto intrappolato nel pozzo presso la cappella fu recuperato dal padre che volle organizzare una grande festa per l’occasione.
Passò dalla mattina alla sera, e di Padron Gems non venne a sapersi più nulla; dopo la festa egli scomparve per sempre, con il dolore di tutti, che da quella sera in poi sentirono sempre una specie di ululato indecifrabile provenire dalle caverne del sottosuolo di Ferrandina e delle tenute Gems.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI GIRIFALCO
Pochi sanno che esiste una leggenda legata al castello di Girifalco, di cui è rimasta traccia solo in qualche rudere tra Matera e Taranto. Di questo castello si conoscono una data riferibile al periodo normanno, ed una più circostanziata del 5 ottobre del 1239, quando l’imperatore Federico II impartisce alcune disposizioni sui castelli cui la popolazione doveva provvedere alla manutenzione. Tra i provisores l’imperatore aveva nominato Guidone del Guasto in Terra di Bari, in Terra d’Otranto ed in Basilicata e tra i castelli demaniali sono nominati il castello di Brienza nel Giustizierato di Principato, la domus Girifalci sul Bradano (in Terra d’Otranto), i castelli di Matera, Turris Maris, Acerenza, Melfi, Muro e San Fele, oltre a quattordici castelli feudali ed altri dieci luoghi fortificati.
Al restauro o alla manutenzione del castello di Girifalco erano tenuti il casale del Sasso caveoso di Matera e i “Saraceni del casale di S. Iacopo”, cioè quei fuoriusciti che l’imperatore aveva scacciato dalla Sicilia dopo un’ennesima ribellione
Il toponimo, poi, riporta ad altre due località, come quella presso Giovinazzo in provincia d Bari e presso Torrella dei Lombardi in Irpinia.
La leggenda è oscura e racconta di numerosi omicidi avvenuti nel castello di Girifalco. Il barone dell’insediamento, si dice, aveva fatto un patto con il diavolo e gli aveva promesso bambini e donne di ogni età almeno una volta alla settimana. Così, quasi con la paura di tutti gli abitanti, il barone spadroneggiava e diventava sempre più ricco come aveva chiesta al diavolo.
Ma il patto di sangue non aveva tenuto conto dell’amore. Il barone scelse un suo fidato per raccogliere a turno gli abitanti destinati al sacrificio, ma un giorno costui aveva scelto una popolana bellissima e dolce. Non fece in tempo a sferrare il colpo sull’altare maledetto dove la poveretta era stata legata, nei piani più bassi del castello, che la vide in volto con gli occhi meravigliosi.
Il barone ordinò subito di sciogliere la ragazza e di renderla libera. Quella sera stessa apparve il diavolo in persona: “Cosa hai fatto, maledetto? Lo sai che sei destinato alla dannazione e ti verrà privato tutto se non obbedisci?”
Passarono giorni infernali per il barone che, in poco tempo, abbrutì in maniera spaventosa senza che egli chiedesse perdono a Dio.
Fu così che la storia parla che l’ultimo suo atto estremo fu gettarsi dall’alta finestra del castello, mentre tutti gli abitanti che rimasero sino ad allora preparavano le masserizie per fuggire per sempre da quel luogo maledetto.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI GIROGICA
Presso il palazzo di Girogica c’era una volta un signore povero che voleva sposare la figlia dell’imperatore e non esitò un istante ad andare da lei dicendo: “Mi vuoi per marito?”. Ma lei, la figlia dell’imperatore, non aveva alcuna intenzione di diventare sua moglie. Il signore dovette usare tutta la sua astuzia per conquistarla. Sulla tomba del padre di questo signore cresceva un cespuglio di rose. Era un cespuglio che faceva un fiore solo ogni cinque anni. Quell’unica rosa aveva un profumo così dolce, che bastava annusarla per dimenticare tutti i dispiaceri. Il signore andava molto fiero del suo cespuglio di rose che, per altro, non era neppure la sua unica ricchezza. Infatti, gli era rimasto in eredità anche un usignolo che batteva, con la sua voce, i cantanti più acclamati. Pensa e ripensa, il signore decise di offrire in dono alla figlia dell’imperatore sia la rosa che l’usignolo. Prese due astucci d’argento, ne usò uno per la pianta e l’altra per l’uccellino, e li mandò al Palazzo. L’imperatore fece portare i doni nella sala del trono, dove la principessa giocava con le dame di corte, e ordinò di aprire gli astucci. “Com’è bella”, dissero le dame in coro. “Stupenda”, confermò l’imperatore.
Ma la principessa: “Papà”, gridò piena di rabbia, “questa rosa non è d’argento e pietre preziose, ma una pianta come tante altre”. L’imperatore, che in fondo era un brav’uomo, tentò di calmare tutti. Disse dunque: “Apriamo il secondo astuccio, prima di condannare l’importuno”. Dal secondo astuccio uscì l’usignolo che si sgranchì le gambe e cominciò a cantare. La sua melodia era talmente bella, che per qualche istante tutti l’ascoltarono incantati. “Non può essere un uccello vero”, disse la signore Ma quando sfiorò l’usignolo, quasi svenne per lo spavento. “Lo è, lo è”, gridò rabbiosa. Ordinò alle sue dame di far volare l’usignolo fuori dal Palazzo. E il povero signore: “Saluti a tutti”, disse quando lo fecero entrare. “Avete bisogno di un altro servitore, qui al castello?”. Gli fu offerto e il signore accettò senza discutere e si mise al lavoro. Gli diedero una stanza vicino al porcile. Dopo un pò di tempo, “Questo porcaro ci sa fare”, decretò con entusiasmo la principessa. In quelle lande belle e verdi della provincia di Matera, la principessa vedeva sempre il pover’uomo e se ne invaghì.
Un giorno la donna volle baciarlo, ma egli prontamente disse: “No!”, senza lasciarsi intenerire. “Non hai capito la mia rosa più bella e hai disprezzato il mio usignolo che non ha pari al mondo. Ma poi, per il tuo tempo, hai baciato un porcaro. Sai qual è la nuova? Io troverò una ragazza più intelligente dite, come sposa”.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI IRSINA
(antica Montepeloso)
Irsina era conosciuta, nel Medioevo, con l’antico nome di Montepeloso, un antico villaggio situato sul Monte Irsi, dove sorgono alcuni ruderi.
Di questo castello altro non si sa che fu fatto erigere da Federico II. Oggi non esiste che una piccola torre, presso Porta Arenacea e dalla parte opposta di detta porta dovette esserci un'altra torre. considerato che il luogo ancora viene deno-minato “la Torretta”.
È certo che una tradizione riferisce che il castello di Irsina fu donato da Federico II a S. Francesco d’Assisi, il quale, giunto a Montepeloso, vi inaugurò un como-do convento che fu, poi, condotto a termine dai suoi seguaci.
Fu sempre sede di un ricco convento, nonostante la notizia che durante il regno degli Angioini si fosse tentato di scacciarne i frati, che si erano mantenuti fedeli agli Svevi.
In un antico manoscritto si legge delle lotte sostenute dai francescani, i quali, aiutati dai contadini, fecero del loro castello una rocca imprendibile, nella quale per altro trattenevano i prigionieri importanti in attesa che fosse loro pagato il riscatto.
La sicurezza del castello divenne così famosa che molti signorotti locali vi facevano custodire sia i propri tesori sia i nemici pericolosi fatti prigionieri, dopo aver versato ai frati delle somme pattuite. Il manoscritto parla quindi di straor-dinarie quantità di oro e di argento accumulate nel castello di Irsina; ciò può es-sere anche vero, se si pensa che bande organizzate di briganti lo assalivano spesso, però sempre senza alcun risultato positivo; evidentemente o i tesori erano una favola o i frati sapevano ben nasconderli.
Purtroppo nessuna delle due ipotesi può essere confermata; tuttavia la tradizione sembra dar fede alla seconda: che così erano pronti a giurarlo, fino a qualche tempo fa, i vecchietti del luogo, i quali recitavano pure una specie di filastrocca. che suonava più o meno cosi:
A Montepeloso, nel grande castello, ci stava un tesoro assai bello.
Era il tesoro di Santo Francesco dai frati sempre tenuto a lo fresco.
Rubini, topazi e acquamarine stavano tutti nelle cantine.
A Montepeloso, nel grande castello ci stava un tesoro assai bello.
O mio signore, cerca e trovi, scava la terra. sradica i rovi:
rubini topazi acquamarine, mucchi ne stanno nelle cantine.
E quando il tesoro tu troverai, ricco e felice per sempre vivrai.
IL CASTELLO DI ISCA DEL PONTE
Ad Isca del Ponte c’era una famiglia reale composta da padre, madre, una figlia che si chiamava Margherita e un figlio. Poiché i genitori avevano fatto un voto all’Arcangelo Michele venerato in Montescaglioso partirono col principino prima per questa città ,poi per Monte Sant’Angelo di Manfredonia lasciando la ragazza affidata al confessore della reggia. Disse il re al prete: “Ti raccomando di vigilare su mia figlia, sèguila con attenzione e se manca in qualche cosa correggila senza riguardi”.
Margherita aveva quattordici anni, ma per bellezza e franchezza di modi sembrava più grande della sua età.
Non appena restarono soli, il prete prese a lusingarla, a corteggiarla, e poichè lei lo scongiurava di lasciarla in pace, passò alle minacce: “Dirò al re che ti sei comportata da sgualdrina!”
Quando i genitori tornarono da Monte Sant’Angelo e s’informarono sul comportamento della figliola, il confessore rispose: “Vostra figlia è un’anima persa. Ha disonorato il palazzo”.
Il re e la regina, stravolti dalla pena, si rifiutarono di vedere Margherita e dopo una notte di tormenti chiamarono il figlio e gli ordinarono di prendere la sorella, portarla nel bosco e ucciderla.
“La verità è quella che vi ha detto il prete?” si permise di osservare il principino.
“Dev’essere la verità”, troncò netto il padre “sennò, che prete sarebbe?”
Il giovane, rassegnato, prese in consegna la ragazza, la condusse nel bosco e con le lacrime agli occhi le disse: “Mi dispiace, sorella mia, ma io debbo ucciderti”.
Margherita, rannicchiata contro un albero, si limitò a rispondere: “Tu non hai colpa, come io non ho colpa. Dio mi assisterà”. E si dispose così mansueta al sacrificio che il principino non ebbe cuore di eseguire l’ordine. Perciò aggiunse: “Costi quello che costi fingerò di ammazzarti. Dammi, ti prego, l’abito che porti”.
La ragazza si tolse la veste e gliela consegnò. Il principe si addentrò nel bosco, uccise una volpe e bagnò l’indumento nel sangue dell’animale, quindi tornò sui suoi passi: “Margherita, giurami che non rimetterai più piede in paese”.
“Giuro” rispose la sorella. Si abbracciarono e si separarono ognuno per la sua sorte.
Il re e la regina come videro la veste zuppa di sangue si ritennero appagati e fecero addobbare a lutto il palazzo per il cordoglio del popolo.
Margherita intanto vagava per la campagna in cerca di cibo e di legna per riscaldarsi. Al quarto giorno venne a trovarsi dinanzi a un palazzo dai tetti rossi che le sembrò deserto. Salì circospetta la scalinata, oltrepassò il vestibolo e scorse una tavola imbandita e a capotavola una poltrona vuota. Dopo che ebbe raggiunto il fondo della sala sentì uno strano rumore; Si trattava della casa dell’orco.
“Uh!” disse costui, avanzando sul tappeto. “Chi è che si aggira nelle mie stanze?”
La ragazza, atterrita, andò a nascondersi sotto quella poltrona e se ne stava immobile, quasi senza fiatare. Non appena l’orco si fu seduto, gli venne di fare una suono con la voce forte come un tuono e la meschina, immaginando chissà che, uscì allo scoperto e lo scongiurò di non ucciderla.
“Oh cielo benedetto!” esclamò l’orco che era di ottimo umore. “Vuoi vedere che con un mio versaccio ho generato una figlia?”
L’abbracciò, la baciò, pretese che sedesse sulle sue ginocchia e cominciò a cantarle la ninna nanna. Ma lei, col suo visetto malizioso, proruppe: “Prima che sonno ho fame, caro signore”.
“Parole sacrosante!” si rallegrò l’orco. “Non solo mi viene regalata una figlia, ma mi viene data cresciuta e di buon appetito”.
Le colmò il piatto di ogni bendidio e dopo che la vide sazia e insonnolita, la prese per mano e la guidò in una camera dalle pareti bianche e azzurre assicurandosi che le piacesse perché d’ora in poi lì avrebbe dormito.
Bisogna sapere che il palazzo dell’orco confinava con quello del re della Isca del Ponte e dietro il giardino del re della Isca del Ponte ruspavano più di cento galline. Quando esse scorsero l’insolita creatura affacciata alla finestra, invidiose cominciarono a canzonarla: “Nonno orco t’ingrasserà, ti carezzerà e con un boccone ti mangerà”.
Margherita tutta turbata non osava raccontare all’Orco ciò che aveva udito; ma quegli si accorse della sua tristezza e le chiese: “Che ti è successo che non ridi e non balli?”
La fanciulla, con la voce che le tremava, riferì la profezia delle galline: “Mi ingrasserai, mi carezzerai e mi mangerai in un boccone”. Al che l’orco, accigliandosi: “Ribatterai a quelle stupide bestiole che tuo nonno ti farà grande e bella e ti farà sposare il loro principe. E poi che con le loro penne riempiremo i guanciali e con le loro carni faremo banchetti”.
La serva del re della Isca del Ponte che era andata a spargere il becchime nel cortile si trovò a guardare in alto e vide quella ragazza luminosa come una stella mattutina che ascoltava sorridente il coro delle pettegole e rispondeva per le rime.
Dopo aver sentito tutto il discorso andò dal figlio del re e gli disse: “Al palazzo dell’Orco c’è una giovane che sembra la figlia del sole e dice che un giorno tu la sposerai”.
Il principe rispose: “Non posso crederci. Domani mattina verrò con te e vedremo”.
L’indomani, di buon’ora, si nascose dietro una colonna di granito e seguì il dialogo tra le galline e Margherita alla finestra.
Il principe, rapìto dalle soavi fattezze della fanciulla e dal suono della sua voce, disse alla serva: “Hai ragione, è proprio una rarità. E dove l’avrà trovata l’orco? Come che sia, ho deciso: la prendo per moglie”. Quindi si rivolse a Margherita: “Ehi, madonna, sono io il figlio del re. Guardami”.
La fanciulla si fece rossa e diventò ancor più splendente.
“Come devo fare per conquistarti? E dimmi, ti piaccio? Tu mi vuoi?”, proseguì il figlio del re.
Quella rispose: “Mi piaci e io ti voglio, ma devi sapere che sono la nipote dell’orco”. :p>
“Non preoccuparti per questo. Domenica verrò con mio padre e fisseremo la data del matrimonio”.
Margherita si ritirò in casa e all’ora del pranzo disse al nonno: “Il figlio del re di Isca del Ponte mi ha detto che domenica verrà a chiedermi in sposa. Sei contento tu?”
“Domenica, se a te piacerà, noi fisseremo il matrimonio a dispetto delle galline furiose"
Il giorno convenuto vennero il re, il principe e la regina e insieme combinarono la lista degli invitati per le prossime nozze.
Lo sposalizio fu celebrato nel duomo alla presenza di tutti i regnanti del circondano e tra quelle teste coronate c’erano anche gli ignari genitori di Margherita e il fratello che, unico, l’aveva riconosciuta.
Al momento del brindisi il connestabile propose che ciascuno narrasse una propria storia, a cominciare dalla sposa. E Margherita non si fece ripetere l’invito.
“Io sono la nipote dell’orco”, iniziò a dire “ma un tempo mio padre, mia madre e mio fratello dovettero andare a Monte Sant’Angelo per sciogliere un voto a San Michele e mi affidarono alle cure del confessore del palazzo. Allorché restammo soli, il prete prese a insidiarmi e io per difendermi fui costretta a chiudermi in una stanza e lì restare fino al ritorno dei miei. Quando essi arrivarono e chiesero al confessore come mi ero comportata, questi disse che ero un’anima persa e rappresentavo il disonore del palazzo. I miei genitori si lasciarono ingannare dall’uomo di chiesa e senza neppure interpellarmi ordinarono a mio fratello di uccidermi, ma il principe ebbe pietà del mio destino e preferì tradire un ordine piuttosto che commettere un delitto. Inzuppò il mio vestito nel sangue di una volpe e lo portò come prova dell’esecuzione al palazzo. Dopo aver patito per cinque giorni fame e freddo, camminando per la campagna scoprii la casa dell’orco e questi mi accolse con tale affetto da farmi dimenticare la malvagità di chi mi aveVa dato la vita e aveva desiderato di togliermela”.
La madre e il padre, stravolti a quel racconto, balzarono dalle loro sedie e si gettarono ai piedi della figlia chiedendole perdono.
Il fratello, intanto, era andato a raggiungere il prete e lo costringeva a confessare. In mezzo alla piazza, dinanzi al popolo, quegli ammise: “Tutto vero ciò che dice Margherita. Tutto vero. Sono stato trasportato da un’ignobile passione”.
La folla, per nulla soddisfatta del meaculpa del prete lo spinse contro il muro, appiccò fuoco alla tonaca e lo sciagurato, ardendo come una frasca, entrò in agonia.
Il re e la regina di Isca del Ponte, non appena appresero che Margherita era figlia di regnanti, furono contenti giacché si raddoppiavano le ricchezze del reame e per devozione distribuirono il pane ai poveri. Quindi mostrarono la loro gratitudine a colui che aveva allevato l’onesta fanciulla e per la prima volta da che mondo e mondo fu visto un orco asciugarsi le lacrime di nascosto.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI MONACELLE
Nei pressi della masseria fortificata delle Monacelle presso La Martella di Matera c’era una famiglia che era composta dal padre, dalla madre e dalla figlia. La sventura volle che morisse la madre la quale lasciò nel cassetto del comò l’anello avuto in dono dal marito il giorno delle nozze.
Una mattina, mentre il padre era andato in campagna, la giovane che si era messa a sfaccendare rinvenne per caso l’anello, lo infilò al dito e la sera lo mostrò ingenua al genitore il quale, infuriandosi e schiaffeggiandola, le impose di rimetterlo là dove lo aveva trovato.
La ragazza obbedì. Il giorno seguente il genitore prese di nascosto l’anello, se lo cacciò in tasca e andò in giro per il mondo in cerca della donna al cui dito fosse andato a pennello. Quella e unicamente quella egli avrebbe sposato. Provò e riprovò con donne di ogni razza e colore, ma a nessuna andava bene o perché troppo stretto o perché troppo largo. Solo al dito della figlia si adattava alla perfezione. Allora cominciò a intestardirsi che doveva essere lei la sua sposa, e glielo disse.
La ragazza ne ebbe sdegno e disgusto e, conoscendo di che violenza fosse capace il genitore, cominciò a piangere, a raccomandarsi a Dio e ai Santi perché le venissero in aiuto. Ne ebbe pietà Sant’Anna che si avvicinò a lei e le chiese: “Che cosa ti è successo?”.
La giovane la informò delle orribili intenzioni del padre e la Santa le diede coraggio e promise che l’avrebbe assistita.
Giunto il giorno dello sposalizio, la fanciulla era più morta che viva e continuava a disperarsi, a raccomandarsi a Dio e ai suoi ministri. Ed ecco che mentre stavano inginocchiati all’altare e il prete si apprestava a unirli in matrimonio, comparve leggera Sant’Anna la quale afferrò per i capelli la sua protetta e la portò con sé nella fortezza delle Monacelle.
In quello stesso momento comparve il demonio oltre la balaustra, digrignò i denti e infilzò il padre con le corna trascinandolo all’Inferno per la strada maestra.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI MONTE ACUTO
In una contrada presso Matera, detta Monte Acuto, c’era un Re che dimorava in un castello situato accanto ad un esteso bosco, dove i cacciatori non osavano entrare. Era un bosco incantato e si raccontavano storie terribili. Ma grazie a queste leggende la selvaggina abbondava. Purtroppo tutti quelli che si erano avventura quel bosco, non avevano più fatto ritorno. Per questo, il Re proibì la caccia in quel luogo.
In occasione della visita di un sovrano di un paese vicino, il cuoco del palazzo si recò dal Re, dicendo: “Non abbiamo cibo sufficiente per gli invitati, maestà. Autorizzateci ad andare nel bosco e cacciare uno dei vostri cervi. Starò molto attento”. Il Re, a malincuore, diede il permesso e il cuoco andò... E non vi fu più ritorno di alcuno. Il sovrano inviò un picchetto di soldati in sua ricerca e anche i poveretti non fecero più ritorno, Il bosco pareva un mostro divoratore di uomini. Il Re rafforzò il divieto di caccia nel terribile bosco. :p>
Ma un giorno, giunse a palazzo un vecchio cacciatore.
“Maestà sono il padre di uno dei soldati scomparsi nel bosco. Chiedo i permesso di andare a cercare mio figlio e vedere cos’è successo”. Il Re non riuscì a negarglielo e l’uomo, con i suoi cani, si diresse nella terribile foresta. Gli alberi erano così fitti, che i rami si incrociavano gli un con gli altri. Qualcosa che lo paralizzò dallo spavento: un enorme braccio era uscito dal fango e s’impadronì di uno dei cani, trascinandolo sul fondo. Prudentemente, il cacciatore rientrò a palazzo dove chiese aiuto al Re. “Mi serve una dozzina d’uomini, maestà. Non ci sarà pericolo”. Provvisto di una lunga e acuminata lancia, il vecchio cacciatore tornò n bosco, dove ordinò ai soldati di scandagliare lo stagno. Così fecero e ogni volta che l’enorme braccio usciva dall’acqua, lo feriva con la lunga lancia facendolo scomparire. Qualche ora dopo, un enorme individuo uscì dallo stagno, tenendosi il braccio sollevato. Fu catturato dalla truppa e condotto a palazzo, dove il mostro fu incarcerato nelle segrete. “Non posso ordinare la sua morte”, disse il Re, “perché intuisco in lui qualcosa di magico e straordinario. Forse non è responsabile delle sue azioni e può darsi che sia sotto l’influsso di un maleficio”. A partire da quel giorno, il bosco si trasformò in un paradiso dei cacciatori. E così, trascorsero i mesi finché, una sera, il figlio del Re, un bimbo di dodici anni, molto curioso e vivace, vide la palla, con cui giocava, sparire in un’inferriata al livello del terreno. “Dove si arriva da qui?”, domandò a un soldato. “Nei sotterranei, Principe. Ma non potete scendere laggiù, causa del gigante di ferro. Poco dopo, appena la sentinella si distrasse, il Principino s’insinuò per le scale che conducevano alle segrete. Subito trovò una gabbia nella quale era chiuso prigioniero. “Dammi quella palla!”, ordinò il Principino. “Te la darò se mi apri la porta”. “No, mio padre l’ha proibito e non so nemmeno dove sia la chiave”. “La conserva tua madre nella stanza. Va a prenderla, aprimi e ti ridarò la palla”. Il bimbo non ci pensò due volte. Voleva la sua palla e perciò andò a cercare la chiave e apri la cella del gigante. “Adesso, dammi la mia palla! Ma l’uomo di ferro, senza esitare, afferrò il ragazzo e fuggì portandoselo nel bosco.
Una volta laggiù, si addentrò il più possibile nel folto della macchia, per essere sicuro che nessuno potesse seguirlo.
“Non ti farò del male, perché mi hai liberato, ma non tornerai da tuo padre. Rimarrai sempre con me e nulla di male ti potrà accadere”, disse il gigante, quando furono in salvo. Il piccolo, terribilmente spaventato, non replicò. Il gigante continuò: “Devi sapere che sono il padrone di questo bosco. Posseggo una fonte e uno stagno, le cui acque sono oro liquido. Perciò sono immensamente ricco. Voglio che tu stia molto attento che nulla lo insudici. Il piccolo vigilava meglio che poteva, purtroppo non poté impedire che un ago di pino cadesse nello stagno. Questo scatenò la collera del gigante. “La prossima volta ti scaccerò”. In un’altra occasione, per impedire che una piuma si posasse in acqua, il giovane si chinò tanto che i suoi lunghi capelli si bagnarono nell’oro liquido, diventando dorati. Per non farsi scoprire dal gigante, il ragazzo si coprì il capo con un fazzoletto. Il suo rapitore lo afferrò, gli tolse il fazzoletto e gridò: “Vattene! Non voglio vederti mai più. Poiché ti debbo la libertà, ti concedo un favore. Quando avrai un problema, torna nel bosco e grida: “Rocco”, e io accorrerò in tuo aiuto. Il piccolo, impaurito, fuggì a gambe levate. Attraversò tutto il bosco e giunse all’estremità della foresta che confinava con una città a lui sconosciuta, l’antica Mateola. Dopo qualche tempo, riuscì a prendere servizio come sguattero, in un palazzo. uella sera il Re ordinò che gli fosse servita la cena nei suoi appartamenti e il cuoco inviò il giovane aiutante, non avendo nessun aiuto.
“Quando ti presenti a me, scopriti il capo”, disse il Re. “Perdonate, signore. È perché devo nascondere i miei capelli dorati”. La Principessa, unica figlia del Re, vide per caso i meravigliosi capelli dorati del giovane e per poterli ammirare sempre, ordinò che andasse a accogliere i fiori per lei, tutti i giorni.
E fu così che la Principessa s’innamorò del giovane aiutante di cucina, ignorando che fosse un Principe come lei. Poiché l’amore era reciproco, il giovane dimenticò il suo desiderio di tornare dal padre e volle restare accanto alla Principessa. Qualche tempo dopo, si scatenò una guerra terribile, Il Principe sguattero andò dal generale e domandò un cavallo.
A quei tempi vi era penuria di cavalieri, così la principessa, in gran segreto, ordinò il piccolo cavaliere. Vi fu una grande battaglia, quando il principe, ormai perdente, invocò all’improvviso il nome del mostro: “Rocco. Roccoooo”. Il mostro entrò nella mischia ed impaurì tutto l’esercito nemico, che fuggì per ognidove. Anche il mostro, però, si avvicinò al principe dicendogli: “Ti ho salvato, adesso non hai più bisogno di me”, e scomparve nella foresta.
Il principe, intravide, fra la schiera, il comandante nemico: era il padre. Accorse da lui, fu riconosciuto, e gli concesse una vittoria alla pari. Fu così che il principe e la principessa poterono, di diritto, sposarsi.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI MONTELEONE
Nel casale di Monteleone presso Matera c’era un ragazzo terribilmente svogliato che una mattina disse al padre: “Non voglio più andare a scuola, preferisco fare il calzolaio”. Il padre acconsentì. Dopo poco tempo che aveva cominciato quel mestiere si punse la mano con la subbia e si lamentò col genitore: “Padre mio, non voglio più fare il calzolaio”. “E che vorresti fare?” chiese il bravuomo. “Voglio imparare l’arte del sarto”. “E sia”, rispose quello con mitezza.
Un giorno, mentre il ragazzo cuciva a macchina gli accadde d’infilare il dito sotto l’ago e in seguito a ciò pianse e giurò che non voleva più fare il sarto. “E che intenderesti fare?”, volle sapere il padre. “Il falegname”. “E fai pure l’arte di San Giuseppe” approvò il vecchio.
Nel corso del nuovo mestiere una sera d’inverno, mentre piallava, si ferì a sangue il pollice. Tornato a casa disse al padre: “Non mi giudicare male, ma io non voglio morire per il lavoro”.
E quegli replicò: “Se non lavori non mangi”. E il figlio: “E io non voglio né mangiare né lavorare”. “Vedremo come farai” accondiscese bonario il genitore.
Passò il primo giorno, passò il secondo, il terzo, il quarto e alla fine, sdilinquito dalla fame, il ragazzo si arrese: “Padre mio, voglio mangiare e lavorare”. “Ebbene, prendi la vanga e seguimi in campagna ” rispose il vecchio mettendo nella bisaccia pane, pecorino e olive.
Il ragazzo vangò dall’alba al mezzodì senza soste, poi si rinfrescò all’acqua del pozzo come aveva visto fare al vecchio, sedette accanto a lui all’ombra di un carrubo e addentò la colazione: “Quanto è saporito pane e cacio” rise a bocca piena “dopo la fatica!”.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI MONTESCAGLIOSO
A Montescaglioso quasi nessuno sa dire se prima esisteva un castello, ma fatti storici dimostrano che esso era posto su di una collina che nell’antichità veniva chiamata "Civitas Severiana".
Questa collina era contrapposta ad un’altra collina, detta appunto "Civitas Vetus" o "Mons Scabiosus" dove sorgeva la grande Abbazia di S. Michele.
Infatti l'origine del castello è legato alle vicende della contea normanna di Montescaglioso. La contea, fondata da Roberto figlio del conte Ruggero e di una sconosciuta
rampolla degli Altavilla, appare anche nel 1063 quando Roberto compare tra i sottoscrittori di un altro diploma in favore dell’Abbazia di Venosa e in occasione della restituzione di alcuni beni usurpati all'Abbazia di S. Maria di Banzi. In entrambi i documenti Roberto si firma "de Monte Scabioso", cioè non esisteva ancora il castello vero e proprio.
Ed è in questo senso che si sviluppa l’origine della città di Montescaglioso: una dualità caratterizzata sia dal Monastero di S. Michele, sia da una scomparsa residenza signorile, forse la "Torre Severiana" che Lacava vide abbattere nel secolo scorso.
A Montescaglioso, dunque, convissero due sviluppi distinti della città che rientravano in un disegno politico più generale, almeno sino all'avvento di Rodolfo Maccabeo e di sua moglie Emma, quando attraverso un atto del 1110 si scopre che "Emma comitissa, scilicet, Civitatis Severianae" –vale a dire la parte nuova della città–, conferma alcuni beni posseduti nella città Severiana, "che mio marito –dice– ha costruito insieme a me": è sorta la città di Montescaglioso, ma scomparirà il castello anche perché l’odio verso i feudatari restò sempre forte e, quindi, non appena essi vennero a mancare, non rimase altro che il polo religioso del Monastero di S. Michele.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI NOVA SIRI
Sulla collina retrostante a Taverna, anticamente si trovava una colonia greca chiamata Siris. Siri sorse sul litorale della Lucania orientale tra la foce del fiume Siri (oggi Sinni) e quella dell'Achiris (Agri). A detta di Antioco, citato da Strabone, la colonia fu fondata da esuli Troiani; le sue origini si riflettono nel culto di Athena Iliàs. Fu occupata dai Chones, una gente del versante ionico dell'Italia, nella prima metà del VII secolo a.C.
Dopo i Chones, giunsero nella Siritide gli Ioni esuli di Colofone, che erano sfuggiti all'invasione dei Lidii, intorno al 675 a.C. I conquistatori furono così crudeli nei confronti dell'etnia locale che li perseguitarono fin dentro il tempio di Athena, strappando dalla cella coloro che vi avevano cercato rifugio. Secondo una tradizione, allora, lo xoanon della dea distolse lo sguardo, rinnovando il miracolo che si era verificato quando Aiace Oileo, a Troia aveva violentato Cassandra (Strabone 6, 1, 14).
Questo culto univa Siri a Locri, una città che aveva anch'essa un legame particolare con la dea.
Archiloco, il poeta del VII secolo proveniente da Paro, paragonò l'isola di Taso al dorso di un asino, ponendo a contrasto il suo territorio con la bellezza e l'attrattiva delle terre presso il fiume Siri. La ricchezza della terra portò alla città prosperità e fasto. Ateneo (523 C) riferiva che gli Ioni abitanti a Siri si vestissero con tuniche cinturate. Oltre a trarre vantaggio dalla sua fiorente agricoltura, Siri era impegnata in una vasta rete di relazioni commerciali, che toccava Grumento, per poi penetrare nella penisola italica e raggiungere lo sbocco tirrenico di Pissunte. Siri fu l'unico raggruppamento ionico in un territorio completamente dominato dai dorici Achei. La sua fine fu decretata dall'azione comune di Crotone, Sibari e Metaponto già alla metà del VI secolo, probabilmente per ragioni di tipo economico, per impossessarsi della fertilissima pianura, ambita soprattutto dai Metapontini, e mettere fine alla sua concorrenza commerciale. La città sopravvisse come centro minore sin quando non risorse come Eraclea nel 433 a.C., che fu distrutta dai Saraceni.
Il paese costituì un vero e proprio rifugio ed in un primo tempo prese il nome di Bollita.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI OLIVETO LUCANO
L’insediamento di Oliveto Lucano prende il nome, si sa, dalla diffusa coltivazione dell’ulivo, ma la sua origine come comune è più recente, quando vi si accentrò la popolazione proveniente da Garaguso e Calciano.
Alcuni affermano che il villaggio sorse sulle ceneri di un insediamento che si sviluppò intorno a dimore di briganti, che si rifugiavano dopo le sortite contro i soldati piemontesi. Non tutto è vero, ovviamente, ma qualcosa di vero c’è e si conosce.
La storia parla di un brigante che, al ritorno da una festa nei boschi di Calciano, venne per riposarsi, quando incontrò un lupo. L’animale si avvinghiò sullo sfortunato che questi a malapena riuscì a rifuguarsi nella dimora baronale.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI PANTANO
Molti anni fa, in un bosco presso Policoro detto Pantano, viveva un Principe che era cresciuto sotto la tutela di sua nonna, perchè il Re era troppo occupato dai suoi doveri di sovrano. La nonna desiderava che il nipote crescesse felice e gli raccontava belle favole. “La cosa più bella è questa terra” gli diceva, “Qu i ci sono grandissimi e stupendi paesaggi e fiori. Ognuno di questi fiori possiede la sapienza saggio. Così, mentre in uno puoi trovare tutto ciò che si può sapere, nei laghi, montagne e fiumi trovi tutta la storia del mondo, di i Re e gli eroi... Di tutte le grandi imprese”.
“Chi può arrivare in quei luoghi?” chiedeva il Principe.
“Solo i buoni. Dio fece il paradiso per tutti, però Adamo ed Eva, i suoi abitanti, lo disobbedirono e furono cacciati. Da allora il paradiso è abitato solo dalle anime di chi si è comportato in modo degno e virtuoso”.
Così, con il passare del tempo, il giovane cresceva e imparava il significato delle cose.
G1i anni trascorrevano ma per il Principe il paradiso perduto, che non credeva fossero quelle terre, costituiva una vera illusione.
Una sera, passeggiando per boschi, si allontanò senza accorgersene e si ritrovò, a notte fonda, in un luogo sconosciuto. Nel cielo correvano nuvole minacciose e non tardò a scoppiare una tempesta, come accade spesso in Lucania. Il Principe corse alla ricerca di un riparo e vide una luce brillare dinanzi a sé. Avanzò, correndo, in quella direzione e trovò una grotta nella quale una donna anziana stava cucinando un cervo sopra un fuoco.
“Entra e asciugati”, disse la donna, “mettiti vicino al fuoco, chè qui dentro è molto freddo. Attento al fuoco!”, non fece in tempo a dire così che la vecchietta lo gettò nell’acqua bollente.
“Ah, ah! Ce l’ho fatta e adesso ti mangerò vivo”.
Il piccolo iniziò a dimenarsi, quando all’improvvisò entrò un lupo della foresta nella casa della donna. “Non fare niente al piccolo–disse il lupo– che costui è signore di queste terre e non crede nella possibilità che questo sia un paradiso vero e proprio”.
La vecchia lo lasciò immediatamente scappare e, all’improvviso, al di fuori di quel riparo riapparve la luce. Fu così che, seguendo i sentieri di quella località, il principe ritornò al palazzo e esclamò alla nonna: “Nonna, è vero che anche in un luogo brutto come credevo che questo fosse, ci sono esseri buoni. E’ come essere davvero in Paradiso!”.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI PARCO DEI MONACI
A Parco dei Monaci, grande possedimento fortificato appartenente ai monaci di Montescaglioso, c’era Rocco, un ragazzo così corto di mente che non riusciva a imparare nessun mestiere per cui la povera madre era costretta a tessere e filare giorno e notte, per sé e per lui, vestiti per i monaci.
Una mattina gli consegnò una lunga pezza di tela dicendogli: “Rocco, i monaci non mi pagano quasi mai e quasi moriamo di stenti, perciò vai nei dintorni e cerca di trovare qualche compratore. Bada però di dare la tela a chi parla poco e non a chi si perde in troppe chiacchiere. Hai capito?”.
“Non dubitare” rispose il figlio. “Lascia fare a me che sono un uomo e non mi lascio gabbare dalle donnette”. E cominciò il giro del paese gridando: “Chi vuole la tela? chi la vuole?”.
“Ehi tu” lo chiamò la padrona di una locanda. “Vieni qua e fammi vedere quello che porti. Oggi avrei proprio voglia di fare qualche buon acquisto”.
“Sì, ma quante chiacchiere!” rispose il giovanotto. “Tu parli troppo e mia madre mi ha detto che debbo venderla a chi parla poco”. E tirò via.
“Che bestia!” commentò una comare dopo aver visto tutto. “Quel tizio dev’essere uno scemo e la faccia lo dimostra”.
A mezzogiorno la tela non era stata ancora venduta. Stanco, il giovane ambulante entrò in una chiesa, vide un grande crocifisso di fianco all’altare, gli si avvicinò e disse: “Vuoi tu la mia tela? Non ho potuto venderla questa mattina perché mia madre mi ha raccomandato di darla solo a chi dice poche parole e tutte le persone che ho conosciuto parlavano a più non posso. La vuoi tu che parli poco?... Non rispondi neppure?”.
Sentendo un sibilo prodotto da una fessura della finestra, credette che fosse la risposta affermativa alle sue domande. Sicché aggiunse: “Ho capito. Hai acconsentito”.
E senza attendere ulteriore conferma, avvolse la tela intorno al crocifisso e lo fasciò come un bambino.
Il sacrestano, che era dietro l’altare maggiore, spalancava gli occhi a quella scena comica e si grattava la zucca.
“Be’, quando mi paghi?” continuava l’idiota. “Non mi dai il denaro? Debbo venire domani?”
E il solito vento rispose “sì”.
“Va bene, verrò domani e tu mi pagherai”.
E si mosse soddisfatto di aver concluso l’affare con l’uomo più taciturno del mondo, mentre uno zoppo arrotolava furtivo la tela e la portava in regalo alla moglie.
La madre di Rocco intanto era disperata nel vederlo a mani vuote e rimpiangeva il suo lavoro perduto. Inutilmente corse in chiesa a supplicare il sacrestano che finse di cadere dalle nuvole. “Il crocifisso nudo era e nudo rimane, con licenza parlando.
Tornata a casa, la donna imprecava contro il destino che le aveva dato un figlio così stupido. Ma questi ribatteva: “Domani, se non mi paga, gli farò vedere! L’aggiusterò io per le feste”.
Il giorno dopo si recò in chiesa con un bastone di cerro lungo due metri, si fermò davanti al crocifisso e prese a gridare: “Tu ieri volesti la mia tela e mi dicesti “domani “. Adesso sono venuto a ritirare il denaro”.
E quello zitto, immobile sulla croce. “Ah, non rispondi? Ti burli di me? Ti rimangi la parola? Ti darò io la favella ” e con una bastonata sulla noce del collo mandò in pezzi il crocifisso dal cui busto, piovvero tante di quelle monetine d’argento quante non ne aveva mai immaginate in vita sua.
Davanti a quel bendidio l’idiota si buttò sul pavimento, si riempì le tasche e si mise in allegria sulla strada di casa.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI PICCIANO
Oggi sappiamo che il casale di Picciano ebbe a che fare con le vicende crociate, quando i Cavalieri Templari, sorti per difendere l'accesso ai luoghi santi dai banditi e dalle incursioni e per accompagnare i pellegrini che ripetevano il rito del battesimo di Cristo, si insediarono presso Matera costituendo una magione lungo le via medievale verso Bari.
I Templari avevano fondato a Potenza il tempio di S. Maria del Sepolcro, la mansione di S. Martino dei Poveri, posta lungo le mura di Forenza, la mansione di San Nicola di Melfi, nella media Valle dell’Ofanto, che appartenne alla casa del Tempio di Lavello, la chiesa di S. Maria Mater Domini (anticamente detta dello Spirito Santo), che recentemente è stata messa in luce durante i lavori di ripristino di Piazza V. Emanuele a Matera e, appunto, il complesso di S. Maria di Picciano, a circa 12 km da Matera in direzione di Gravina. Posizionata, quindi, strategicamente rispetto al territorio pugliese, era uno snodo essenziale per il traffico dei pellegrini.
La mansione di Picciano non esiste più, ma una tradizione vuole che fosse appartenuta ai Templari nel 1270; sul fondo alla navata destra, infatti, è murato un bassorilievo raffigurante uno stemma con tre merli del commendatore frate Silvio Zurla.
Si racconta che in una notte di luna piena, ad alcuni pellegrini giunti presso l’Ospizio, era apparso un lupo con i denti rossi di sangue. Esso aveva anche parlato dicendo loro: “Se voi partite da questo luogo senza pentirvi di essere santi, io vi farò morire entro la giornata!”
Lo sgomento venne improvviso, e tutti, anche se stanchi della fatica, corsero in chiesa per chiedere perdono dei peccati commessi. Il monaco-sacerdote, ignaro di tutto, fu svegliato dal baccano e dalle grida di spavento dei numerosi viandanti. “Che è, che succede? Vi ha morso il diavolo?” Mai frase così vera fu detta. Insieme corsero dal santo per chiedergli conforto raccontandogli l’accaduto. “Ah, non vi preoccupate, il diavolo è dappertutto ed è addirittura donna. Si chiama Yolanza e, anni fa, vendette l’anima al diavolo per fuggire finalmente da questo castello e ritornare nella sua patria, Antiochia; l’avevamo catturata lì durante una scaramuccia e portata come schiava addetta alle pulizie. Ma volle accanirsi su tutti i monaci chiedendo loro di soddisfarla e, così, l’abbiamo sgozzata”.
Passò una notte intera e Yolanza non fece sentire neanche il suo ululato, ma il giorno seguente fu trovato cadavere un guardiano della mansione cui era stata tagliata la gola. Tutti si impaurirono a vedere tale scempio e si prepararono a partire. “Non fuggite –implorò il monaco– non fuggite e vi dirò come salvare l’anima per sempre, senza raggiungere Ierusalèm, venite e vi dirò tutto”. Si scoprì che presso quella stazione di pellegrini vi era un luogo magico e oscuro, dove avvenivano da sempre delitti misteriosi. Uno di questi pellegrini, tale Riccardo di Andria, volle vederci chiaro. La notte seguente volle appostarsi di nuovo e vide una cosa veramente strana. Un monaco indossava una testa di lupo con i denti insanguinati. “Aahh, vi ho scoperto finalmente!” –esclamò Riccardo– “Volete impaurire i pellegrini con queste storie fasulle!”
I monaci malefici furono scoperti e cacciati dal tempio di Santa Maria di Picciano, ma qualcuno sostiene che per essi, dediti alla magia con la complicità dei boschi, fu escogitato questo trucco per poterli poi allontanare definitivamente dalla storia, come poi davvero accadde.
(P. Rescio)
IL CASTELLO DI POMARICO
Quasi tutti gli abitanti di Pomarico sanno che i loro antenati non hanno sempre vissuto nel centro attuale, ma a pochi chilometri più a sud, nella località oggi conosciuta come "Castro Cicurio".
Era in questo casale che esisteva il castello nel quale, certamente, doveva risiedere, nel XII sec., Riccardo, proveniente dalla vicina Camarda, presso Bernalda.
Pare che un violento terremoto avesse sconvolto, nell’età sveva, il villaggio fortificato di Castro Cicurio, ma un’altra leggenda narra che fu lo stesso feudatario Riccardo a provocarne la distruzione.
Si racconta, infatti, che Riccardo non fosse proprio bellissimo e tentava sempre di maritarsi con una donna nobile, ma comunque almeno consenziente, ma egli non ne trovava affatto ed era per questo sempre triste.
Accadde un giorno che Riccardo si fosse invaghito di una nobile dama della sua piccola corte, ma questa non riusciva nemmeno a guardarlo per quanto era brutto. Egli, allora, escogitò uno stratagemma: indossò una specie di maschera di terracotta forgiata dagli artigiani della vicina Grottole per sembrare più bello. La nobile signora s’invaghì dello sconosciuto e chiedeva sempre di lui durante le feste.
"Ma questo forestiero" –le aveva confessato– "mi ha detto che è di Pomarico, una terra che non conosco".
Il nobile Riccardo comprese che la dama si era innamorata di lui e fece in questo modo: raccolse tutta la popolazione dicendo che lì vicino era sorto un altro feudo e che egli avrebbe concesso elargizioni se il popolo avesse abitato quella nuova terra.
Fu così che la dama ed il nobile uomo si sposarono fondando la città di Pomarico: Riccardo era morto per sempre e la dama sposò quel signore che, da allora, indossò per sempre la maschera di Grottole.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI RECOLETA
La Masseria di Recoleta, situata nella contrada Recoleta a 12 km. dal Comune di Montalbano Jonico, è una stupenda masseria del XVII e XVIII secolo costruita, pare, su di un antico villaggio medievale fortificato.
Alcune fonti riportano che sul sito di Recoleta vivessero dei monaci che, nel 1123, furono prima sotto la dipendenza del vescovo di Tricarico, poi, nel 1126 alla Trinità di Venosa.
Non sappiamo, però, da dove deriva il toponimo di Recoleta, e qui abbiamo la nostra storia.
Inizialmente l’edificio attualmente visibile era costituito da un pianterreno e dall’abitazione baronale, sede forse di una torre di avvistamento, che fu poi inglobata in varie strutture, acquistate in ultimo dalla Famiglia Federici, che si dice avesse piantato per la prima volta in Basilicata una pianta, la rucola, per sciogliere un voto fatto alla Vergine Maria.
Un giorno, Francesco, capostipite dei Federici, ebbe un figlio che si dalla nascita si rivelò malato di un morbo allora sconosciuto. Il padrone chiese a tutti i suoi contadini come poteva fare per far riprendere il bambino, ma i dottori lo davano già per spacciato.
Il bambino, giorno, per giorno, peggiorava sempre di più, quando un contadino dei suoi, un magiaro, gli disse che una strana erba, dal sapore forte e nello stesso tempo saporito, doveva guarirlo completamente.
Francesco ordinò ai suoi fattori di raccogliere ogni tipo di erba per il figlio che, giorno per giorno, ne assaggiava un po’, ma non riprendendosi affatto. Giorno e notte, a turno, i contadini e la mamma del povero rampollo erano accanto, ma nulla.
Era costume, in quell’epoca di povertà, che i fattori portassero con sé una bisaccia di acqua ed un pezzo di pane con un tocco di formaggio.
Quel giorno il formaggio era ripieno di rucola. Il contadino, che sino ad allora aveva assistito il bimbo, appoggiò per un attimo sul comodino di legno, quel pane, che al bimbo apparve così succulento che ne dette un morso.
Il giorno dopo, per le campagne di Mastro Francesco Federici, si sentivano urla di ogni tipo: il contadino veniva cercato per tutte le campagne. Il poveretto, spaventato, si presentò al padrone tutto mortificato e gli disse che era pronto a pagare per la morte del figlio. “Noo, il caro figlio mio è vivo e tu l’hai guarito per sempre”.
Fu allora che i campi dei Federici furono coltivati a rucola e, nel 1744, il figlio di Francesco costruì la chiesa dedicata alla Vergine Maria, e il contadino fu per sempre accolto nella famiglia Federici, diventando anch’egli padrone di quelle terre.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI ROTONDELLA
Molti ritengono che il villaggio di Rotondella sia sorto sulle ceneri di tre casali: Santa Laura, posto sulla costa ionica e non distante dall’attuale Rotondella, tassato nel 1669 per 19 fuochi; il vicino casale di Santa Lucia, posto sulle rovine di Trisaia, e la stessa Trisaia o Tre Santi, antico centro che nell'età sveva era tenuta a riparare il castello di Policoro.
Si racconta che il casale di Santa Lucia fosse rimasto distrutto dal terremoto del 1669, e i suoi abitanti preferirono trasferirsi nella vicina Rotondella. Fallito il tentativo di ricostruirlo casale sia pure sotto altra denominazione, il luogo rimase presto deserto.
Il tentativo fu fatto per iniziativa del barone di Santa Laura, anch’esso distrutto dal terremoto. Stessa cosa avvenne con Trisaia, che nel 1504, disabitato, fu concesso ad Antonio de Guevara conte di Potenza.
Prima che questi casali, cioè Trisaia, Santa Laura e Santa Lucia, fossero del tutto abbandonati, le terre appartenenti erano ritenute fertilissime, tanto che i Greci avevano colonizzato per primi quelle aree. Alcuni raccontano che qui vigeva una strano governo, quasi di tipo democratico, nel senso che non vi era un barone od un conte, ma gli ecclesiastici facevano da padroni sui contadini, i cui figli, per “vocazione”, potevano diventare anch’essi dei sacerdoti. In sostanza, vi era un governo quasi “ecclesiastico”.
Uno di questi monaci, nato povero, ma in quel periodo padrone di quelle terre, volle organizzare un periodo di feste in onore delle sante Laura e Lucia, per fare in modo di rendere anche gioiosa la vita dei popolani. Decise di chiamare alcuni saltimbanchi che erano di passaggio e li pagò abbastanza con cibo ed ospitalità, per trattenerli almeno tre giorni. Il popolo era davvero in festa, e gli altri religiosi concordavano che il loro abate meritava davvero di essere amato da tutti.
Durante la festa venne fuori una specie di zingara che volle predire il futuro degli astanti. Dopo alcune persone, la scelta si indirizzò verso il monaco ma, all’improvviso, la zingara fuggì gridando come una forsennata. Nessuno riuscì a spiegarsi quel comportamento e, dopo qualche attimo di smarrimento, la festa continuò senza problemi. Il monaco, che aveva raggiunto la zingara sino all’esterno del villaggio, chiese il perché di quel comportamento. Ella gli svelò di averlo riconosciuto come figlio poiché somigliava al padre, che morto nel casale di Santa Laura per peste, aveva donato il figlio ad una famiglia di contadini perché lo allevassero con amore.
Si racconta che, da allora di poi, tutti i figli degli zingari, degli stranieri e dei profughi, dovessero sempre essere accolti con gioia nei tre casali che portarono alla formazione del villaggio di Rotondella.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI SAN BASILIO
Nella masseria seicentesca di San Basilio la moglie del proprietario aveva una figlia così seducente che perfino il folletto perdette la testa. Tutte le notti il povero ronzava intorno alla ragazza la quale non potendone più di sentirsi sfiorare ora qua ora là, confidò alla madre: “Madre mia, ogni notte un folletto mi viene a lisciare e io ho paura che faccia il peggio”. Rispose quella: “Eh, figlia mia! Spetta a te saperlo prendere. Sai che potresti fare? Se questa notte torna a trovarti, domandagli in regalo due coperchi. Dicono che quando chiedi ai folletti i coperchi ti porta quattrini e quando gli domandi quattrini ti porta coperchi, poiché è dispettoso”.
Venuta infatti la notte il folletto si ripresentò e si mise a vezzeggiarla e quella gli disse: “Corrisponderò al tuo bene quando mi porterai due coperchi”.
“Santi numi dei folletti!, tutto qui? Quanti ne vuoi te ne porterò”, rispose il corteggiatore. E si mise a portarle soldi e soldi. E porta una volta e porta un'altra, la ragazza diventò ricca, tanto da poter ingrandire la piccola masseria e da farla diventare come è oggi.
Una notte lui le domandò: “Mi vuoi un poco di bene?”
“Si che te ne voglio” rispose la ragazza.
“E dimmi come ti chiami”.
“Mi chiamo Mestesso”.
“Che nome strano ti hanno dato! Ma non importa. Sei il mio splendore e tanto basta, cara Mestesso”.
Un giorno, stanca di quell'importuno, la ragazza disse alla madre: “Mamma, come faccio a levarmelo di torno?”. “Prova a domandargli cosa gli piace mangiare”, disse la donna. Venne la notte e la ragazza disse al folletto: “Visto che mi hai fatto tanti regali, fammi sapere cosa ti piace mangiare e te lo preparerò con le mie mani”. “A me piacciono molto le frittelle e me ne farei volentieri una scorpacciata”. “Oh povero amore, e non potevi dirmelo prima?”. Prese la farina e, seguendo ciò che le aveva detto la madre, la lavorò con latte e miele e ne fece delle frittelle. Versò l'olio nel caldaio e lo mise sul fuoco; appena fu bollente si mise a friggere.
Il folletto, che con i suoi salti aveva rovesciato una pignatta, si era seduto lì accanto a lei per non perderla d'occhio. Non appena lo vide ben rimpinzato la furba fanciulla gli disse: “Fammi un favore, amore mio, guarda nel caldaio se l'olio si è ritirato e se dobbiamo metterci dell'altro”.
Il folletto innamorato si chinò servizievole a controllare, ma poiché il fumo lo accecava, alla ragazza venne facile afferrarlo per il didietro e spingerlo nel caldaio.
“Aiuto, aiuto, che brucio!” si mise a strillare.
Immediatamente si udirono tante voci di folletti radunati nella cappa del camino che chiedevano: “chi è stato? chi è stato?”
“Mestesso” piangeva il folletto. “Aiuto, ché son fritto!”
“Chi hai detto che è stato?” insistettero i compagni, “Mestesso” cacciò in un ultimo grido. “E crepa!” sghignazzarono i compagni “visto che sei tu stesso la causa della tua rovina!” E se ne andarono altrove a fare scherzi di notte.
La fanciulla si liberò del tutto del folletto, ma c'è chi giura che, nel visitare la bella e maestosa masseria fortificata di San Basilio, il folletto si aggiri ancora per trovare la sua amata.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI SAN FRANCESCO
Nei pressi del castello-masseria di San Francesco viveva un padre che aveva due figli: Giacomo e Giovanni; l’uno era buono di cuore e bello di viso, l’altro maligno e sfaticato.
Il padre si raccomandava sempre che si amassero e si aiutassero a vicenda ma Giovanni troppo invidiava il fratello buono per corrispondere al desiderio del genitore. Quando questi morì, il figliolo onesto si mise a lavorare senza tregua e nel giro di due tre anni racimolò una discreta fortuna; l’altro, invece, che trascorreva il tempo tra la piazza e l’osteria, si ridusse ben presto in miseria e cominciò a chiedere soldi a questo e a quello e soprattutto a Giacomo.
Una sera andò in casa di costui in campagna e poiché il fratello maggiore tentennava e non si fidava delle promesse di restituzione, Giovanni, accecato dall’ira, afferrò la paletta del braciere e lo uccise.
Quando il giorno dopo i guardiani della masseria scoprirono il cadavere, rimasero inorriditi dalla ferocia con cui era stato massacrato il loro padrone; corsero in paese a denunciare il misfatto e poi provvidero pietosamente a sistemare nella cassa il povero Giacomo e a portarlo al cimitero.
Per identificare l’assassino furono interrogati mezzadri e massari di Matera, Montescaglioso e Miglionico, ma nessuno seppe dare un indizio.
Una notte, mentre alcuni contadini scendevano per un tratturo che costeggiava il luogo dov’era stato commesso l’omicidio, avvertirono un curioso rumore e intravidero un essere senza forma che si agitava sull’aia. Là per là restarono senza fiato, credendo che si trattasse di un demonio; poi si fecero coraggio e andarono a vedere chi fosse. Non appena gli furono a tiro scoprirono un grifone che con voce lamentosa diceva:
“Per l’amore dell’uccello grifone
mio fratello è stato il traditore”.
Non appena udirono queste parole, si fecero il segno di croce per la paura e a gambe levate scapparono dall’aia.
Ma anche a mezzo miglio di distanza sentirono ripetere quel lamento e allora capirono che il grifone era l’anima del giovane ucciso che chiedeva vendetta. Si guardarono l’un l’altro incerti sul da fare e infine tutti d’accordo decisero che era meglio tornare in paese, bussare alla porta del giudice e raccontargli i fatti.
I gendarmi arrestarono l’omicida che dapprima cercò di negare e poi, messo alle strette, confessò la colpa, meritandosi il carcere a vita.
Si illudeva, il Caino, di poter sfuggire alla pena solo perché nessuno era stato testimone della sua malazione; ma Dio che è onnipotente e non per nulla vede e provvede, fece un cenno di lassù all’uccello grifone e mise in opera l’umana giustizia.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI SAN MARTINO
Vicino al centro urbano di Stigliano insiste una masseria fortificata, seicentesca, denominata Grancìa di San Martino. Qui, una volta, un padre di famiglia, rimasto vedovo, si era incapricciato della figlia e voleva sposarla perché somigliava in tutto e per tutto alla madre.
La ragazza respinse la vergognosa proposta ma non riuscendo a resistere alle insistenze del genitore invocò la Madonna la quale suggerì di dire al padre che avrebbe acconsentito alle nozze a patto che egli le avesse regalato due abiti: uno tempestato di gemme e di brillanti e l’altro bello come la luna e il sole.
La giovane si comportò come le aveva consigliato la Vergine e lo sciagurato padre si mise a girare per il mondo in cerca delle due vesti. Cammina e cammina, dopo aver fatto il giro del continente chiamò il diavolo e in cambio del suo aiuto gli promise l’anima.
Tornato a casa, mostrò gli abiti alla figlia e le ingiunse di prepararsi alle nozze che si sarebbero celebrate il giorno dopo. Disperata, la ragazza pregò ancora la Madonna di soccorrerla, e la Vergine le disse di non preoccuparsi e di mettere in un catino d’acqua un pappagallo che sapesse pronunziare “Mò vengo”, giacché così avrebbe dovuto rispondere quando il padre avesse esortato la figlia ad andare a letto.
La piccola eseguì l’ordine della Madonna e la sera delle nozze, quando il padre s’era già coricato e la sollecitava a raggiungerlo, ella oppose che doveva ancora finire di lavare i piatti. Mise il pappagallo nel catino e se ne fuggì. Allorché l’uomo ripeté l’invito il pappagallo, sbattendo le ali nel catino, disse: “Mò vengo”. L’infame, a quel rumore, credette che la figlia stesse realmente sfaccendando e si dispose ad aspettare.
Intanto la piccola, accompagnata dalla Madonna che si era trasformata in una vecchierella, era arrivata a Matera. Bussò al portone del castello del principe, nel vederla così tapina non volle riceverla e permise appena che alloggiasse nel pollaio.
Un giorno il principe, che era sceso a prendere le uova nel cortile, restò colpito dalla bellezza della fanciulla, ma essendo troppo povera non poteva né amarla né sposarla. Se ne distolse a malincuore, però se ne distolse.
Qualche sera dopo si dava a corte una gran festa da ballo alla quale partecipavano tutti i signori del circondario. La Madonna provvide a vestire la sua protetta con un abito colore del cielo e trapunto di stelle, le diede un sacchetto di cenere e l’accompagnò fino all’ingresso del palazzo. Nel vederla, tutta la corte di dame e cavalieri rimase abbagliata e il principe, che non sapeva spiegarsi chi fosse mai quella fata, ne fu così fulmineamente invaghito che quando scomparve dal salone la fece seguire dai suoi servi.
La ragazza, però, una volta che li ebbe a tiro si girò di scatto, buttò sulla loro faccia un pugno di cenere e si rese invisibile. Intanto il principe, che non poteva prendere sonno per l’emozione e continuava ad arrovellarsi sul chi e sul come, fu d’un tratto folgorato dalla somiglianza della bellissima fata con la fanciulla che aveva adocchiato nel pollaio. Allora si precipitò nel cortile per verificare, e potete giurarci che ne ebbe la conferma.
La prese per mano e la condusse dai suoi genitori. Essi, ora che l’avevano ammirata nell’abito color del cielo trapunto di stelle, la considerarono degna del manto regale e benedissero le nozze.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI SAN SALVATORE
Il castello di San salvatore, in agro di Bernalda, trova le sue origini antichissime nel vicino tempio di Hera dell’antica Metaponto.
Viveva in questo piccolo castello un contadino che era solito regolare il passaggio su un ponte che permetteva di guadare il fiume Bradanosi. Mangiava solo pane e cipolle e qualche volta, nelle feste, qualche avanzo di polenta che qualche passante gli portava da terre lontane. Un giorno, mentre sorvegliava il ponte, che oggi non c’è più, vide dinanzi a sé una donna di straordinaria bellezza, ornata d’oro e di diamanti. Meravigliato, le domandò:
“Chi sei tu, o bella Regina, che vieni a trovare me, povero diavolo?”.
Quella rispose: “Io sono la Ricchezza, vivo come voglio, nessuno pone limiti ai miei desideri e tra i nemici temo solo la Morte. Siccome ho deciso di farti vivere felice, ti dono una parte dei miei tesori. Quando fa notte, vai nel fondo soprannominato Pizzica e lì troverai un pozzo. Attingi acqua e vedrai che più volte il secchio calerai più volte oro prenderai”.
Detto ciò scomparve.
Il contadino, appena si fu ripreso dall’emozione, e poiché s’era fatta già notte, decise di recarsi sul posto indicato e di provare. Calato il secchio, lo ritirò su che traboccava di oro fino. Contento come una pasqua se ne tornò alla sua capanna. Il giorno successivo comprò cavalli e carrozze, ed ingrandì il bel castello e si circondò di servitù.
Tutte le notti continuò a calare secchi nel pozzo, divenendo in breve tempo l’uomo più ricco della contrada, tanto che il re di Bernalda al suo confronto sembrava un poveraccio. Ma la Morte che per un certo tempo aveva lasciato campo libero alla sua rivale, volle prendersi la rivincita. Entrata di straforo nel palazzo del contadino arricchito, convinse il suo servo più fidato a intrufolarsi nella stanza in cui era custodita la cassaforte. Il servo eseguì quanto gli era stato richiesto e vedendo il padrone in poltrona dinanzi a mucchi di zecchini e canini, avido di possederne almeno una parte, estrasse un coltello e lo uccise. Poi, riempitesi le tasche e il cappello di monete, fuggì.
La Morte, che aveva seguito la scena nascosta dietro la cassaforte, si avvicinò al contadino disteso sul pavimento occhi sbarrati e sogghignando commentò: “Meglio per te sarebbe stato se fossi rimasto contadino! Non ti avrei preso prima del tempo. Ti lasciasti lusingare dalla Ricchezza e ora eccoti qua freddo”.
Da allora è nato il proverbio:
R’ picc’ abbàst’, r’assai uàst’.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI SANTA CANDIDA
Nella stupenda masseria secentesca di Santa Candida, antico villaggio preistorico e medievale di Matera, abitava Rocco, un ragazzo così corto di mente che non riusciva a imparare nessun mestiere per cui la povera madre era costretta a tessere e filare giorno e notte per sé e per lui.
Una mattina gli consegnò una lunga pezza di tela dicendogli: “Rocco, vai nei dintorni e reggiungi al massimo Matera o Gravina di Puglia, e cerca di trovare qualche compratore. Bada però di dare la tela a chi parla poco e non a chi si perde in troppe chiacchiere. Hai capito?”.
“Non dubitare. Lascia fare a me che sono un uomo e non mi lascio gabbare dalle donnette”. E cominciò il giro del paese gridando: “Chi vuole la tela? chi la vuole?”.
“Ehi tu” lo chiamò la padrona di una locanda. “Vieni qua e fammi vedere quello che porti. Oggi avrei proprio voglia di fare qualche buon acquisto”.
“Sì, ma quante chiacchiere!” rispose il giovanotto. Tu parli troppo e mia madre mi ha detto che debbo venderla a chi parla poco” E tirò via.
“Che bestia! ” commentò una comare sulla cantonata. “ Quel tizio dev’essere rincretinito e la faccia lo dimostra”. A mezzogiorno la tela non era stata ancora venduta. Stanco, il giovane ambulante entrò in una chiesa, vide un grande crocifisso di fianco all’altare, gli si avvicinò e disse: “Vuoi tu la mia tela? Non ho potuto venderla questa mattina perché mia madre mi ha raccomandato di darla solo a chi dice poche parole e tutte le persone che ho conosciuto parlavano a più non posso. La vuoi tu che parli poco?... Non rispondi neppure?”.
Sentendo un sibilo prodotto da una fessura della finestra, credette che fosse la risposta affermativa alle sue domande. Sicché aggiunse: “Ho inteso. Hai acconsentito”. E senza attendere ulteriore conferma, avvolse la tela intorno al crocifisso e lo fasciò come un bambino.
“Beh, quando mi paghi? Non mi dai il denaro? Debbo venire domani?”
E il solito vento rispose “sì”. “Va bene, verrò domani e tu mi pagherai”.
E si mosse soddisfatto di aver concluso l’affare con l’uomo più taciturno del mondo, mentre lo zoppo arrotolava furtivo la tela e la portava in regalo alla moglie. La madre di Rocco intanto era disperata nel vederlo a mani vuote e rimpiangeva il suo lavoro perduto. Inutilmente corse in chiesa a supplicare il sacrestano che finse di cadere dalle nuvole. “Il crocifisso” disse “nudo era e nudo rimane, con licenza pàrlando”.
Tornata a casa, la donna imprecava contro il destino che le aveva dato un figlio così stupido. Ma questi ribatteva: “Domani, se non mi paga, gli farò vedere! L’aggiusterò io per le feste”.
Il giorno dopo si recò in chiesa con un bastone di cerro lungo due metri, si fermò davanti al crocifisso e prese a gridare: “Tu ieri volesti la mia tela e mi dicesti “domani “. Adesso sono venuto a ritirare il denaro”.
E quello zitto, immobile sulla croce. “Ah, non rispondi? Ti burli di me? Ti rimangi la parola? Ti darò io la favella”. Con una bastonata sulla noce del collo mandò in pezzi il crocifisso dal cui busto piovvero tante di quelle monetine d’argento quante non ne aveva mai immaginate in vita sua.
Davanti a quel bendidio l’idiota si buttò sul pavimento, si riempì le tasche e si mise in allegria sulla strada di casa.
Da quel momento sorse di nuove vita il villaggio di Santa Candida, sino ai giorni nostri.
(P. Rescio)
IL CASTELLO DI SANTA MARIA DEL VETRANO
Nella fortezza di Santa Maria del Vetrano, posta in contrada Campagnola in agro di Montescaglioso, si trova una torre normanna appartenuta ai benedettini di Sant’Angelo. Essa, un tempo, si chiamava castello di Passavanti, per poi chiamarsi Santa maria del Veterano o del Vetrano per la presenza di un vecchio castello.
La castellana non riusciva ad avere figli. Tutto il giorno si disperava e pregava Gesù Cristo perché le desse il frutto tanto desiderato. Ma il Signore rimaneva insensibile alle preghiere della poveretta.
Allora quella, vedendo che Cristo non l'ascoltava, si votò per disperazione al diavolo scongiurandolo che le desse un figlio e aggiungendo che non importava se poi lo avesse perduto all'età di diciotto anni.
Quale compenso, metteva a disposizione la sua anima. Il diavolo accettò e promise che al nono mese avrebbe partorito un bel bambino. E così avvenne.
Non si può credere quanto la madre lo adorasse, ma al pensiero che a diciotto anni egli doveva morire non si dava pace. Il ragazzo cresceva sano e sereno, ignaro del crudele destino che lo attendeva.
Quando compì il sedicesimo anno la poveretta era ormai stravolta dalla pena e tutto il giorno non faceva che piangere e piangere.
Qualche volta il figlio cercava di farsi dire perché fosse così afflitta, ma la donna non aveva il coraggio di confessarglielo. Tuttavia, all'avvicinarsi della data stabilita, e mancavano soltanto sette giorni, gli rivelò per filo e per segno ogni cosa. Il giovinetto impallidì, si sentì perduto, ma ciononostante ebbe forza di consolare la madre.
Alla fine decise di trascorrere fuori di. casa quei sette giorni e, ricevuta la benedizione materna, se ne partì.
Cammina e cammina, giunse al convento dei benedettini di Montescaglioso e qui trovò ricetto per la notte. Il mattino seguente confidò la sua sventura al padre guardiano pregandolo di suggerirgli un mezzo per sottrarsi al disegno del demonio.
Il padre guardiano gli disse: “Figlio mio, raccomandati a San Benedetto. Noi non possiamo fare altro che celebrare una messa l'ultimo giorno. E quando arriva l'ora che il diavolo dovrà scendere per prenderti, faremo in modo di trovarci all'elevazione, perché allora le porte dell'inferno si chiudono e il diavolo non può sortire”.
Così fecero.
Arrivò il giorno, e quando i monaci stavano con l'ostia alzata, il cielo della chiesa si spalancò, due grosse catene calarono dal soffitto proprio sul corpo del giovinetto il quale gridava e si contorceva e faceva ogni sforzo per divincolarsi; ma le catene cigolavano e lo tiravano su come un pesce all'amo con la canna. Ed ecco il miracolo. Proprio nell'istante in cui il giovane stava per sprofondare nell'inferno, San Benedetto si parte dalla sua nuvola, lo afferra, stacca le catene e lo libera dalla morte.
Il giovinetto s'inginocchiò dinanzi al Santo, gli baciò il lembo della tonaca e gli promise di farsi monaco.
La lieta notizia giunse la sera stessa all'orecchio della madre, e lascio pensare a voi quanto la poveretta se ne riempisse il cuore. Egli intanto mantenne la promessa, si fece monaco e a trentatré anni, giusto come gli anni di Cristo, diventò padre priore del monastero.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI SANTO SPIRITO
Nella masseria fortificata di Santo Spirito, nei pressi di Stigliano, c’era una donna che mentre era incinta fu colta improvvisamente dalla voglia di un vaso di fiori. Venne il momento del parto e mise al mondo una magnifica pianta di rose.
La poveretta molto soffrì di questo evento, ma non potendovi rimediare in alcun modo, circondò di cure la sua creatura né più né meno che se fosse stata una bambina. Ed ecco che un giovane facoltoso che abitava in quei pressi prese di mira il bel vaso e chiese alla donna di venderglielo. La donna, afflitta dalle ristrettezze in cui viveva, fu costretta a cederglielo, e anche a buon mercato. Ma fece male, come potrete giudicare, perché la rosa si apriva sempre più e nascondeva una vaghissima fanciulla.
Una mattina, mentre il giovane innaffiava la pianta, comparve tra i petali il suo viso: due occhioni neri, una bocca piccolina, una chioma fittissima.
Il giovane, stupefatto, le domandò chi fosse, ed ella rispose: “Sono la donna di fiore e sarò tua purché non mi tocchi fino al momento in cui non te lo dirò io”.
Intanto la madre del giovane stava pensando a una sposa degna del figliuolo e molte gliene proponeva, ma quegli via via le rifiutava ora dicendo che non si sentiva pronto per il matrimonio, ora che la ragazza non gli piaceva, ora che avrebbe fatto da sé la sua scelta. Sen-nonché la madre, più ostinata di un tarlo, tanto disse e tanto insistette che al giovane fu giocoforza acconsentire a una delle proposte più vantaggiose.
Durante il fidanzamento, per un motivo che non sappiamo, il giovane dovette allontanarsi da casa per alcuni giorni e lasciò alla madre l’incarico di curare la pianta, imponendole inoltre di non far entrare chicchessia nella sua stanza e di non suonare il campanello che era accanto al vaso.
Una sera, però, venne in visita la promessa sposa e pregò con insistenza la futura suocera di farle vedere la stanza del fidanzato; e quella, pur ricordando le avvertenze del figliuolo, le permise di entrare raccomandandole tuttavia di non toccare il campanello accanto al vaso. Parole al vento! Appena si trovò sola, la ragazza, vinta dalla curiosità, si diede a scampanellare. Comparve la donna di fiore e questa, accorgendosi che c’era un’estranea nella stanza, si affrettò a rinserrarsi tra i petali.
La promessa sposa, sconvolta per quella apparizione, afferrò il vaso e lo lanciò dalla finestra, e a malapena poi si poterono ricomporre i cocci in modo da sorreggere la rosa che si era miseramente sciupata.
Quando il giovane fu di ritorno, entrò di corsa nella sua stanza e suonò tre volte il campanello, ma solo dopo molto tempo la donna di fiore apparve dolorante e contusa; gli raccontò la sua storia, lo rimproverò di averla lasciata sola e aggiunse che non sarebbe mai più comparsa se egli non avesse rotto il fidanzamento con la rivale.
A queste parole il giovane cercò di placarla, promise di liberarsi di colei che non amava e andò a protestare con la madre per il suo comportamento, precisando che egli aveva già la sua sposa e non desiderava sentir parlare di altre donne: e si affrettasse piuttosto ad accelerare i preparativi delle nozze.
Giunse finalmente quel giorno. Tutto era predisposto e gli invitati che affollavano la casa si domandavano con curiosità chi fosse mai la prescelta.
Quand’ecco nel momento in cui si doveva andare in chiesa si apre la porta di una stanza e compare in un fascio di luce, tra la meraviglia dei presenti, la donna di fiore. In mezzo agli ospiti che la festeggiavano e si complimentavano c’era anche la madre della famosa voglia che, non si immaginava potesse diventare realtà. Dopo che la fanciulla fu riconosciuta naturalmente dalla madre, elle stessa si avvicinò a suo marito dopo la cerimonia e disse: “Ora sono tua”.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI SCANZANO
Scanzano, oggi comune autonomo, era un piccolo ed antico casale sulla costa jonica i cui abitanti dovevano, nell'età sveva, provvedere alla riparazione del castello di Policoro.
Esso, poi, fu abbandonato come centro abitato nell'età aragonese e ripopolato successivamente.
Le memorie di questo insediamento non sono molto conosciute.
In effetti l’attuale borgo è abbastanza moderno ed è famoso per la sua bella costa, ma nel centro cittadino è presente un grande palazzo baronale, che gli abitanti chiamano "Palazzaccio" o "Castello di Scanzano".
Ci si chiede il perché di questo nome, e qualcuno racconta che ivi erano presenti degli affreschi che rappresentavano il barone del castello che tagliava le sue vittime su un tavolo e dipingeva con il loro sangue sulle pareti del suo palazzo. Ecco perché alcune sale, un tempo, erano tinteggiate di rosso.
Un giorno, nelle mani del signore, giunse inaspettatamente uno straniero che chiese, appunto, ospitalità nella dimora. Il signore già calcolava, dalla corporatura, la possibile stanza da "abbellire" con nuovo e fresco sangue, ma fece male i suoi calcoli. Mentre dormiva, il viandante si rivelò un parente di una delle vittime che, in un sol colpo, sgozzò il poveretto senza che egli fiatasse.
Qualcuno dice che, scrostando le pareti del "Palazzaccio" si intravedono tracce di intonaco rosso.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI SELVA SAN LIOGI
Una giovane donna di venticinque anni di nome Filomena aveva una terra presso la torre di Selva San Liogi; ella aveva i capelli neri e l’incarnato chiaro come la neve; il marito, strano a dirsi, era un marinaio e navigava in lontani paesi; perciò Filomena fu tentata da un giovane signore, gli cedette e divenne infedele.
Presto, tuttavia, subentrò il pentimento e appena tornato il suo uomo gli si gettò alle ginocchia confessando la colpa e domandandogli perdono.
Il marinaio, benché l’amasse grandemente, non corrispose alle sue implorazioni e decise di punirla. “Preparati a morire” le disse.
La donna, atterrita, di nuovo supplicò strappandosi i lunghi capelli che sembravano di seta; ma vana fu ogni promessa per il futuro e vani i ricordi del passato.
Lo stesso giorno il marinaio la caricò a bordo della barca, sciolse le vele e appena fu distante dieci leghe dalla costa, l’afferrò per la vita e la gettò fra le onde. “Ora sono vendicato!” si disse, e mestamente tornò in porto ben immaginando il destino di quel corpo alla mercè dei pescecani.
Le sirene invece ebbero pietà della bella annegata, l’accolsero tra le loro braccia e la condussero nei loro palazzi incantati dove una schiera di donne splendenti l’attendeva per farle festa: e chi le pettinava le chiome, chi le profumava le mani e il seno, chi le poneva al collo di cigno una collana di rossi coralli; infine la Regina le impose questo nome: Spuma.
Sennonché, pur confusa da tante premure e conquistata da quelle magnificenze, Filomena non riusciva a dimenticare le traversìe terrene, il rimorso per il tradimento inflitto al marito riprendeva a torturarle l’anima, gli occhi di conseguenza si velavano di malinconia e il sorriso si spegneva sulle labbra.
Per sollevarla da questa tristezza e darle un segno del loro affetto le sirene la iniziarono all’arte del canto malizioso con cui da secoli attiravano gli ingenui marinai. FilomenaSpuma prese dunque posto nel cerchio delle compagne canterine, ma non sempre aveva voglia di emergere con loro; più spesso si appartava, o vagava di qua e di là solitaria nel regno delle acque azzurre.
Una notte che il cielo e il mare erano illuminati dalla luna piena, ella scorse da lontano un vascello con le vele gonfie al vento di maestro, e mentre questo si avvicinava le sirene la trascinarono in superficie: “Vieni, vieni con noi a cantare”; e circondarono la nave con note così soavi che d’improvviso si vide un uomo salire sul parapetto e slanciarsi nelle onde. Filomena con una stretta al cuore lo riconobbe: quel marinaio era suo marito.
Allora pregò le compagne che non lo uccidessero, né lo trasformassero in corallo o in bianco cristallo, che lo lasciassero vivo almeno per un giorno.
Le sirene, impietosite dalle sue parole, accordarono ventiquattro ore al prigioniero ed ella, che era rimasta sola nella reggia sottomarina, si avvicinò alla cella dove era stato rinchiuso il marito e cominciò a cantare:
“Io ti conobbi in vita e a te fui ingrata tu mi amasti
traendomi dal mio nido per condurmi
al dolce talamo e io ti tradii.
Oh quanto piansi per il mio tradimento! Quanto piansi!
E piango ancora, amato mio.
Non riconosci le mie lacrime?”
Intese il prigioniero quella canzone e ne rimase stupefatto: poteva mai essere Filomena a cantare con quella voce sorgiva, la donna che egli aveva ucciso e gli si rivolgeva con tanto tremore?
La canzone proseguiva:
“Per salvare te io rischierò le catene
le sirene forse non mi perdoneranno di ridare la libertà
a chi era destinato a morire”.
Poi si fece ancor più da presso alla cella e disse sottovoce: “Ascoltami, Michele. Le sirene sono qui intorno a giocare ed è già tardi. Sta per sorgere il sole e tu sai che il giorno esse riposano e la notte tendono reti ai marinai. Questa sera stessa, appena si saranno allontanate dal palazzo, io verrò a prenderti. Tu abbracciati a me fiducioso e lasciati guidare”. Passò quel giorno, giunse la sera, e il marinaio dubitava che la sua donna venisse a salvarlo. Ma ecco che ella si presentò raggiante di gioia, gli tese le braccia e insieme fluttuarono per ore e ore finché non sfiorarono la prua di un bastimento.
“Adesso domanda aiuto a quei naviganti”, gli suggerì la donna. Il marinaio gridò tre volte, dalla nave fu calata una scialuppa e venne issato a bordo nell’attimo in cui Filomena, compiuta la sua opera, risprofondava negli abissi.
Tornato a casa, Michele ricominciò a vivere le sue giornate con animo tutt’altro che sereno: era assalito dai rimpianti, si aggirava per le stanze senza requie e non c’era oggetto che non gli richiamasse alla memoria la sua donna e non c’era suono che non gli ricordasse le parole melodiose da lei sussurrate man mano che lo liberava dall’incantesimo.
E allora si accorse che non poteva più sfuggire a un obbligo: salvarla, o perdersi accanto a lei. Si addentrò in una foresta, sedette sotto un noce dove correva fama si radunassero le fate a danzare, e attese. D’un tratto scorse tra i rami una brutta vecchia che sorrideva.
“Chi sei tu?” gli domandò una vecchia. “Un infelice!”, esclamò il marinaio. “Perché infelice?”. Michele capi che la vecchia era una fata e avrebbe potuto aiutarlo, e con l’animo aperto alla speranza le narrò in ogni particolare i casi della sua vita. “Tu mi sembri un bravo giovane » disse infine la vecchia. “E io voglio farti riacquistare tua moglie. A un patto però”. “Accetto senza fiatare. Farò quello che vorrete”.
“E allora ascolta: a notte fonda dovrai tornare qui e deporre ai piedi di quest’albero un fiore che si trova solo nei palazzi delle sirene e che si chiama Il più bello...”.
“Ma come farò io, poveraccio, a prendere dal palazzo delle sirene un simile fiore?” si sgomentò il marinaio. “Eppure, se vuoi riacquistare tua moglie devi portare qui Il più bello”.
S’imbarcò sul suo legno e sciolse le vele al vento. Sopraggiunta la notte, calcolò che aveva navigato per oltre dieci leghe e che era tempo di chiamare la moglie. La chiamò, infatti, e subito la bellissima Filomena gli apparve tra le spume. “Amore mio” le disse “son venuto per salvarti”. “E come?” domandò la poverina. “Devi solo riuscire a prendere il fiore che chiamano Il più bello nel palazzo delle sirene”. “Oh, amore mio”, rispose tristemente, “chiedi l’impossibile. Il fiore che tu dici fu tolto alle fate e manda profumo celestiale laggiù nei nostri palazzi. Ma il giorno in cui tornasse sulla terra morirebbero cento sirene ed io sarei tra queste”. “Tu non morrai” insistette il marito “perché una fata di sicuro ti proteggerà. Perciò devi a qualunque costo procurare Il più bello”. “Vieni domani” disse Filomena.
L’indomani il marinaio attese all’àncora che la moglie emergesse, e appena quella ricomparve sulla cresta di un’onda le domandò: “Ebbene?”. “Ho riflettuto e ho indagato. Perché possa ottenere il fiore è necessario che tu compia un sacrificio”. “Quale?”. “Vendere ogni tuo avere e col denaro ricavato acquistare i più bei gioielli che si ammirino nelle principali vetrine del regno. Le sirene, attratte dal luccichìo, si allontanerebbero dal palazzo di cristallo e io potrei rapire il fiore”.
In pochi giorni vendette ogni suo avere e acquistò più rari gioielli del regno. Le sirene, abbagliate da quegli splendori, presero a seguire a frotte la barca, invocando chi un orecchino chi un pendaglio chi un bracciale chi un fermaglio... E intanto che Michele si adoprava a pararle si udì d’un tratto un tremendo boato sottomarino e l’acqua si levò a immense altezze. Le sirene compresero allora quel che era avvenuto, ma era ormai troppo tardi: a cavallo di una scopa si vide navigare per l’aria una vecchia fata che si portava Filomena, per consegnarla finalmente a suo marito, per sempre.
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI STIGLIANO
Nel 1697, dopo la morte di don Nicola Carafa de Guzman, lo Stato di Stigliano, per mancanza di eredi diretti fu devoluto alla corte, la quale, per 122.100 ducati, lo vendette a Donna Olinda Piccolomini. Alla vendita si fece precedere l’apprezzo dei feudi, che si legge estesamente in un voluminoso libro manoscritto. che ha per titolo "Compra di Stigliano".
Da detto manoscritto, riportato da Pennetti stralciamo la descrizione del castello, che già nel predetto anno non si trovava in buone condizioni, essendo stato molto danneggiato dal terremoto del 1694.
Sembra che il castello nel XIV sec. fosse stato restaurato da un famoso architetto locale, Jacopo da Stigliano, lo stesso che costruì la cattedrale di Pignola e che restaurò anche il castello di Uggiano presso Ferrandina.
Il manoscritto così recita: "A mano destra della porta principale di Stigliano vi è il castello, consistente in un arco di porta. senza porta di legname, dal quale si entra al cortile scoperto, dove si vedono le mura di diverse stanze dirute. A mano destra vi è una stanza coperta a tetti dove prima vi era la cappella; segue appresso un poco di atrio coperto a travi, però l’astrico è mezzo caduto, dal quale si entra ad una stanza a travi, accosto vi è l’altra stanza, e da essa s’entra ad un’altra stanza più piccola. E dal detto cortile sagliendo per alcune stanze dirute s’impania al suddetto coperto, che forma un poco di loggetta, con l’astrico sfondato, dalla quale s’entra ad una camera grande coverta a tetti…".
Di questo castello alcuni contadini raccontano che vi fossero numerose provviste per l’inverno. Un giorno di un anno imprecisato, la popolazione, che moriva di fame, prese d’assalto il castello per recuperare ogni tipo di cibo: solo che entrarono quando il signore del castello era a cena. La spettacolo fu di orrore e sgomento, quando videro che il signore si cibava di carne umana e le dispense erano ricolme di sacchi imbottiti di ossa umane.
Quasi all’istante il signore del castello venne ucciso e fu allora che si scoprì il perché delle sparizioni notturne di parecchi concittadini. Ancora oggi, infatti, gli abitanti di Stigliano raccomandano i giovani di stare attenti quando escono di notte.
La città di Stigliano era circondata da una fortificazione. In un affresco del 1709 erano dipinte le torri che circondavano la città di Stigliano, che ovviamente vennero abbattute quando con un Privilegio Giovanni Orsini del Balzo donava il suo castello ai cittadini.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI TORRE DI MARE A METAPONTO
Sulla foce del Basento, luogo dove nell’antichità si svilupparono le grandi civiltà che gravitavano nel Metapontino, vi era una città che documenti del 1222 denominavano "Città della Santa Trinità, che oggi si chiama Torre di Mare, nominata invece, in età sveva, come Torre Maggiore.
Il centro scomparve come intorno alla metà del XVII sec., ma di esso rimangono alcune memorie.
Si racconta che un feudatario del luogo si fosse innamorato di una bellissima popolana dal semplice nome di Maria. Egli entrò di forza nella casa dei suoi genitori, prelevò la fanciulla e si dileguò nella notte, portandosi la popolana nel bosco.
Violentò la fanciulla per tutta la notte e l’abbandonò nel bosco dicendole: "Tornerò presto a prenderti, quando ne avrò voglia".
I genitori, preoccupati del non ritorno, pensarono che il signore di Torre di Mare fosse innamorato e che avesse portato la loro bambina nel castello; andarono in cerca della fanciulla, ma niente. Essa era proprio scomparsa.
Dopo giorni e giorni fu trovata morta nel bosco di Metaponto, tutta mangiucchiata dagli animali.
Quello spettacolo rimase così vivo nel piccolo fratellino di Maria, che questi decise che un giorno si sarebbe vendicato.
Venne il giorno della maggiore età, e vide che nel frattempo era cresciuta anche la figlia del feudatario di Torre. Con degli amici decise di rapirla e di portarla nel bosco per usarle violenza. "Ti prego, non farmi del male!" –disse la principessina– o mio padre ti ucciderà". "E che m’importa?" –esclamò lo spavaldo.
Anche quella fanciulla fu ammazzata, e si dice che dentro il castello di Torre di Mare fosse appesa una testa di un popolano cui era stata uccisa la sorella.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI TORRE SPAGNOLA
Presso la piccola fortezza di Torre Spagnola c’era il massaro la cui figliola splendeva di tanta bellezza che pareva avesse raggi di sole per i capelli, tanto era bionda e luminosa, rispetto agli altri della famiglia di origine spagnola ed araba. La fanciulla si chiamava Agata.
Un giovane ragazzo, altrettanto bello e per giunta valoroso, l'amava pazzamente ed era amato dalla giovinetta.
Questi, era l'ultimo dei figli del contadino che lavorava per il padrone che, che essendo cattivo ed ingiusto, gli aveva ordinato di andare via dal castello.
La fanciulla era stata promessa al principe Giovanni, il quale ignorava i sentimenti di Agata e del giovane.
Le nozze furono celebrate e il figlio del contadino si sentiva morire dal dolore. Si rinchiuse nella sua piccola stanza, e si abbandonò alla più cupa disperazione. Mentre con la testa stretta tra le mani meditava sul proprio destino, udì una flebile voce che chiedeva: “Perché piangi?”. Si alzò spaventato. “Non ti preoccupare, sono un folletto dalla spirito benefico, non preoccuparti ti dico. Raccontami le tue pene e non ti lascerò triste”.
Il folletto ascoltò senza interrompere e si allontanò da lui dicendo: “Non dire ad alcuno della mia visita, hai capito? Io farò che il tuo desidero si avveri”.
Intanto, nel palazzo le feste erano finite a tarda notte e gli sposi si ritirarono nella camera nuziale, dove c’era un baldacchino di damasco sorretto da colonne d'oro tempestate di gemme che proteggeva in dolce penombra il letto. La sposa, liberandosi lentamente del ricco vestito, si rattristava e non parlava. Lo sposo, credendo che fosse il pudore delle vergini non si preoccupava, ma anzi era contento.
Appena però essi sì furono coricati; il folletto saltò sul seno di Agata e questa divenne rossa, poi nerissima. Spaventato, Giovanni chiamò i medici ed i parenti.
Nei giorni che passarono la povera Agata deperì sempre più ed allora il vecchio genitore, inorridito dalla sventura toccata alla, figliuola, convocò i primi scienziati per consultarli sull'oscuro male della fanciulla. Gli scienziati dettero un verdetto: “Il male di Agata è il marito!”.
Il massaro ingegnò uno stratagemma: chiamò i suoi servi, fece rapire Giovanni e lo rinchiuse nelle grotte della Torre Spagnola, dove miseramente morì.
A distanza di un anno circa, Agata guarì e poté sposarsi con il ragazzo figlio di un servo.
Si dice che ancora oggi è seppellito il corpo di Giovanni in una segreta della masseria.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI TREMITI DI SOPRA
A sud di Matera, tra Ferrandina e Pisticci, c’era un Re che aveva tre figli. Volevano prendere moglie tutti e tre, ma lui non sapeva dove andare a trovare tre fidanzate degne dei suoi ragazzi. Un bel giorno li chiamò e disse: “Ecco queste tre palle d’oro: andate in cima al monte e fatele rotolare a valle. Dove queste tre palle si fermeranno, là sceglierete la donna che dovrete sposare”.
I figli del Re salirono sul monte e, come il padre aveva comandato, ognuno buttò giù la sua palla. Ecco allora che la palla del più grande entrò dentro la bottega di una fornaia. Quella del mezzano entrò dentro la bottega di una macellaia. Quella del più piccolo, che si chiamava Augusto, finì dentro un fosso.
I fratelli più grandi scesero subito nei luoghi dove erano andate le palle e dissero alle ragazze che c’erano che le avrebbero sposate. Fatto questo, cominciarono a prendere in giro il fratello più piccolo dicendogli di andarsi a cercare moglie dentro al fosso. Augusto fece proprio così. Andò al fosso e cominciò a pensare: “Chi chiamo, se qua non c e nessuno? Adesso chiamo una ranocchia e buona notte!”. Infatti cominciò a chiamare: “Rana, rana!”. Dal fondo del fosso si sentì rispondere: “Chi è che mi chiama?” “Augusto che poco t’ama”. “M’amerai quando bella mi vedrai”. “Che vuoi da me?”, gli domandò la ranocchia. E lui raccontò che il padre, dovendo ammogliare i tre figli, aveva dato loro tre palle.., e la sua era andata a finire dentro quel fosso. “Dunque”, concluse, “sono venuto a dirti che sei la mia sposa!”
“Va bene, quando arriverà il momento verrai a prendermi”. Detto fatto, Augusto tornò a casa dal padre. Il padre quando seppe che tutti e tre avevano trovato moglie, disse: “Benissimo! Adesso vedremo quale delle tre sarà la Regina!” E mise tutte e tre alla prova consegnando ai figli una bracciata di lino e ordinò di portarlo alle loro donne, perché colei che sarebbe riuscita a ricavarne il filo più sottile sarebbe divenuta Regina. Ognuno si prese la sua parte di lino: i più grandi lo portarono alle loro ragazze e si raccomandarono di fare il filo più sottile possibile; il più piccolo andò al fosso e chiamò. “Rana, rana!” “Chi è che mi chiama?” “Augusto che poco t’ama”. “M’amerai quando bella mi vedrai”. “Che vuoi da me?”, gli domandò la ranocchia. E lui: “Ho portato del lino da filare! Lo lascio qui. Tu cerca di fare il filo più sottile possibile, perché mio padre ha detto che quella che lo farà meglio sarà la nuova Regina”.
La ranocchia prese con sé il lino, ed Augusto tutto malinconico se ne andò a casa. Otto giorni dopo il padre convocò i figli e ordinò di andare a ritirare il filo dalle loro donne. Augusto va al fosso e chiama: “Rana, rana!” “Chi è che mi chiama?” “Augusto che poco t’ama”. “M’amerai quando bella mi vedrai”. “Che vuoi da me?”, gli domandò la ranocchia. E lui: “Hai finito di filare il lino?”. Lei: “Sì, cala un canestro, che te lo mando su!” Augusto lasciò andare giù il canestro, prese il filo e tornò dal padre. Il padre si mette là a osservare tutti e tre i gomitoli di filo, poi dice: “Quello della fornaia è bello, quello della macellaia è meglio, ma quello della ranocchia è il più bello di tutti. Dunque la ranocchia sarà la Regina”. I fratelli non ci volevano credere: “Ma papà! Che dite! Come è possibile che una ranocchia sia la Regina?”. Allora il padre disse: “Non facciamo troppe chiacchiere! Ecco qua, riprendetevi ognuno il vostro gomitolo di filo, riportatelo alle vostre ragazze, fateglielo tessere... e quella che farà la tela più bella sarà la Regina”. E così fu fatto. Augusto, come al solito, si recò al fosso, dove chiamò: “Rana, rana!”. “Chi è che mi chiama?”.
“Enrichetto che poco t’ama”. “M’amerai quando bella mi vedrai”.
Mandò giù il filo dicendole di farci una tela: otto giorni dopo sarebbe passato a prenderla. Passarono otto giorni, e tutti e tre i figli del Re andarono a ritirare le tele e le consegnarono al padre. Il padre si mette lì a osservare le tele e dice: “Ah certo... la tela della fornaia è bella, quella della macellaia è meglio, ma quella della ranocchia è la migliore di tutte. Dunque la ranocchia sarà la Regina”. Ma i fratelli di Augusto non potevano rassegnarsi: “Ma papà! Che fate? Le ragazze nostre sono tanto belle... e voi per Regina scegliete una ranocchia?”.
I fratelli più grandi andarono a prendere le loro spose a cuor leggero perché erano due belle ragazzone. Invece il povero Augusto, si disperava. Salì sulla carrozza e andò giù al fosso. Dice: “Rana, rana!”. “Chi è che mi chiama?”. “Augusto che poco t’ama”. “M’amerai quando bella mi vedrai”. Lui le disse: “Sbrigati, sali in carrozza! Dobbiamo andare a sposarci”. E la ranocchia disse: “Eccomi qua!”. E con un salto fu subito in carrozza. I servitori, quando la videro, ridevano tutti sotto i baffi! Intanto Augusto, piegato dentro la carrozza, piangeva.
Quando la ranocchia arrivò alle camere, non volle nessuna cameriera che l’aiutasse a vestirsi, tranne il suo Augusto. “Bene, la ranocchia sono io!”, esclamò lei.
“Come? Voi! Questa non me la bevo davvero!”
Allora quella:
“Sì, sono proprio io! Ero vittima di una fattura. Dovevo restare ranocchia fintanto che non avessi trovato un giovane che mi avesse sposato prima di sapere che ero bella”.
Augusto, contento come un matto, la prese sotto braccio, la portò nella sala dove c’erano le altre spose e disse: “Signori miei, vi presento la sposa
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI TURSI
Il grande centro abitato di Tursi pare fosse stato abitato e costruito nel IV e V sec. dai Goti che, penetrando nell’Italia semidesertica, colonizzarono estese terre un tempo controllate dalla fattorie romane tardoantiche, che a loro volta vennero via via abbandonate.
Si racconta che il primo nucleo della città prende il nome di "Rabatana" o "Arabatana" perché un gruppo di Saraceni volle erigere una torre, dove poi avrebbe dimorato il loto capo, un certo Tursico.
Di qui gli Arabi, amici di quelli che si insediarono su Pietrapertosa, Tricarico e Laurenzana, si applicavano nelle scorrerie dei dintorni, mettendo a ferro e fuoco gli insediamenti circostanti.
Una tradizione vuole che questo Tursico, stanco ed ormai vecchio delle scorrerie, decise di dar in sposa la propria figlia al signore di un altro villaggio vicino, quello di Santa Maria d’Anglona.
Tutto fu preparato per le nozze, anche perché la figlia di Tursico era bellissima con capelli ed occhi neri, e quindi molto ambita dai piccoli musulmani del tempo che allora abitavano in Basilicata; ma avvenne un fatto gravissimo.
La piccola fanciulla, che doveva possedere poco meno di dodici anni, si era invaghita di un suo schiavo. Il padre se ne accorse, e decise di uccidere lo schiavo gettandolo da una rupe al di sotto della Arabatana.
Nel mentre si preparavano le nozze, dopo la cerimonia di investitura del signore di Santa Maria d’Anglona, la piccola fanciulla non fu più trovata accanto al suo sposo, ma impiccata nella casa fortificata di Tursi.
Il grande Tursico, conscio della sua arroganza e colmo di dolore per la morte della figlia, decise allora di convertirsi al cristianesimo e di liberare completamente la città ed il territorio dalla scorrerie arabe.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI UGGIANO PRESSO FERRANDINA
Qualcuno ha ritenuto che questo castello è una specie di roccaforte per la posizione, l’ampiezza delle mura di cinta, l’esistenza di una chiesa e la mancanza di resti di edifici pubblici fra le macerie. In realtà indagini degli ultimi anno lasciano affermare il contrario, e che il castello, con l’abitato, era indipendente dal centro vicino di Ferrazzano, cioè Ferrandina.
Non sappiamo nulla del fondatore della rocca né sappiamo molto di coloro che per primi ne ebbero la signoria; tuttavia, bisogna farne risalire le origini ai primi anni del X sec.
La prima notizia relativa ad Uggiano è del 1023 e 1029, quando Lupo Protospata descrive che due musulmani, Rajca e Safar assediarono il castello Oggiano e si rappacificarono con gli stessi abitanti.
Viene documentato, così, il valore strategico dell’insediamento che il 6 febbraio del 1068 permette a Roberto il Guiscardo di rintanarvisi, non avendo egli ancora preso Montepeloso (Irsina), come riporta lo stesso Romualdo Salernitano. Nel Catalogus Baronum, ovvero l’elenco normanno dei feudatari e suffeudatari tenuti al servitium feudale, si evince che un Rogerius de Ogiano possedeva il feudo di Sant’Arcangelo offrendo un soldato o, in aggiunta, due soldati, per una rendita di 20-40 once d’oro.
Null’altro si conosce dell’insediamento, che dunque doveva possedere già alcune fortificazioni.
Nel 1269 il feudo viene donato a Pietro de Bellomonte, conte di Montescaglioso. Di ciò non abbiamo una fonte autentica, ma nel 1275 il feudo è nelle mani di Giovanni di Monteforte, genero di Pietro. In quest’ultimo documento si parla di "soldati e civili", che la Cancelleria Angioina degli anni 1276-1277 registra in una popolazione di 400 fuochi, tassata per 100 once, 29 tarì ed 8 grana.
Nel 1280 anche l’insediamento di Uggiano deve provvedere alla riparazione del castello di Melfi. Il feudo di Andria, insieme ad Uggiano, passò ad Azzo d’Este nel 1308, raccolti in dote dalla moglie Beatrice, ultima figlia di Carlo II d’Angiò, la quale rmasta vedova risposò in seconde nozze con Bertrando del Balzo, cui portò questa dote che si unì alla contea di Avellino e di Montescaglioso.
Alla guida del feudo successe il figlio Francesco I, poi il nipote Guglielmo, indi il pronipote Francesco II, che andò sposo a Sancia, figlia di Tristano di Chiaromonte e di Caterina Orsini Del Balzo. A Franceco II successe Pirro del Balzo. Il 20 dicembre 1430 a Napoli il re Ferdinando I ordina un’inchiesta per reintregrare Pirro del Balzo principe di Altamura e duca di Andria, nel possesso dei feudi di Bisceglie, Montepeloso, Acquaviva, Torre di Mare, Pomarico, Tolve, grottole, Altogiovanni, Monteserico, San Gervasio, Mottola, Uggiano, Sarfi e Tressuti. Nel 1485 Pirro del Balzo viene privato da Ferdinando I di questi beni, per la ribellione da lui capeggiata durante la cosiddetta "congiura dei baroni". Ne è investito il genero Federico d’Aragona, che nel 1492, secondo una pura leggenda, dopo un violento terremoto, fonda con i profughi uggianesi Ferrandina.
Di notevole pregio è, infine, la scritta posta come cantonale destro della facciata principale della chiesa
HOC OPUS FECIT MAGI
STER JACOPUS TRIFOGIA
NIS DE ASTILIANO ANNO
MILLESIMO CCCL
L’iscrizione è realizzata su un concio che male si imposta sull’estradosso dell’arco acuto, per cui è a questo Jacopo di Trifoggio (casale presso Pietrapertosa) cui si devono la serie di tamponamenti, i rifacimenti strutturali e le nuove destinazioni d’uso del castello.
(di P. Rescio)
IL CASTELLO DI VENUSIO
Nel casale di Venusio, presso Matera, c’era un ragazzo terribilmente svogliato che una mattina disse al padre: “Non voglio più andare a scuola, preferisco fare il calzolaio”. Il padre acconsentì. Dopo poco tempo che aveva cominciato quel mestiere si punse la mano con la subbia e si lamentò col genitore: “Padre mio, non voglio più fare il calzolaio”. “E he vorresti fare?” chiese il bravuomo.
“Voglio imparare l’arte del sarto”. “Eva bene, farai il sarto”, rispose quello con mitezza.
Un giorno, mentre il ragazzo cuciva a macchina gli accadde d’infilare il dito sotto l’ago e in seguito a ciò pianse e giurò che non voleva più fare il sarto. “E che intenderesti fare?” volle sapere il padre. “Il falegname”. “E fai pure l’arte di San Giuseppe” approvò il vecchio.
Nel corso del nuovo mestiere, una sera d’inverno, mentre cercava di modellare un’asta di legno, si ferì a sangue il mignolo. Tornato a casa disse al padre: “Non mi giudicare male, ma io non voglio morire per il lavoro”. E quegli replicò: “Se non lavori non mangi”. E il figlio: “E io non voglio né mangiare né lavorare”. “Sei proprio sicuro? Vedremo come farai” accondiscese bonario il genitore.
Passò il primo giorno, passò il secondo, il terzo, il quarto e alla fine, sdilinquito dalla fame, il ragazzo si arrese: “Padre mio, voglio mangiare e lavorare”. “E allora, prendi la vanga e seguimi in campagna”, rispose il vecchio mettendo nella bisaccia pane, pecorino e olive.
Il ragazzo vangò dall’alba al mezzodì senza soste, poi si rinfrescò all’acqua del pozzo come aveva visto fare al vecchio, sedette accanto a lui all’ombra di un carrubo e addentò la colazione: “Quanto è saporito pane e Cacio, caro papà. Oggi ho capito quanto è importante il lavoro e quanto è bello mangiare dopo la fatica!”
(di: P. Rescio)
IL CASTELLO DI GROTTOLE
Una notizia, non ancora verificata, narra che il castello di Grottole fu fatto costruire nell'851 da Sichinulfo, un duca longobardo principe di Salerno. Fatto edificare con materiale calcareo e difeso da una serie di merli e feritoie, per i numerosi arcieri, difendeva la città di Grottole, che anticamente, come si legge nei Registri Angioini, era cintata di mura con vallo e ponte levatoio.
Probabilmente il duca Sichinulfo aveva voluto questa fortezza soprattutto per difendere i territori venuti in suo possesso.
Oggi non rimane che un colossale torrione, con una sola finestra spalancata verso il paese e, se la si osserva con attenzione nelle notti di luna e nei mesi da aprile a giugno, è facile vedervi una figura di una donna, Abufina, la più bella e la più sfortunata ragazza mai vissuta a Grottole. E’ la storia di un grande amore che inizia così. Un giorno Abufina, bellissima dama, ricamava seduta accanto alla finestra del torrione: ella possedeva la pelle bianca come latte e pensava al suo amore, Selepino, che combatteva in terra lontana.
All’improvviso, mentre era intenta ai lavori domestici, avvertì lo scalpitio di un cavallo; era un messaggero che portava un plico che così recitava: “Vieni, Abufina, vieni da me; io che uccido i nemici, me l'amore mi uccide; vieni, Abufina, vieni da me: insieme con te al castello di Grottole sol tornerò; fà presto, fà presto...”. E Abufina partì, ma il bianco cavallo, distratto dalle pietre luccicanti e scivolose del fiume Basento, s’impennò, e la bella fanciulla fu travolta nei vortici del fiume.
La leggenda narra che il signore del castello, per onorare la memoria di una fanciulla, Abufina, morta per andare incontro al suo amore vi collocò una lapide (di cui era possibile vedere fino agli inizi del secolo scorso dei frammenti) con una scritta: “Ad Abufina la bella, che corse, cui fu dolce morire d'amore; questa torre che fu tua dimora, parli sempre alle genti di te. Ogni amante ti porga un saluto, e si stringa al suo cuore l'amata...”.
Ancora oggi il Basento, pentitosi per aver distratto il cavallo bianco, pare che mormori ogni tanto il nome di Abufina.
(di P. Rescio)
LA TORRE DI S. MAURO FORTE
Quella che viene chiamata torre rimane ancor oggi ben salda e sembra ergersi a difesa della Cattedrale.
Poiché nel 1060 troviamo per la prima volta nominato S. Mauro, possiamo far risalire la costruzione della torre ai primi del mille; lo stile, ad ogni modo, non la rivela proprio normanna, quanto angioina. Dovette avere accanto a sè il relativo castello, che, insieme al monastero di S. Maria, rientrava nell’urbanistica della città.
Si racconta che in questa torre avvenissero torture contro coloro che non risolvevano i debiti. Infatti alcuni riconducono la vicinanza della torre con la Cattedrale, proprio perché chi riusciva a sfuggire alle torture si rifugiava in chiesa per non varcare la soglia dell’uscita mai più, poiché prendeva i voti.
Molti, però, affermano che i preti continuassero ad avere figli e parenti.
Dopo l’avvento degli Angioni S. Mauro Forte passò da uno ad un altro signore, ma il castello non ebbe mai periodi di splendore, essendo i suoi padroni feudatari di altre terre, nelle quali preferivano vivere a Montescaglioso.
IL CASTELLO DI TRICARICO
L’alta torre cilindrica del centro storico di Tricarico si eleva a più di 27 metri ed tutta coronata di archetti pensili e circondata alla base da scalette adatte ad una pronta difesa e ad un isolamento più pronto e più rapido. Essa doveva far parte di un complesso fortificato vero e proprio.
Questa torre, la prima che si presenta allo sguardo di chi viene in Tricarico, si staglia su di una roccia isolata.
Circa le origini qualcuno la vuole costruita dai Tarantini; altri –ed è l’opinione più accreditata– l’attribuiscono a Roberto il Guiscardo, che, fin dal suo ingresso in Tricarico (dopo la vittoria sui Bizantini che l’occupavano) realizzò molte opere pubbliche.
Probabilmente il Guiscardo trovò già un complesso di fortificazioni ed un castello costruito dai Musulmani: infatti il castello era famoso per i suoi magici giardini con fiori di ogni specie, alberi da frutta e piscine con zampilli d’acqua.
Verso il 980, infatti, vennero in Tricarico i Saraceni; entrarono dalla parte bassa del paese, che non era difesa dalle mura di cinta, come gli altri rioni. Poichè era loro intenzione fermarsi, pensarono subito a costruire, in quei luoghi dove mancava, mura e fortilizi.
Iniziarono così a sorgere quelle che ancora oggi sono chiamate porta e torre "Rabatana".
Si dice che per la costruzione furono costretti a lavorare i cittadini stessi di Tricarico, i quali erano trattati del tutto come schiavi; si racconta, inoltre, che durante i lavori i Saraceni, che si erano già bene annidati nel castello di Pietrapertosa, assalivano le popolazioni dei centri vicini, catturavano gli umini validi e ne assegnavano trenta al giorno per la costruzione delle nuova mura, mentre le donne venivano violentate dopo grandi e fastosi pranzi; ogni sera, quindi, Tricarico si presentava, ai pellegrini diretti a Matera e Bari, come luogo di perdizione pagano.
Una leggenda racconta che lì visse, sognò e mori la bionda Mabiha, che, uscita dalla turrita Ceccano, era venuta, intorno al 1157, sposa al conte Giacomo Sanseverino.
Dalla valle del Sacco, con un seguito di cavalieri e di armati, per quindici giorni cavalcò da San Germano (Montecassino) a Napoli e a Potenza, e seguendo l’Appia, per il passo appenninico del Marmo, era giunta a Tricarico.
Qui ascoltava le canzoni degli zingari e dei viandanti, che ricordavano la patria lontana. Né tornò più alla sua Ceccano tutta assorta nei pensieri del marito ghibellino, morto in una imprecisata battaglia contro i Bizantini sul Basento.
(di P. Rescio)
Video: Castelli della Basilicata
Video: Castello di Lagopesole
Castello di Lagopesole: il Corteo Storico
Video: Melfi, Citta' di Federico II di Svevia
|